Contro Severino…27 anni dopo. Le obiezioni di M. Cavaioni e le mie risposte
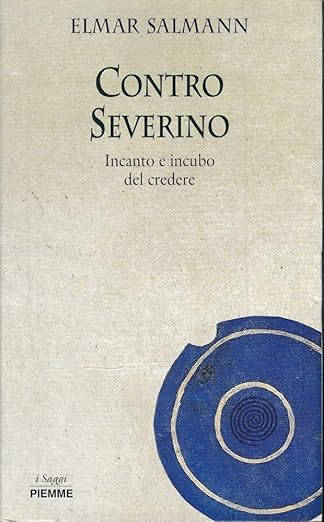
Con piacere e interesse ho letto le obiezioni che M. Cavaioni muove ad alcune mie affermazioni, contenute nel libro di E. Salmann, Contro Severino. Incanto e incubo del credere del 1996. Riprendo qui le sue considerazioni e aggiungo, a seguire, la mia breve risposta. Mi sembra un modo singolare di scoprire come un libro di quasi 30 anni fa abbia continuato a camminare e a parlare, anche a dispetto del suo titolo “forzato” (redazionalmente, non da parte degli autori). Bisogna ricordare, infatti, che il libro è stato scritto come risposta non all’intera e maestosa produzione di Severino, ma solo a “Pensieri sul cristianesimo” (Rizzoli, 1995) dove Severino, in modo piuttosto approssimativo, ricostruiva la dottrina cristiana attraverso una riduzioni semplicistica rispetto al suo assunto teoricofondamentale. In questo suo intento sproporzionato e pesantemente riduzionista era giusto delimitarlo e smascherarlo, per quanto potessero farlo allora due teologi e filosofi certamente non appartenenti alla scuola di Severino né iniziati ai suoi dogmi. Se gli autori non hanno saputo fare “neppure il solletico” al sistema severiniano, certamente Severino nel suo libro non ha neppure lambito marginalmente il senso del mistero cristiano, appiattendo anche quella tradizione, di cui ripeteva assunti tratti da un catechismo meno che elementare, a mera “fede nel divenire”. Presento qui le obiezioni di M. Cavaioni, seguite dalle mie risposte.
Obiezioni (di M. Cavaioni)
In un volume intitolato “Contro Severino”, Piemme, 1996 (ma che, a mio parere, non riguarda se non pretestuosamente Severino, a cui non fa nemmeno il solletico) firmato con Elmar Salmann, Andrea Grillo a p. 166 – riferendosi a Severino (a cui obietta una forma di psicologico sospetto per ogni forma di dualità, quando, invece, a me pare che l’intera “struttura originaria” severiniana sia la pretesa di tener ferma proprio una dualità impossibile), ma questo non è qui importante – osserva che:
«La mediazione presuppone due termini da mediare e quindi che vi sia differenza: dove trionfa solo una identità, l’idea stessa di mediazione è una bestemmia.»
A parte il fatto che se “una” identità è la “sola” ad essere, non potrà dirsi “una identità” (dire “una” è, infatti, dire “più d’una”: ma “più d’una” significa che ciascuna di esse sarà una identità che è altrettanto differenza, dunque tali da non riuscire ad essere mai veramente identità, appunto perché la differenza entra a costituirle, dunque a dissolverle come “identità”) non è, dicevo, “una” identità, bensì “la” identità, se appunto vi è solo essa.
La quale, quindi, non avendo alterità non potrà essere determinata e, pertanto, sarà l’assoluto stesso, il quale è, in verità, l’unica identità e del quale, in effetti, è insensato parlare di mediazione (tanto estrinseca quanto intrinseca).
Su questo si conviene.
Nondimeno, non mi sembra che sia questo ciò che dice Severino, il quale parla appunto di “identità” al plurale ovvero parla (e non dimostra, ma solo mostra) della presunta originarietà di una strutturazione (differenziazione) intrinseca dell’identico, dell’essere: il che equivale ad una contraddittoria “unità molteplice”, “unità duale”: “unità non-unità” – ma, ripeto, non è questo ora il punto.
* * *
Il punto è un altro.
Cosa vuol dire, chiederei al Prof. Andrea Grillo , “la mediazione presuppone i due termini da mediare”?
Se essi sono presupposti alla ( = posti prima della) mediazione, essi saranno immediati. Bene, chiedo: come sorgerebbe la mediazione dalla immediatezza? come sorge il movimento da ciò che si postula come statico?
In quanto essenzialmente statici (immediati), rispetto ad essi il movimento (mediazione) sopraggiunge come estrinseco, cioè non li riguarderà essenzialmente mai.
In realtà, già parlare di “immediati” al plurale è un controsenso, una contraddizione.
In quanto, infatti, si parli di “due” si è già in piena mediazione (che è la stessa relazione o distinzione); altrimenti, si tratterebbe di “due” unici ovvero, più propriamente, della reiterazione, pratico-operativa e non teoretica (ché teoreticamente non ha alcuna ragion d’essere) dell’unico.
Ebbene, in quanto “due”, essi sono già distinti. Ma saranno concretamente, non astrattamente, distinti – lo insegna Gentile – solo in virtù della distinzione (dell’atto di distinguersi).
Sicché, presupporre i distinti all’atto in ragione del quale essi sono tali (appunto “distinti”: participio passato del verbo ossia dell’atto del distinguersi) è pretendere che siano già distinti senza esserlo ancora, cioè mai.
Equivale a presupporli a se stessi.
E, difatti, gli immediati (al plurale) sono lo stesso presupposto: la pretesa di porsi prima di porsi effettivamente (porsi che è mediazione, come tale è il non esserci mai degli immediati, se mediazione è negazione in atto della pretesa immediatezza dei dati, dei termini).
Più chiaramente: la mediazione è, in realtà, intrinseca ai (presunti) immediati, i quali pertanto sono tali solo negandosi (negando la loro presunta, solo presupposta, ma inessente immediatezza).
Con questa conclusione, che è già stata detta ben più autorevolmente, a voler e saper leggere le opere fondamentali della teoresi italiana: l’immediato “è” la sua negazione (mediazione), cioè il suo originario mediarsi o risolversi nell’atto del mediarsi (che è nichilismo solo per chi crede alla immediatezza dell’essere dei dati, dei fatti, impropriamente detti “essenti”).
Questo a dispetto dell’apparenza empirica (della illogicità del piano fenomenologico) che presenta per l’appunto dati immediati, accolti come immediati solo se non si pensa
Risposte (di Andrea Grillo)
Il punto di resistenza dell’immediato, sia prima, sia dopo, rispetto alla mediazione, deriva dal dissenso rispetto al pensiero centrale nel sistema di Severino: ossia la univocità dell’essere. Perché la struttura originaria della necessità non mi sembra altro che un sofisma, che pretende di svelare una contraddizione interna all’intera cultura, non salvando nessuno, nemmeno Parmenide. Il garbo ostinato e la forza argomentativa con cui Severino ha ripetuto per quasi 70 anni questa tesi, in mille variazioni del medesimo, non gli ha mai impedito di restare nobilmente superiore ad ogni critica, con una rara signorilità. La sua, d’altra parte, non è una conoscenza, ma una fede, come tale indiscutibile: è un dogma che pretende di smascherare il nichilismo e la contraddizione in ogni pretesa di giustificare o di ammettere il divenire. Se capisco bene M. Cavaioni (ma ho letto solo questa sua breve pagina), nella sua distanza da E. Severino, egli sostiene la impossibilità di ammettere un “dato” se non è pensato e mediato. Non esiste pensiero recettivo, ma spontaneità originaria di essere e pensiero. Perciò un “dato”, negando il pensiero, crea una alterità insostenibile e contraddittoria.
Il punto che mi convince a difendere la correlazione tra la mediazione e la immediatezza iniziale e finale – ossia la funzione “mediana” dell’atto del mediare tra due estremi, in cui da una immediatezza si produce una nuova immediatezza – viene però da una accezione non solo filosofica, ma anche teologica e giuridica del mediare. La funzione del “mediatore”, dei “media salutis”, del “contratto di mediazione” o della “mediazione penale” consiste, precisamente, nel mettere in contatto due estremi, che da una immediatezza giungono ad una nuova e diversa immediatezza. Che cosa sono nell’uomo “parola e mano” (non solo pensiero, ma anche azione e operazione) se non mediazioni che permettono una nuova immediatezza? Qui, evidentemente, non posso utilizzare “mediazione” soltanto nella accezione filosofica, che diventa perciò una accezione troppo unilaterale, anche se articolata (come è per lo più anche tra i filosofi, ma non in Severino). Non a caso deriva da una tendenza all’attualismo, che toglie ogni fenomeno e risolve ogni immediato in una mediazione che occupa l’intero orizzonte e toglie il respiro. Non diversa da questa ispirazione è la posizione del pensiero di Severino e della sua pretesa senza misura di negare ogni divenire. La contraddizione in cui cade Severino mi sembra patente: se l’essere e ogni essente è eterno, ogni divenire è mera apparenza. Ma se la apparenza, che prima appariva, ora non appare più, almeno per l’apparire il divenire risulta necessario. Un esito “mistico” e direi quasi “sommosacerdotale” del pensiero di Severino – la affermazione della eternità di ogni essente – costituisce una sorta di assunto dogmatico, una dimostrazione senza alcuna evidenza, se non controfattuale. E nella misura in cui viene definita la “credenza” nel divenire come una “follia”, la difesa di una relazione tra immediato e un mediato non irreversibile costituisce la risposta alla difficoltà fondamentale: pensiero ed essere non sono né contraddittori, né univoci. Sono piuttosto forme della immediatezza e della mediazione. L’essere è immediatezza del pensiero, il pensiero è mediazione dell’essere. Ma anche l’essere è mediazione del pensiero e il pensiero immediatezza dell’essere. La dogmatica severiniana è fondata su pochi assunti fondamentali, che girano sempre su se stessi e a sé riducono tutti i fenomeni. La ammirazione per un sistema tanto raffinato non può nascondere la radicale negazione di ogni spazio sia per la rivelazione sia per la fede, sostituite da una visione fondata su una credenza che si immunizza da ogni esperienza, riducendola a mera apparenza. Ogni pretesa di uscire da questo dogma è bollata come follia. Il massimo del garbo si sposa perciò con il massimo della incomunicabilità e con la pretesa di confutare come “infondata” l’intera storia della cultura, d’oriente come di occidente. La correlazione tra mediazione e immediatezza vuole resistere a questo riduzionismo monista, che eternizza ogni essente, ma non spiega più alcun fenomeno. Poiché la mediazione, come l’essere, “si dice in molti modi”, la pretesa di ridurre tutto ad una unica accezione dell’essere, distorce tanto l’essere quanto la mediazione. La univocità dell’essere è la carenza centrale del pensiero di Severino, così come la univocità della mediazione, che passa facilmente dal tutto al nulla. Una mediazione che non sta “in medio” nega se stessa. Forse non è assenza di pensiero il fatto di partire da e di arrivare ad un immediato, ma soltanto la traccia della resistenza ad un pensiero univoco, che dice l’essere in un modo solo e perciò è costretto ad infiniti giochi di prestigio logici per giustificare come quella evidenza logica non appaia né nella vita di un uomo né in quella di una foglia. L’eternità di ogni uomo, come la eternità di ogni foglia non si lasciano dimostrare solo logicamente. La immediatezza del vivere e del morire, “ciò che non muore e ciò che può morire” non sono “fedi” cristiane, dantesche o semplicemente umane, ma sono “dati” ed evidenze comuni, che chiedono una mediazione diversa da un principio logico.


























 Area personale
Area personale











