La traduzione /tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam”
Al di fuori degli ambienti strettamente “liturgici” sfugge a molti un problema che è sorto, all’interno della tradizione cattolica, proprio all’inizio del nuovo millennio. Nel 2001, infatti, la Congregazione per il Culto divino ha emanato la V Istruzione per la attuazione della Riforma Liturgica, che porta il titolo “Liturgiam Authenticam”. Questa istruzione si occupa essenzialmente di una questione: ossia di stabilire i “criteri” per una traduzione dal latino alle diverse lingue parlate nella Chiesa cattolica.
Per capire meglio, facciamo una breve storia del dibattito e della prassi intorno al “tradurre ecclesiale”
1. Una breve storia
Subito dopo la approvazione del testo di Sacrosanctum Concilium, per attuare i nn. 36 e seguenti, dedicati propriamente alla “lingua liturgica”, si aprì un grande cantiere, per consentire il grande lavoro che avrebbe dovuto dare, a tutta la Chiesa, nelle sue diverse espressioni linguistiche, un grande numero di nuove traduzioni, da usare per la celebrazione di tutti i sacramenti e della liturgia.
Era evidente che la comunione doveva pensarsi, da lì in poi, come garantita dal tradurre, non da una lingua illusoriamente comune. Ciò che è “comune” non è il latino, ma la possibilità di tradurre da lingua a lingua. Questo è il “novum” su cui, dal 1963, si comincia a riflettere ufficialmente.
Il grande testo, che costituì il primo punto di sintesi, fu Comme le prévoit (1969), scaturito dal confronto internazionale e da Congressi dedicati a creare una serie di criteri e di esemplificazioni, utili per il lavoro di differenziazione e di uniformazione delle diverse traduzioni. Nel 2001, la V Istruzione per la attuazione della Riforma Liturgica, a più di trent’anni da quel testo, ritorna sul medesimo tema, ma con una diversa prospettiva, con restrizioni assai forti nel concepire il rapporto tra lingua latina e lingue vernacole. Se analizziamo brevemente il cuore di questi due diversi documenti, essi attestano non semplicemente diverse opzioni teoriche nell’ambito dei criteri di traduzione, ma una coscienza profondamente diversa della “sfida” che il tradurre rappresenta per la tradizione. Da una iniziale consapevolezza della articolazione e della complessità del compito, si è regrediti alla illusione di poter “controllare” le traduzioni con un modello dottrinale, retorico e persino grammaticale costituito da una lingua “non più viva”. Questo è il principio teorico di una “paralisi” che da 15 anni ha progressivamente interessato tutto il corpo ecclesiale sul piano del “tradurre”. Analizziamo meglio i due documenti:
– Comme le prévoit (1969)
E’ un documento assai articolato, che alla lettura di oggi appare il frutto di un primo grande sforzo per fornire alla grande fatica del “tradurre ecclesiale” alcune coordinate essenziali, ma irrinunciabili. Certo, alla luce di tutto quanto si è scoperto nei 40 anni successivi non si può negare che manchi di tutta una serie di consapevolezze che oggi abbiamo potuto maturare, non solo grazie a nuovi studi, ma anche grazie all’esperienza che abbiamo fatto nel tradurre e nell’impiegare nel culto le nostre traduzioni. Esso resta, a mio avviso, la base buona per un approfondimento ulteriore e per un vero arricchimento della tradizione nel confronto con “nuove culture” portate dalle lingue vernacole.
– Liturgiam authenticam (2001)
Questo testo pretende, esplicitamente, di cambiare direzione, di invertire la rotta. Sembra diffidare delle lingue vernacole e confidare soltanto nella possibilità di una “trasposizione dal latino” nelle lingue dei “barbari”. Nella storia della Chiesa mai si erano assunte posizioni così autoritativamente drastiche e così argomentativamente rozze, oltretutto senza alcuna motivazione portante, ma soltanto con giustificazioni di carattere amministrativo e burocratico. Manca in ogni caso tutta la articolazione che il documento del 1969 offriva con grande ricchezza, anche se aggiornata soltanto all’immediato preconcilio.
Per ovviare agli “abusi” che l’esperienza ha presentato negli anni successivi la strada obbligata sarebbe stata quella di “proseguire integrando”, piuttosto che quella di “invertire negando”. Al problema reale non si può rispondere con una soluzione così drastica da compromettere del tutto ogni possibile traduzione e di fatto bloccando il sistema.
2. La questione centrale: una riduzione delle lingue a strumenti della dottrina
In LA appare, in qualche modo, la certezza – che rasenta talora la illusione – che la lingue moderne, le lingue vernacole, possano/debbano essere semplicemente il “calco” della lingua latina, della quale si assume la “normatività” a livello liturgico. Vi è persino la “pretesa” di bloccare le lingue moderne mediante il “glossario” del Catechismo della Chiesa Cattolica! Ciò che è “dottrinale”, assunto dagli schemi catechistici, pretenderebbe di essere “normativo” per la stesura delle traduzioni dei testi liturgici.
Si consideri, ad es., il modo con cui LA indica la necessità che, nella traduzione, “il genere letterario e retorico dei vari testi della liturgia romana deve essere conservato”. E’ assai curioso che ciò che è tipico di una modalità “espressivo/esperienziale” di un ambito linguistico – ad es quello latino-romano – sia assunto quasi come un modello espressivo che si dovrebbe imporre alle altre espressioni linguistiche. Ma le lingue non rispondono alla autorità ecclesiale. Hanno una “propria” autorità, che deve essere rispettata ed ascoltata. Questa pretesa di LA – a metà tra ingenuità e arroganza – rivela una comprensione “strumentale” e, insieme, monumentale, della lingua. Ciò che conta, in fondo, in questa prima forma di approccio – che in fondo troviamo espressa con questa superficialità soltanto dal 2001 in qua – è la corrispondenza formale, verbale e sintattica, che deve essere perseguita nel modo più rigido possibile. Già Girolamo era consapevole che questa, come tale, non è una soluzione. Egli diceva che nel tradurre: “Se seguo parola per parola, non ha senso; se sono costretto a cambiare l’ordine del testo o le sue espressioni, mi sembra di essere infedele al mio compito di traduttore”.
In realtà il discorso che viene proposto da LA trova la sua giustificazione come opposizione ad una “teoria liberale” del tradurre, che viene espressa con molta forza al n. 19 di LA: “Le parole della Sacra Scrittura, come pure le altre che vengono pronunciate nelle celebrazioni liturgiche […] non vanno considerate in primo luogo come se fosse quasi lo specchio della disposizione interiore dei fedeli; esse esprimono delle verità che superano i limiti imposti dal tempo e dallo spazio”.
E’ evidente, quindi, che la “ratio” del documento LA sta in una reazione apologetica rispetto ad una “deriva” post-conciliare, percepita come “soggettivismo e relativismo liberale”.
A questo proposito si possono fare due osservazioni:
-
non vi è dubbio che il rischio di “traduzioni troppo libere” possa aver segnato la produzione di testi successivi a “Comme le prévoit” e che fosse necessario richiamare le singole Conferenza episcopali ad una maggiore attenzione;
-
d’altra parte, una risposta che pretenda di riportare ordine nella liturgia romana riconducendo la pluralità delle lingue a semplici “strumenti” per la comunicazione delle “res” dette e pensate in latino, questo mi pare, francamente, un rimedio peggiore del male, poiché porta a una totale paralisi della tradizione.
La diagnosi proposta da LA, per quanto esasperata e resa quasi apocalittica, può avere una sua pertinenza. Ma la terapia proposta è priva sia di fondamento teorico, sia di vera praticabilità. L’esito è che i testi prodotti secondo questo criterio “rassicurante” risultano di fatto inutilizzabili nelle lingue vive. E ne deriva che le lingue vive, proprio per questo, rivendichino a loro volta, a causa di questa impostazione, una autonomia ancora maggiore. Il che, d’altra parte, è incluso nella valutazione originaria della “mediazione linguistica della fede”, che non può essere sequestrata da un’unica tradizione, per quanto antica e autorevole.
3. Prospettive di soluzione
Ad una prima valutazione dobbiamo subito riconoscere che il passaggio tra i due documenti è assai brusco, e si può intendere da un lato come un passaggio del tutto “fisiologico”, ma dall’altro come l’affacciarsi di un processo “patologico”, nel quale è giunto ad ammalarsi il rapporto stesso tra Chiesa e cultura, con la presunzione di poter decidere “autoreferenzialmente” lo sviluppo della tradizione. LA, nel tentativo di superare alcuni abusi obiettivi, finisce con il peggiorare le cose, negando il presupposto della necessità del rapporto con la cultura, che la “svolta pastorale” del Concilio Vaticano II ha reso irreversibile nella storia della Chiesa. LA è quasi una sorta di “ribellione” contro questa logica “dialogica” che il concilio ha reso del tutto irreversibile. Possiamo dedurne che:
– del tutto normale è la risposta conciliare, come “esperienza” della complessità di una “comunione nella differenza”. Essa, evidentemente, corre anche dei rischi. E’ del tutto naturale che, dopo “Comme le prèvoit” dovessero sorgere nuove istanze, problematiche prima ignote, prospettive integrative e anche revisioni di criteri da precisare e da approfondire. Ma tutto questo resta una dinamica assolutamente fisiologica in un percorso di “aggiornamento”;
– assai anormale è invece la risposta “preter-conciliare”, ossia una risposta alla “questione della lingua” come se il Concilio non ci fosse stato e la sua svolta pastorale fosse puramente ipotetica. LA sembra completamente dimenticare che, in questi 50 anni, sono nati numerosi “testi originali in lingua vernacola”, che costituiscono il frutto di una nuova coscienza e di nuove generazioni, di nuove esperienze di nuove narrazioni: dimenticare ciò significa quasi immunizzarsi dalla storia, rifiugiarsi in un passato idealizzato e coltivare nostalgie, che diventano -inevitabilmente – una forma di “violenza sulla storia” dovuta ad un eccesso di autoreferenzialità.
4. “Liturgiam autenticam” “contiene” e “anticipa” Summorum Pontificum
Per concludere vorrei riprendere il “disegno autoreferenziale” che ha comandato LA: ossia quello di tornare a quanto “prevede SC 36”, ma facendo come se il Concilio – ossia come se la “svolta pastorale” che lo giustifica – non ci fosse mai stato. Vi è, in effetti, più di un indizio che può farci propendere per questa ipotesi. Il più sorprendente si trova proprio nel numero 2 del documento LA, dove troviamo la frase:
“Exinde, Summorum Pontificum cura, magnum opus instaurandi libros liturgicos Ritus romani coepit initium…”
Il Motu Proprio di 6 anni successivo, che avrebbe dato inizio al rischioso parallelismo tra rito ordinario e rito straordinario è, di fatto, contenuto, non solo nello spirito, ma addirittura nella lettera di LA, ossia all’interno di questa indiretta negazione non certo del Concilio, ma proprio della sua giustificazione pastorale.
Una delle ambizioni di LA veniva così affermata: “La presente istruzione prelude – cercando di prepararla – una nuova stagione di rinnovamento…”. Questa asserzione assomiglia molto a quelle – ad essa contemporanee e anche successive – intorno alla esigenza di un “nuovo movimento liturgico”, ossia l’auspicio di un movimento liturgico che possa garantire alla navicella della Chiesa di rispondere ad un “solo ordine”: “macchine indietro tutta”!
Oggi, a distanza di 15 anni – ma, in fondo, era facile prevederlo già 15 anni fa – è del tutto evidente che “una nuova stagione di rinnovamento” sarà possibile soltanto superando le contraddizioni e le ingenuità nostalgiche di questo atto di interruzione della “svolta pastorale” iniziata con il Concilio Vaticano II.
Anche in liturgia vale ciò che P. Beauchamp diceva, delle Scritture, ossia che “la loro verità non sta dietro, ma davanti ad esse”. Una VI Istruzione dovrebbe aver chiara, anzitutto, questa bella immagine: in liturgia la verità sta anche sempre davanti, non solo dietro; sta anche nel destinatario, non solo nella fonte; sta anche nel dono dello Spirito alla Chiesa e non solo nella istituzione originaria del testo storico.
La tradizione ha bisogno di traduzione vere – inevitabilmente rischiose: non può vivere di calchi impossibili e autoreferenziali di una lingua che non è più alla base della esperienza dei popoli cristiani.
“Liturgiam authenticam”, assumendo l’autorità solo del passato, ha reso il presente e il futuro impossibili. Una Chiesa “in uscita” deve quanto prima rimediare a questo chiavistello che spranga la porta sul futuro.


























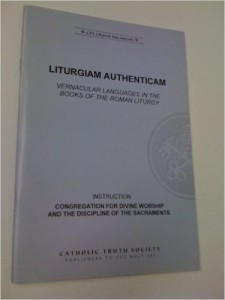
 Area personale
Area personale












Che poi, perdoni. Il modello delle messe schitarrate, batti-le-mani, muovi–piedi, mi sembra proprio abbia avuto un grande succcesso. Siam tutti così contenti di essere cattolici che
1. le messe sono stracolme di gente entusiasta (e infatti lei parla di gente, a cui i vescovi devono obbedire, significativa espressione)
2. dal soglio pontificio la liturgia viene definita preoccupazione per pelagiani.
Che dire di più?
In ossequio di obbedienza i vescovi obbediscono al papa: quando la liturgia non è più Azione Sacra allora tutto diventa opinabile e secondario, anche le sue care traduzioni, “Lithurgiam authenticam” e menate varie (perchè ormai tali sono considerate dal soglio petrino, non nascondiamoci dietro un dito).
Il dramma del nostro tempo, caro Grillo, sta nella negazione continua di una trascendenza. La liturgia è il primo obiettivo della secolarizzazione, quando essa non tende più a far memoria (lei sa il significato del termine) del divino mistero incarnato (parole che ormai i teologi aborriscono, si capisce). E, spiace dirlo, la crisi della liturgia non si combatte con una traduzione politically-correct, semmai ne si decreta la fine. A quando la dichiarazione di morte presunta?
Il suo goudizio è privo di equilibrio. Tradurre è una cosa seria. Dal 2001 invece la si tratta come se la trascendenza fosse garantita solo dalla “lettera”. Questo blocca la tradizione. Spero che lei maturi uno sguardo meno ideologico.
Dovrei maturare uno sguardo meno ideologico. E sta bene.
Solo una semplice domanda: ma a che serve la liturgia?
Perchè questo è il fulcro della questione. Se essa è autocelebrazione comunitaria, circolo di villaggio (globale), occasione di manifestazione di istanze sociali/di gruppo venata di ambientalismo/buonismo (avvalorato dall’ultima enciclica), credo che tutta la questione da lei sollevata sia inutile. Di fatto basta garantire la libertà delle traduzioni vernacolari, la flessibilità rituale, secondo l’occasionale sensus fidelium, così da creare una nuova traditio. E tutti sono contenti. Guardi, non basterebbe nemmeno una nuova istruzione liturgica, perchè tale testo sarebbe autocontraddittorio. Personalmente credo che molti teologi e pastori (anche molto in alto) ne sarebbero contenti: sarebbe sdoganato il dogma dell’Eucarestia e si potrebbero creare “cerimonie” interreligiose che tanto in questo tempo sono cercate… Il ridicolo è che si ripiomberebbe in un nuovo cerimonialismo, dove però il caos sarebbe il vero dominus della situazione.
Ma se la liturgia è altro, se è un dono non in nostro possesso, certe questioni che lei pone sono preoccupanti proprio per il fatto che lei (da teologo ancora cattolico?) se le pone, perchè denotano chiaramente una deriva… e mi fermo qui. Allora che cos’è la liturgia? Se siamo d’accordo che non sia solo un insieme di cerimonie o di testi da tradurre, allora che cos’è? Credo che nella risposta a questa domanda si giochi la nostra fede.
Caro Matteo, sono 20 anni (almeno 20 anni) che cerco di scrivere e di dire, in ogni sede, proprio la differenza che le sta a cuore. Proprio perché la liturgia non è in nostro possesso non può essere irrigidita soltanto nella cultura latina. L’assolutismo del latino solo in apparenza garantisce la intoccabilità della liturgia. In realtà la rende schiava di una cultura di funzionari clericali. Io senso, in profondo, una consonanza tra la sua legittima aspirazione – che è anche la mia – di garantire la “natura di dono” della liturgia, e la esigenza di far entrare nella liturgia le culture dei diversi popoli cristiani e cattolici. Lei continuamente si chiede se io sia ancora cattolico. Io le rispondo che è proprio il mio cattolicesimo a chiedermi la fedeltà alla cultura, alla esperienza degli uomini e delle donne, per poter onorare pienamente il Vangelo. Anche il “dogma eucaristico” presuppone la evidenza della esperienza del “pane” e del “vino”. Sono solo le specie, non la sostanza, ma sono mediazioni delicate della sostanza. Se manca una cultura del pane e del vino non c’è eucaristia. QUesto diceva S. Tommaso, commentando i “miracoli eucaristici” e deducendo che la “carne” o il “sangue” che apparivano in quei miracoli potessero essere “soltanto” apparenze del pane e del vino. Solo così quella poteva continuare a essere eucaristia! Allora, coraggio, non si deve avere paura della cultura e delle lingue moderne. Il servizio alla tradizione è una mediazione delicata e non rigida. Ogni rigidità è sintomo di paura. Un caro saluto.
La ringrazio per la risposta ed il franco contraddittorio.
Noto un punto di accordo: la liturgia non è un semplice insieme di cerimonie, per lo più ridotte ad etichette tardorinascimentali-manieriste. Per questo, mi creda, non sono e non voglio essere uno scismatico lefebvriano, ma cattolico.
Con altrettanta forza però desidero sottolineare che c’è quel quid nella liturgia, specie eucaristica, che non può essere oggetto di continue trasformazioni, sull’onda emotiva del consenso dei contemporanei. Ritengo che il dramma del cattolicesimo del nostro tempo sia, sotto sotto, il tentativo malcelato di eliminazione del trascendente (che per sua natura ci supera in maniera incommensurabile) dalle nostre vite e l’illusione dell’autosalvezza. In questo senso, permetta, la liturgia creativa che piace (ma quanti sono poi gli effettivi praticanti? pochi direi…) è, a mio avviso, molto più autoreferenziale di altre che si potrebbero definire più “ingessate”. Un ultimo spunto, magari potremmo continuare la discussione su altri articoli: si sente più parlare di “Santo Sacrificio eucaristico”? Ormai i preti stessi rifuggono da queste definizioni… che aborriscono (tranne pochi). Il che, a mio parere, è tutto dire… Grazie e un saluto anche a lei.
Già il Concilio si è posto la questione di distinguere ciò che si può modificare e ciò che non si può modificare. Da un lato si può dire che ci sono “parti modificabili” e parti “non modificabili”; ma questo, a dire il vero, non convince. Piuttosto c’è una “sostanza” che deve restare anche se gli “accidenti” possono cambiare. Questa è una rappresentazione migliore. Con lei condivido il bisogno di continuità. Ma per assicurarla occorre anche coraggio, per rinunciare agli accidenti che sono oggi di ostacolo. Questa è arte del tradurre. Che i preti rifuggano dalla terminologia del “santo sacrificio eucaristico” non è forse solo un male. Possiamo dirlo così: per garantire il senso della “morte per” di Gesù, cui la Chiesa è associata, quale linguaggio è meglio utilizzare? Perché dobbiamo sentire il bisogno di tradurre “pro vobis tradetur” come “offerto in sacrificio per voi”? Ecco un esempio di “traduzione libera”, legittima, che non mi scandalizza, ma che intenzionalmente aggiunge quello che non c’è. Un caro saluto
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam” […]
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam” […]
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam” […]
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam” […]
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam” […]
Does anybody nowadays read the writings of Christine Mohrmann? If no, why not?
[…] Ma Francesco ha fatto capire da subito che la cosa lo lasciava indifferente. E ora, con l’istituzione di questa commissione, va incontro alle idee di modernizzazione del linguaggio liturgico caldeggiate, ad esempio, dal liturgista Andrea Grillo, professore al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e molto apprezzato a Casa Santa Marta: > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam”. […]
Gentile prof. Grillo,
Leggerla per me è sempre molto utile, anche quando non mi convince ciò che scrive. Non entro nel merito dell’articolo, ma vorrei porle una questione meta-liturgica: non le sembra che sarebbe ora di portare un po’ di serenità e distacco scientifico in questo infinito dibattito sulla liturgia, sulla lingua liturgica, etc.?
Recentemente mi sono trasferito in Lombardia e ho iniziato a conoscere la realtà del Rito Ambrosiano, anche quella dove si celebra nella forma del 1954 del Cardinal Schuster. Forse non sono ancora abbastanza inserito nella nuova realtà al punto da comprenderne eventuali tensioni interne, ma fino ad ora ciò che mi ha colpito in positivo è stata la “serenità” con cui i fedeli convivono con entrambe le forme del loro Rito. Perché tanto livore, invece, per il Rito Romano? Perché il Messale di Pio V è divenuto una bandiera partitica, invece di rimanere uno dei tasselli del patrimonio della Cristianità occidentale? So bene che certi ambienti, come denunciato (per dirne uno) da Ives Congar, ne hanno fatto una sorta di arma anticonciliare; però penso che sia davvero un peccato identificare un patrimonio universale della Chiesa con il presunto Cavallo di Troia di piccoli gruppi ideologizzati, che attraverso il Vetus Ordo intendono mettere in discussione l’intero CVII. Mi piacerebbe avere una sua opinione sulle questioni poste sopra. La mia impressione, infatti, è che senza una ritrovata prospettiva pluralista e, dunque, autenticamente cattolica, vi sarà sempre una sordità reciproca fra chi ritiene che la Chiesa inizi e finisca a Trento e chi ritiene che la Chiesa inizi e finisca col CVII.
Cordialmente
Francesco Mascellino
P.s. Poi, un’altra volta, le chiederò anche del rapporto (o meglio: del non-rapporto) tra i teologi e la filosofia analitica, che sulle questioni linguistiche ha detto e continua a dire tanto, ma che per le facoltà pontificie è figlia del demonio… 🙂
[…] l’attacco a LA ha anche un altro scopo, che è proprio l’insospettabile Andrea Grillo a rivelarci. Riassunto: se spazziamo via LA colpiamo anche il motu proprio Summorum Pontificum (SP), perché […]
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di "Liturgiam authenticam" […]
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di "Liturgiam authenticam" […]
[…] > La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di "Liturgiam authenticam" […]
[…] propio Andrea Grillo en su artículo: La traduzione /tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam” (: “…La presente istruzione prelude – cercando di prepararla – una nuova stagione di […]
[…] Autenticham tiene otro alcance, que insospechablemente Andrea Grillo revela lo siguiente (ver aquí) : si exterminamos a través de la Liturgiam Autenticham, golpeamos también el motu proprio […]
[…] Autenticham tiene otro alcance, que insospechablemente Andrea Grillo revela lo siguiente (ver aquí) : si exterminamos a través de la Liturgiam Autenticham, golpeamos también el motu proprio […]
[…] Autenticham tiene otro alcance, que insospechablemente Andrea Grillo revela lo siguiente (ver aquí) : si exterminamos a través de la Liturgiam Autenticham, golpeamos también el motu proprio […]
[…] to Magister, the agenda of the commission was established by an article drafted by the theologian Andrea Grillo, which apparently had the support of Pope […]
[…] to Magister, the agenda of the commission was established by an article drafted by the theologian Andrea Grillo, which apparently had the support of Pope […]
[…] languages.” According to Magister, the agenda of the commission was established by an article drafted by the theologian Andrea Grillo, which apparently had the support of Pope Francis. […]
[…] to Magister, the agenda of the commission was established by an article drafted by the theologian Andrea Grillo, which apparently had the support of Pope […]