Il coraggio della parresìa per “smaschilizzare” la Chiesa. Un evento che diventa un libro
Perché mai parlare di un “evento” che diventa “libro”? Perché a me pare che il piccolo volumetto che è appena uscito dalle edizioni Paoline (L. Vantini – L. Castiglioni – L. Pocher, “Smaschilizzare la Chiesa”? Confronto critico sui “principi” di H.U. von Balthasar, 2024) sia la registrazione pubblica e oggettiva di un evento ecclesiale, avvenuto il 4 dicembre 2023, quando, su invito di papa Francesco due teologhe e un teologo sono stati invitati ad offrire una riflessione, al Papa e al suo Consiglio di Cardinali, intorno alla presenza e al ruolo delle donne nella Chiesa. Ma c’è di più: la domanda venuta dal papa non mirava ad un generico approfondimento, ma a tematizzare esplicitamente (e criticamente) la teoria del “principio mariano” di H. U. von Balthasar, di cui il magistero degli ultimi decenni ha fatto un uso piuttosto intenso e piuttosto acritico. I tre invitati hanno fatto il loro mestiere e hanno mostrato, in modo differenziato, quanto critico debba essere il confronto.
Nel libro il papa ha scritto anche due pagine di Prefazione, che mostrano bene due priorità: l’esigenza di “ascoltarsi reciprocamente”, per “smaschilizzare la Chiesa” (il titolo del libro riprende precisamente questo tipico neologismo del papa); l’esigenza di comprendere la differenza tra uomini e donne, lasciando il punto di arrivo “nelle mani di Dio”.
Ora, mentre i due interventi di Castiglioni e di Pocher si concentrano soprattutto su una analisi della identità presbiterale in una nuova comprensione e su una rilettura rinnovata dalla figura di Maria in alcuni passi della Scrittura, vorrei qui esaminare soltanto il primo testo, quello di Lucia Vantini, che, per così dire, “prende il toro per le corna” e mostra la fragilità teoretica e pratica della dialettica tra “principio mariano” e “principio petrino”, così come concepita da H.U. von Balthasar e come poi utilizzata da parte del magistero ecclesiale.
Va detto che nel suo testo Vantini segnala di proporre una riflessione che si appoggia su un lavoro ormai ventennale, in cui molte teologhe italiane e straniere hanno mostrato, con finezza argomentativa, la fragilità carica di pregiudizi con cui la teoria dei “principi” è stata prima concepita e poi utilizzata. Anche su questo blog Marinella Perroni ha già presentato, sinteticamente, il cuore delle profonde riserve sul piano esegetico e sistematico rispetto a questa teoria ( il testo si può leggere qui).
Ma esaminiamo meglio i tre passi fondamentali che Lucia Vantini ha compiuto davanti al Consiglio dei Cardinali.
a) Il principio, le sofferenze e le insofferenze
Il principio mariano-petrino, per chi lavora in una ricerca di genere, provoca sofferenze e insofferenze. Questo evidentemente vale anzitutto per le teologhe, che sentono, sul loro corpo, la sofferenza e la insofferenza verso un modo di impostare la comprensione della differenza che mortifica una parte. Dice Vantini, rivolgendosi a Papa e Cardinali:
“Il mio desiderio è quello di creare un passaggio tra noi affinché, come uomini che hanno un ruolo ministeriale ordinato, possiate accedere a quel mondo femminile che si trova a disagio con questo principio di Balthasar, un mondo femminile tanto esaltato quanto incompreso, misconosciuto, inascoltato, sottovalutato, deriso e demonizzato” (15).
Dopo aver citato due interventi pubblici di papa Francesco, nei quali invitava appunto ad esprimere le sofferenze e a manifestare le insofferenze, Vantini precisa come il “conflitto di interpretazioni” non sia da intendersi come quello di schieramenti contrapposti, ma come ricostruzione, dialogica, di una complessità non riducibile, rispettosa, non escludente, in vista di una crescita di tutti e per conseguire un livello più alto di esperienza comune.
b) Una mistica dello stereotipo e della sottrazione
Molto opportuno e singolarmente efficace è l’attacco del secondo paragrafo, dove Vantini inizia da una utile definizione del “principio”, sulla scia degli studi di M. Perroni:
“Il principio mariano-petrino […] funziona perché promette di semplificare quella complessità che ci terrorizza, di riportare le differenze all’unità voluta dal soggetto più forte e di ordinarle con precise polarità gerarchizzate, perché consente a qualche nostalgico di riproporre in modo elegante quell’orizzonte patriarcale e fratriarcale entrato oggi in crisi, ma non del tutto estinto né sostituito da un sistema simbolico alternativo” (18)
La teologia “di genere” ha smascherato il “gioco truccato” che si nasconde dietro il tono sommosacerdotale di von Balthasar
“il principio mariano-petrino cancella o neutralizza le donne attraverso definizioni buone e immagini esaltanti” (18)
E qui, di nuovo, è molto fine il rimando tra la “condizione femminile” e la “condizione papale”: Vantini ricorda la affermazione di una delle prime interviste di papa Francesco (“Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c’è una aggressione”). Come il papa temeva, in quella intervista, che la “idealizzazione del papa” fosse sotto sotto una forma di violenza esercitata sulla sua libertà storica, analogicamente questo vale per le donne di fronte al principio mariano:
“Francesco usò una logica simile a quella delle donne stanche di essere descritte alla luce del modello mariano o del genio femminile, sentendosi forse come loro, inchiodato in uno spazio di perfezione che paralizza e condanna all’impossibilità di essere ciò che si è, con i pregi e i limiti della propria singolarità” (19)
Qui mi pare molto ispirata e sorprendente la sovrapposizione tra due diverse idealizzazioni, che esercitano violenza sulle donne e sul papato: forse proprio qui vale la complessità delle figure bibliche, in cui Maria è anche emblema dell’essere “sotto la legge” e in cui Pietro è anche ferito dalla sua debolezza e sa piangere amaramente.
c) Forzature del femminile e del maschile
Siamo di fronte ad una “formula vuota con tristi e ingiusti effetti collaterali” (19). Ciò che le donne, con il loro studio hanno mostrato, può essere così sintetizzato:
“La promessa veicolata sembra positiva: un mondo in cui donne e uomini possono avere il giusto spazio senza entrare in competizione o pestarsi i piedi, e vivano in una buona alleanza per la cura del mondo. Il dispositivo, però, è strutturalmente fragile, perché mira a ottenere tutto questo integrando il femminile come ‘forza di ispirazione’ di un mondo che resta maschile. Noi donne non siamo nella Chiesa come Beatrice per Dante” (19-20).
Questo smascheramento del dispositivo idealizzante che scatta nell’uso del duplice principio permette di leggere con nuova lungimiranza sia la Chiesa-sposa, come metafora da applicarsi ad ogni vita credente e da non chiudere in un automatismo di ruoli che la stravolge. La “ricettività” alla grazia è trasversale, è di tutta la chiesa, di tutti i “nati da donna”, uomini e donne. Per questo la problematicità dei due principi investe non solo il femminile, ma anche il maschile:
“Il principio di Balthasar è problematico non solo perché interpreta l’elemento mariano-femminile come affettivo e carismatico, ma anche perché interpreta quello petrino-mascile come esclusivvamente ministeriale-istituzionale, avvalorando una strana cornice che confina il primo nel mondo soggettivo e il secondo nel mondo oggettivo” (25)
Un effetto non controllato (ma forse voluto inconsciamente) è quello di avvalorare
“un immaginario della differenza che confina le donne in retroscena e gli uomini a gestire, da soli, o al massimo con una moderazione femminile implicita, il governo delle cose” (28).
Le ragioni delle differenza non sono gerarchiche: qui sta il punto decisivo per impostare correttamente la “partecipazione femminile” alla vita della Chiesa e per rimuovere gli impedimenti teorici e pratici di tutti quelli che si paralizzano solo a sentirne parlare.
d) Dal complesso al costretto: andata e ritorno
“Periculum latet in generalibus”. Come bene sottolinea anche Castiglioni, nel secondo testo, e Pocher, nel terzo, una trattazione della “donna” o di “Maria” che avvenga “in generale”, che trasformi la donna e Maria in un “principio”, passa facilmente dalla complessità delle donne e delle attestazioni su Maria, ad una idealizzazione che genera una “costrizione” e una “chiusura”.
Così si deve precisare lo scopo di questa “critica dei principi”:
“Decostruire il principio mariano-petrino non conduce alla negazione della differenza sessuale come tratto di parzialità e finitezza che segna ogni vita. Il gesto, piuttosto, la rende libera di significare senza cadere in formule gerarchiche antievangeliche” (28)
Si dischiude così l’orizzonte paolino di Gal 3,28, in cui le differenze etniche, sociali e sessuali non possono essere motivo di vanto o di umiliazione delle vite: questo richiamo prepara una conclusione sul piano della coscienza storica e della custodia della complessità, in cui differenza ed eguaglianza trovino il loro equilibrio, tra dignità e onore. E giustamente, in chiusura, Vantini ricorda una frase profetica di Carlo Molari:
“Ci sono qualità umane che secoli fa non erano necessarie, o erano impossibili da sviluppare o erano addirittura vietate” (citato a p.31)
Uscire dalla idealizzazione mistica del femminile, per scoprire le donne reali, è un modo, forse l’unico modo, per accettare e valorizzare quell’evento che Giovanni XXIII ha riconosciuto limpidamente nella sua ultima Enciclica, Pacem in terris: l’entrata nello spazio pubblico della donna. Questo evento culturale e sociale è un evento spirituale che non solo non è estraneo alla vita ecclesiale, ma che viene oggi riconosciuto come uno dei terreni su cui è più urgente per la chiesa uscire da sé: verso una chiesa in uscita anzitutto dai propri pregiudizi.
Aver potuto e saputo dire tutto questo davanti al Papa e al Consiglio dei Cardinali è un segno dei tempi: della limpida maturità di una teologia di genere e della parresìa di cui sente l’urgenza non solo chi ha il coraggio di esercitare la critica apertis verbis, ma anche chi ha il coraggio di subirla, di accoglierla e di meditarla. Questo dialogo tra donne coraggiose nel parlare e uomini coraggiosi nell’ascoltare fa bene al cuore.



























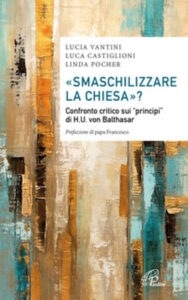
 Area personale
Area personale












Puoi ben immaginare, Andrea, quale gioia mi abbia dato ricevere in regalo da Lucia Vantini questo piccolo libro. Piccolo, ma potente, come Davide di fronte a Golia. È vero, sono anni che insisto – che insistiamo in molte, in realtà – perché il Magistero pontificio esca da questo cul de sac in cui si è cacciato con la ripresa, monotona e soprattutto acritica, del doppio principio balthasariano. Mai avrei creduto che un giorno una di noi, bravissima ma anche rappresentativa in quanto presidente del Coordinamento teologhe italiane, sarebbe stata convocata “al vertice” per spiegare perché da molti anni ormai teologhe di tutto il mondo abbiano chiesto di liberare l’ecclesiologia magisteriale da questo binarismo che la ingabbia. Invece è successo, e il saggio di Vantini, in modo pacato ma inesorabile, rende ragione di anni e anni di riflessione critica e di dibattiti.
Aggiungo solo una notazione strettamente personale: mi dispiace che non ci sia più tra noi padre Silvano Maggiani, Servo di Maria, che ci ha lasciato ormai da quattro anni. È stato lui, ben venti anni fa, a propormi di affrontare criticamente il problema del doppio principio in vista di un convegno delle Associazioni teologiche italiane. È stato lui a chiedermi di presentarlo poco dopo come quaestio disputanda su Marianum ed è stato sempre lui a inviarne copia a papa Francesco dato che, poco dopo l’elezione, si era allineato ai suoi predecessori presentando il principio mariano-petrino di Hans Urs von Balthasar come la regola aurea di un’ecclesiologia a suo avviso rispettosa della differenza sessuale. Dedico allora a padre Silvano questa breccia che si è aperta e attarverso la quale potranno finalmente circolare riflessioni e dibattiti, prospettive e aspettative. Perché la nostra chiesa sia sempre più una comunità di uomini e di donne “nel Signore”.
I meriti di P. Silvano sono, su questo come su altri temi, profezia di futuro, ora davvero possibile.
I am so glad to see this report. It is very good to know that the Pope and his cardinal advisors were told all of this. But did they take it in? Did they understand it?
In his address to the plenary of the Dicastery of Divine Worship on February 8, Pope Francis out of nowhere leaned hard on the notion of “woman” as a symbol, in service to the diminution of women’s ministerial calling and potential. All the same problems with the use of a Marian/Petrine dichotomy were on full view, as if they are not problematic at all.
Here are his words: “The Church is woman, the Church is mother, the Church has Mary, and the Church-as-woman, whose figure is Mary, is greater than Peter; that is something else. … Woman in herself finds in the Church-as-woman a very great symbol, without being reduced to ministeriality.”
Who is “woman in herself” of whom he speaks? It is an idealization. I am glad there is a book that shows what was said. From the Pope’s recent statement, I would have imagined that he heard the exact opposite: a reinforcement of the Marian / Petrine dichotomy.