Un matrimonio da portare in detrazione: il bonus e Don Abbondio
La proposta di “incentivare il matrimonio cattolico” con un bonus, che preveda la possibilità di detrarre il 20% delle spese sostenute per la cerimonia fino al tetto massimo di 20.000 euro, ha suscitato immediatamente reazioni sdegnate. Un quadro molto preciso delle questioni è stato delineato a caldo da Luciano Moia ieri su “Avvenire” (in un puntuale articolo che si può leggere qui). Le parole chiare di questo testo recepiscono anche le dichiarazioni ferme di Mons. Paglia, che suonano così:
“Il matrimonio per la Chiesa è un sacramento e un sacramento non si compra. Il credente che sceglie la celebrazione del matrimonio in Chiesa, non si fa convincere a questo passo dalle detrazioni economiche”.
Non si deve dimenticare, tuttavia, come mette bene in luce lo stesso Moia nella seconda parte del suo articolo, che questa “riduzione economico-giuridica” del matrimonio non è solo frutto di una “grossolana svista” di alcuni parlamentari leghisti, ma è anche il risultato di una “storia” di cui la Chiesa cattolica deve assumere una parte non piccola di responsabilità. Vi è una autocritica ecclesiale che è intrinseca al “rilancio sano” della scelta matrimoniale. Lo ha detto chiaramente papa Francesco in quel “decalogo di autocritica” che troviamo all’inizio di Amoris Laetitia e dove precisa:
“Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell autorità.” (AL 35)
Questa autocritica è particolarmente ardua, perché cozza contro un “sistema” che ha fatto del principio di autorità la sua ragion d’essere, la sua identità e il suo onore. Vorrei soffermarmi brevemente su questo punto.
a) La relazione tra “bonus” e “tametsi”
Due parole latine ci sono utili, per capire la deriva “giuridico-economicistica” nella quale siamo caduti, quasi senza accorgercene. Ci aiuta in modo elegante ancora L. Moia, che all’inizio del suo articolo ricorda come Don Abbondio, nel cap. 2 dei Promessi sposi, propone a Renzo una piccola lezione sul matrimonio:
«“Sapete voi quanti siano gl’impedimenti dirimenti?” “Che vuol ch’io sappia d’impedimenti?” “Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, si sis affinis, …” cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita. “Si piglia gioco di me?” interruppe il giovine. “Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?”»
La scena è carica di quella ironia che Manzoni sapeva orchestrare con tanta abilità. Ma rappresenta una comprensione del matrimonio che da circa un secolo era divenuta possibile in Europa, dopo il decreto Tametsi (1563). Con il quale la Chiesa cattolica assumeva come criterio di validità del sacramento del matrimonio la sua “forma canonica”. Per la prima volta il matrimonio diventava totalmente interno ad un “ordinamento giuridico”. La proposta di legge della Lega resta, sostanzialmente, in questa logica: e intende incentivare la scelta del matrimonio “religioso” mediante un “bonus”. E’ curioso leggere la definizione che il Vocabolario Treccani dà di “bonus”: “Sconto, abbuono, spec. in ambiti come le assicurazioni e i trasporti.” Che si tratti il matrimonio come una assicurazione o un contratto di trasporto non è cosa nuova. Molta parte delle politiche economiche “a favore della famiglia” funzionano così: con sconti, detrazioni o incentivi, creano le condizioni perché la unione, la generazione o la cura-assistenza possano risultare economicamente più vantaggiose. La riduzione “economica” di un sacramento è certo cosa grave: ma non ha cominciato a farlo lo Stato, bensì la Chiesa, in tutt’altro tempo e con ben altri intenti. Però la sovrapposizione completa e tendenzialmente totalizzantee tra “ordinamento ecclesiale” e “logica matrimoniale” è nata proprio a metà del XVI secolo, nella reazione della Chiesa cattolica alle trasformazioni moderne. E’ la modernità cattolica ad aver inventato questa possibilità.
b) Conseguenze inattese di una scelta contingente
Un sacramento “non si compra” né si sottopone a condizioni, si dice giustamente. Ma la “forma canonica” è precisamente una “condizione” perché il sacramento sia valido. Da questa scelta, discussa allora e discutibile anche oggi, discendono una serie di conseguenze inattese: ad es. la tendenziale applicazione, sempre più estesa, delle “condizioni di nullità” ad ogni vincolo matrimoniale; la pretesa che solo l’ordinamento ecclesiale fondi un legame valido; la lotta contro ogni normativa civile circa il matrimonio e la parallela contrapposizione tra ordinamento canonico e ordinamento civile, fino alla possibilità – davvero estrema – per cui l’ordinamento civile costruisce una legge che favorisce la scelta dell’ordinamento canonico (cosa che, sul piano civile, cozza contro il principio costituzionale di parità di trattamento). Può essere soprendente, ma è un buon segno, che oggi sia venuto dal mondo ecclesiale cattolico la protesta contro un provvedimento che attesterebbe “una scelta discriminatoria tra matrimonio religioso e matrimonio civile”. Questa è una buona notizia. Ma dietro alla questione rimane il problema strutturale e sistematico della “cecità” dell’ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamenti. Questo punto critico rimane intatto, finché la logica totalizzante e totalitaria di “Tametsi” resta lo stile di fondo del modo di pensare il matrimonio, con una esclusiva attribuita all’ordinamento ecclesiale che fatica a comporsi con le logiche della natura e della città. E che pertanto, in caso di crisi, preferisce “dichiarare la nullità del vincolo” piuttosto che riconoscerne altre forme. D’altra parte la stessa nullità non è stata elaborata, fin dall’origine, assimilando matrimonio e contratto? Qui sta il punto debole della tradizione, che AL ha iniziato a modificare.
c) Il bonus come condicio e il valore gratuito del matrimonio
Si è detto, a ragione, il matrimonio è una scelta libera, che non può essere condizionata da un “bonus”. Questo però vale per ogni matrimonio. Ma le politiche di incentivi lavorano precisamente sulla “convenienza”. Che cosa accadrà se, come è probabile, il bonus verrà esteso ad ogni matrimonio (religioso e civile)? Si chiederà forse al cattolico, che decide di sposarsi in Cristo, di sottoscrivere una dichiarazione di “rinuncia al bonus”? Oppure il ricorso al bonus potrà essere usato, domani, come “motivo di nullità”? In realtà le politiche di incentivo alla unione e alla generazione prendono. spesso la figura di “vantaggio economico”. Di questo non ci si deve scandalizzare troppo. Piuttosto deve essere arricchita la percezione delle “diverse forme di legame familiare”, e delle loro differenze, senza introdurre, per legge, forme di discriminazione o di disparità maggiori di quelle che già esistono di fatto. Tuttavia il fatto che un soggetto possa portare in detrazione, nella prossima dichiarazione dei redditi, le spese che ha sostenuto per i fiori o per il pranzo del matrimonio, mi pare un modo per ridurre ulteriormente quella esperienza di gratuità che proprio un matrimonio religioso dovrebbe garantire, quasi a simbolo massimo di ogni convivenza di fatto. Il matrimonio “religioso” è una differenza di grazia, una differenza gratuita. Così l’incentivo economico, inventato per favorire una esperienza, si capovolgerebbe, facilmente, in un più radicale svuotamento simbolico dell’atto matrimoniale, dei suoi linguaggi contingenti e della sua potenza vitale. Non c’è festa senza consumo, senza perdita, senza pura gratuità. Contraddire questa sapienza umana ed ecclesiale, per un piatto di lenticchie, sarebbe un modo, indiretto ma feroce, con cui non da Don Abbondio, ma proprio con le nostre mani saremmo condotti, quasi inconsapevolmente, a “prenderci gioco di noi stessi”.


























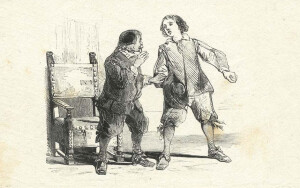
 Area personale
Area personale












Vero. Basta riconoscere pure il.pensiero unico e di sistema imperante.
https://gpcentofanti.altervista.org/un-racconto-breve-habemus-papam/