A proposito di “Summorum Pontificum”: una risposta a Zeno Carra
Nel post precedente (qui) Don Zeno Carra aveva proposto alcune riflessioni critiche sul mio post (qui) dedicato alla autobiografia di J. Ratzinger come criterio di giudizio per il MP Summorum pontificum. Qui propongo qualche riflessione in risposta alle parole di Don Zeno, per continuare un utile dibattito.
Caro Don Zeno,
anzitutto un ringraziamento per aver scritto la tua lettera in risposta ai miei ultimi post e per la libertà con cui hai esposto le tue limpide osservazioni. Da sempre credo che il confronto aperto, leale e sincero sia l’unica via, anche nella Chiesa, per affrontare le questioni importanti. Ti sono grato anche per il tono personale che hai voluto dare alle tue parole. In fatto di liturgia e di eucaristia, argomentazioni e questioni si legano sempre ad affetti e ad “attaccamenti”, senza i quali non esiste celebrazione alcuna.
Voglio proseguire il tuo ragionamento, seguendolo “passo passo”, perché mi sembra che indichi con chiarezza tutto ciò su cui siamo d’accordo e i punti su cui pensiamo cose diverse.
In primis, e qui mi pare non solo che ci sia accordo tra noi, ma che tu sia tra i pochi teologi che hanno espresso apertis verbis la incompatibilità tra VO e NO: la reciproca esclusione tra i due “ordines” deve essere riconosciuta e accuratamente segnalata, contro ogni falso “concordismo”, che a me appare per lo più come una finzione irresponsabile.
In secondo luogo mi sembra che invece la differenza tra la tua considerazione e la mia appaia più chiaramente dove tu proponi una “diversa ermeneutica” della autobiografia ratzingeriana. Su questo punto credo che possa essere utile chiarire alcune questioni, che mi sembrano decisive per comprendere appieno ciò che è in gioco.
Vorrei farlo mettendo in luce alcuni aspetti del problema che la tua ricostruzione certamente considera, ma in modo forse parziale.
a) Tu distingui tra una mia critica, che chiami “epistemologia giuridica del fatto riforma”, e un approccio materiale a singoli aspetti della Riforma, che riconosci come fondamento delle parole del futuro Benedetto XVI. Qui mi pare che vi sia un possibile equivoco, che desidero chiarire.
Ciò che dal 2007 io rilevo è certo un problema che può essere definito di “epistemologia giuridica” – ossia riguardante la questione di “quale rito romano sia vigente” – ma non è soltanto né principalmente relativo ad una questione di diritto. E’ piuttosto una questione teologica, pastorale e spirituale a dover essere sollevata.
b) Il punto debole di SP, infatti, consiste nell’aver reintrodotto “in forma universale” – per quanto condizionata – il Vetus Ordo: questo è un modo improprio e distorto per affrontare le questioni che tu giustamente sollevi, e sulle quali io non ho alcuna difficoltà ad assumerle seriamente, come “riflessioni critiche interne alla Riforma liturgica”. Purché si riconosca che con la Riforma Liturgica il rito romano è passato, in forma completa e definitiva, da un ordo ad un altro. E che questo è avvenuto per assicurare la continuità della tradizione.
c) Se invece, come accade con Summorum Pontificum, si riabilita in forma universale, il rito che è stato oggetto di revisione da parte della Riforma Liturgica, si getta obiettivamente un discredito complessivo sul cammino ecclesiale, che crea un “percorso parallelo”, con la pretesa di renderlo “immune” dalla necessità della Riforma. SP può anche ripetere senza posa la “esigenza di riconoscere il NO come forma ordinaria e universale del rito romano”, ma di fatto crea le condizioni oggettive perché molti soggetti possano farne a meno per sempre.
d) Per questo io ritengo che proprio le tue osservazioni a riguardo sia di alcuni aspetti dell’Ordo Missae (riti di ingresso, orientamento della celebrazione e riti del venerdì santo), sia più in generale dell’inclinazione “centralista” della Riforma Liturgica postconciliare, possano trovare buoni fondamenti e debbano entrare profondamente nel dibattito postconciliare, purché si riconoscano due “condizioni” di questa tua attuale considerazione:
- che essa è possibile proprio come “ripensamento” interno all’atto riformatore. Ossia che gli aspetti “nuovi” del rito antico appaiono solo perché un atto riformatore complessivo ha mutato l’approccio globale verso l’azione liturgica, riconoscendo i limiti della teologia e della prassi precedente;
- che essa può avere una sua plausibilità e pertinenza solo se si resta tutti implicati “nella stessa storia comune”. La differenziazione “opzionale” tra VO e NO crea, invece, la condizione straniante per cui si rende di fatto “opzionale” il cammino ecclesiale di Riforma, non lo si considera più necessario e ci si può “chiamare fuori” da esso. E questa critica, ripeto, non è solo per le esigenze di una “epistemologia giuridica”, ma per l’imporsi del sensus ecclesiae e sensus fidei.
L’anno della approvazione del MP Summorum Pontificum scrissi una replica al modo con cui A. Scola, nella Prolusione all’ILP di S. Giustina di quell’anno, aveva ritenuto di armonizzare il rapporto tra “lex orandi” e “lex credendi” dopo SP. In quel testo (qui) facevo notare la debolezza teologica e liturgica della “finzione” che SP introduce nella esperienza ecclesiale e che non si riesce a giustificare se non arrampicandosi sugli specchi della terminologia tradizionale.
Per concludere, vorrei riferirmi allo stesso esempio che tu fai, alla fine della tua lettera. Tu paragoni la condizione liturgica attuale ai passaggi “generazionali” di arredamento dei nostri appartamenti. La modernizzazione di 60 anni fa non esclude affatto che oggi, nelle stesse case, si cerchino “pezzi antichi” per vivere in modo più ricco e più pieno la esperienza domestica.
La tua “similitudine” intercetta una esperienza profonda, che riguarda inevitabilmente anche la Chiesa, esattamente come il mondo. Mondo in cui si cerca dall’antiquario la credenza o la tavola di 200 anni fa, ma avendo in casa wifi, cancello elettrico, 3 automobili con cruise control, pannelli solari e raccolta differenziata dei rifiuti.
D’altra parte il mondo civile stenterebbe a capire che in Chiesa si estremizzi questa opzione. E si allestiscano addirittura “due case”, una tutta moderna e l’altra tutta antica, e che ciascun membro della famiglia, di volta in volta, possa vivere qui o là, a seconda dei suoi affetti, attaccamenti o stati d’animo.
Se proviamo a pensarla fino in fondo, vediamo bene che la “soluzione” prospettata da SP è un rimedio peggiore del male. Perché, per affrontare questioni reali, sceglie la via peggiore, ossia quella di “spaccare l’unità”. Forse proprio l’esempio che tu hai fatto permette di pensare fino in fondo la questione, che formulerei così, in due proposizioni di principio, per continuare a discutere, con tutta la accuratezza necessaria:
a) La Riforma Liturgica deve essere considerata “necessaria”, ma “non sufficiente”. Merita riprese critiche, discussioni, approfondimenti e correzioni;
b) La continuità con la tradizione, però, si trova solo “dentro la riforma”, non accanto, prima o sotto di essa. La Chiesa ha una “casa rituale comune”.
Avendo negato di fatto entrambi questi principi (assumendo di fatto la Riforma come “non necessaria” e quindi come “aggirabile” in un altro appartamento) SP alimenta una “rottura” della tradizione comune. Una percezione “tragica” della Riforma – che trapela chiaramente dal testo autobiografico considerato – impedisce di riconoscerne la “fragile profezia”. Per questo il superamento della “finta soluzione” offerta da SP significa riprendere oggi le tue belle osservazioni, sui diversi livelli, ma non in un “altrove” artificiale, bensì nell’unica casa comune, quella del rito romano del 1969. Che proprio perché è “definitivamente comune”, può essere valutato, corretto, precisato, rimodulato, nel cammino fedele e creativo della tradizione ecclesiale.































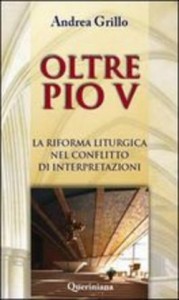
 Area personale
Area personale











