Per un confronto aperto ed efficace tra teologi e canonisti sul matrimonio
La teologia del sacramento e la legge della Chiesa.
Dibattito intersinodale e svolta pastorale.
Anche in seguito a alle dure prese di posizione di giuristi e di teologi nel corso del recente dibattito intorno al Sinodo straordinario e ai suoi possibili sviluppi, appare evidente una serie di implicazioni che si possono desumere da tale dibattito:
– una pastorale di “accompagnamento” delle famiglie felici e infelici necessita di strumenti concettuali e pratici rinnovati. La tradizione cattolica ha una teologia del matrimonio che spesso si identifica con una competenza canonistica, priva di vera profondità teologica e basata su concetti superati e inadeguati.
– ciò non significa contestare o cambiare la dottrina della Chiesa, ma tradurla e trascriverla in un contesto e per esigenze che sono obiettivamente mutate; l’ esigenza di cambiamento non viene anzitutto dall’esterno ( dal mondo, dalla società, dalla cultura…) ma dall’interno della stessa Chiesa, dalla sua ecclesiologia e dalla sua ecclesiologia.
– questa “riforma” deve essere allo stesso tempo della mentalità e delle procedure. Per questo deve riguardare una nuova intesa, profonda e articolata, tra pensiero teologico e mediazione canonica. Il ruolo del diritto canonico, nonostante i limiti evidenti, rimane fondamentale e assolutamente decisivo per una buona soluzione pastorale.
Sotto questo profilo bisogna concordare.con l’analisi di un fine giurista come Carlo Fantappiè, che ha di recente pubblicato un saggio sul tema “Ecclesiologia e canonistica nel post-concilio” (“Periodica” 103[2014], 165-205) che oggi si rivela del tutto pertinente al dibattito sviluppatosi intorno al Sinodo. La questione che egli solleva deve essere seriamente considerata, per dare una risposta adeguata alle legittime aspettative che attraversano il corpo ecclesiale.
Per favorire una Chiesa capace di un’ “arte dell’accompagnamento” – come dicono bene i Lineamenta in vista del Sinodo del 2015 – occorre uscire da una lettura ecclesiologica della Chiesa che, in alcuni giuristi autorevoli, è rimasta, sostanzialmente, quella del Vaticano I. Ed è proprio la condizione di “separatezza” del diritto rispetto alla teologia – favorita dalla codificazione del 1917 – ad aver accentuato oggi, in modo forse sorprendente, una funzione retrograda e chiusa del diritto canonico rispetto alle logiche nuove. Se la teologia lascia il diritto scivolare in una ecclesiologia ottocentesca, non riuscirà a creare le condizioni per una vera riforma.
Qui si evidenzia, in modo assai significativo, il valore iniziale, ma provvisorio, della proposta avanzata con coraggio dal card. W. Kasper. In essa, infatti, parlava la buona intenzione di una svolta, declinata, in una fase iniziale, soltanto sul piano della identità dei singoli battezzati. Il “singolo” battezzato divorziato e risposato, in quella proposta, poteva ottenere, con le dovute modalità, riconciliazione e comunione ecclesiale. Il limite di questa proposta, come già segnalato dallo stesso suo autore, consiste proprio nel precludersi, intenzionalmente, ogni giudizio sulla condizione di “comunione giuridica” del soggetto in relazione di coppia. In qualche modo essa acquisisce la comunione sacramentale del singoli a scapito della comunione giuridico-cononica dei due. Il singolo cristiano scopre di appartenere alla Chiesa, può comunicarsi, ma vive una condizione sostanziale di “nuova unione” su cui non si dice nulla.
Viceversa l’approccio giuridico, che si oppone a questa soluzione, fa valere semplicemente la contraddizione tra una comunione sacramentale possibile e la mancanza di comunione formale e canonica. Per questo la posizione di questi giuristi, formalmente, radicalizza il contrasto: se vi è matrimonio rato e consumato non si può accedere alla comunione sacramentale quando sussista una condizione di vita contraddittoria rispetto a quel legame. Se invece il legame rato e consumato risultasse nullo, allora sarebbe possibile accedere alla comunione sacramentale nella condizione di una “seconda unione” che potrebbe allora essere riconosciuta come “prima” e “unica”.
Non è chi non veda come questo ragionamento canonico dipenda da un approccio “metafisico” alla tradizione matrimoniale: se c’è, il vincolo deve esserci e non può non esserci. Se invece appare in crisi è perché non c’è mai stato. L’essere del matrimonio appare, in questa visione, destoricizzato e assolutizzato, al di sopra e al di là della coscienza dei soggetti. La storia dei soggetti non ha e non può avere alcuna rilevanza.
In certo modo, proprio sul piano del “diritto matrimoniale” può essere fatta valere una opzione “contro la libertà di coscienza”. La quale può valere come una sorta di “ultima trincea” per resistere alla modernità, al Vaticano II e a Dignitatis Humanae. Almeno nel matrimonio, sembra possibile trovare un “fronte” di resistenza della ecclesiologia del Vaticano I. Di fatto, il modello di argomentazione e di pensiero del diritto matrimoniale favorisce obiettivamente questa opzione “autoritaria” nel promuovere la comunione.
Come è evidente, se un approccio teologico, pur illuminato, lascia fuori dalla considerazione la realtà della “nuova unione”, finisce per favorire una lettura canonica basata su un approccio alla realtà familiare di carattere formalistico. La teologia e la pastorale debbono dunque promuovere un approccio giuridico rinnovato e fedele alla svolta del Concilio Vaticano II. Senza un rapporto strutturale tra teologia, ecclesiologia, pastorale e diritto canonico, del problema del matrimonio nella Chiesa contemporanea non si potrà venire a capo, se non per dettagli marginali, che rischierebbero di risultare contraddittori rispetto all’assetto complessivo del tema e del sistema.
Ciò significa che una “svolta pastorale”, per essere tale, deve modificare la legge canonica e alimentare un approccio diverso alle questioni in gioco. Questo è un compito tutt’altro che semplice. Poiché la crisi del modello classico di matrimonio e di famiglia, il ripensamento profondo dei rapporti tra consenso, consumazione, la trasformazione della intimità e la sentimentalizzazione del matrimonio, hanno cambiato anche il sacramento e le sue logiche. Di fronte a ciò il diritto canonico rischia di restare totalmente isolato e di reagire in modo apologetico o moralistico al mutamento della cultura e della fede. Un tale diritto canonico non servirebbe più la Chiesa, ma solo i canonisti.
Si tratta, quindi, di un compito di “traduzione” e di “trascrizione” della tradizione matrimoniale – della fedeltà, della indissolubilità, della generazione, del bene dei coniugi e del bene della famiglia – in un contesto che è mutato non solo sul piano culturale, ma anche su quello ecclesiale. Nel dibattito sulla “comunione ai divorziati risposati” ci si interroga molto sui diritti e sui doveri dei divorziati risposati, come se fosse una cosa ovvia e ovviamente immutabile il significato del “fare la comunione”. In realtà, negli ultimi due secoli, non è cambiata soltanto la società e la cultura della intimità, ma è cambiata la forma della intimità eucaristica della Chiesa con il suo Signore. Il diritto non corrisponde più non solo alla società in cui vive il cristiano, ma alla risoluzione ecclesiale di rileggere la giustizia all’interno dell’orizzonte ampio e sorprendente della misericordia, e non viceversa. Per provvedere ad una Chiesa che si riconosce come “ospedale da campo” occorre metter mano, coraggiosamente, ad alcuni snodi giuridici fondamentali, senza toccare i quali la Chiesa dovrebbe agire, anzitutto contro se stessa.
La reazione “sopra le righe” di alcuni teologi e giuristi al cambiamento di stile voluto da papa Francesco indica precisamente la urgenza di questo compito: recuperare un diritto ecclesiale veramente al servizio della svolta pastorale. Per farlo occorre impegnarsi, teologicamente, in un ripensamento del “paradigma matrimoniale”, in una società mutata e in una chiesa rinnovata. Il binomio Concilio e Codice, che tanto stava a cuore a San Giovanni XXIII, deve tornare di urgente attualità. Le difficoltà di collaborazione tra teologi e canonisti – rilevata correttamente da Fantappié nel saggio citato – deve oggi lasciar spazio a un fecondo confronto, nel quale non si cada nella polarizzazione tra una teologia che pensa una riforma guardando solo ad un futuro un poco utopico e una canonistica che la ridicolizza guardando solo indietro, verso Trento e il medioevo.
Forse proprio un “tema definito” come il matrimonio e le sue crisi potrebbe favorire, da subito, un mutamento di atteggiamento. Perché il teologo possa additare una riforma che assuma forme istituzionali adeguate, senza fuggire nelle astrazioni o nelle istanze generiche, e perché il canonista non diventi il difensore dello status quo e non scivoli, progressivamente indietro, dal Vaticano II al Vaticano I e da questo alle magnifiche sorti, e regressive, del tridentino. La teologia e il diritto debbono servire l’ospedale da campo. Solo collaborando in modo nuovo possono aiutare la Chiesa a annunciare il Vangelo e a realizzare la pace della comunione. Sinodo indica “cammino comune”: oggi esso appare come un cammino necessariamente comune anche tra teologi e canonisti.


























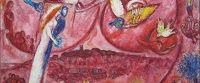
 Area personale
Area personale











