Sulla metafisica e i suoi linguaggi: 1/ (di Marco Cavaioni)
Anche dalle “navigazioni” sulla rete può accadere di fare buoni incontri e di promuoverne anche di migliori. Così, per conoscenze personali, accademiche o virtuali, siamo arrivati a definire una serie di “spazi” di riflessione, che ruotano attorno al testo “Metafisica concreta” di M. Cacciari e che si spingono ad offrire sintesi, contrasti, ermeneutiche e paradossi, nel campo di quel sapere che da almeno 2300 anni chiamiamo “metafisica”. Per rispettarla, per restaurarla, per superarla o almeno per comprenderla, anzitutto nella sua “incomprensibilità”. Iniziamo con un testo singolarmente intenso e profondo, che propone una rilettura in parallelo di alcuni passi di Cacciari e di Stella, come voci di un pensiero metafisico che, in forme diverse, reclama una inaggirabile centralità. Potrà apprezzare queste pagine solo chi si dispone alla pazienza lenta e accurata della teoresi. Se si sarà accettato questo gioco, con disciplinata analisi, non si resterà delusi. (ag)
Metafisica concreta o Metafisica originaria?
Pensando con M. Cacciari e A. Stella
di Marco Cavaioni
Cosa sia “metafisica” è già questione pienamente metafisica. Forse, anzi, cosa si intenda per “metafisica” è l’intero della questione, l’omne punctum in cui tutto sta.
Se la metafisica non venisse metafisicamente intesa, infatti, si permarrebbe al di qua di essa, credendo di comprenderla. Sicché nella metafisica aut ci si trova originariamente aut essa permarrebbe inaccessibile. Vi è, dunque, un aspetto, peraltro fondamentale, per il quale è da dirsi – come osservava Hegel (Enciclopedia, § 3) circa la Unverständlichkeit della filosofia – che la metafisica non può non essere e sapersi “in-comprensibile”, nel preciso senso che essa non si lascia com-prendere da altro da sé o in altro da sé. Non è com-prensibile a muovere da altro da essa, poiché è intenzione di totalità, rispetto alla quale non vi può essere alterità.
Ma ciò non comporta alcuna chiusura solipsistica o monismo dogmatico, dal momento che ad essere propriamente metafisica è, a nostro avviso, l’intenzione stessa quale domanda di totalità, totalità inconvertibile in oggetto e tale, pertanto, da convertire l’intenzione o “domanda di totalità” in “totalmente domanda”, imponendole cioè di farsi tutto e solo domanda, nient’altro che pura domanda, tensione senza riserve al tutto.
Sulla base di queste prime considerazioni ci chiederemmo se la metafisica, nella sua classicità ovvero originarietà (tale, dunque, da escludere “superamenti”, “novità” ed “originalità”), possa dirsi concreta, nell’accezione etimologica del termine che è, come si sa, da con-cretum (con-cresciuto, cresciuto assieme, costituitosi in relazione ad altro), ovvero se il suo dirsi “concreta”, nel senso appena rammentato, possa contemperarsi con il suo sapersi “originaria”, dunque – parafrasando ancora lo Hegel sopra menzionato – unvermischt (senza mescolanza, pura).
Originaria significa dialetticamente non-altra rispetto ad alcunché e nemmeno identica a tutto ciò che la implica, che la richiede e a cui, dunque, è intrinsecamente presente. Questa è la sua essenziale purezza.
Ora, “puro” può sembrare sinonimo di “astratto”, solo se si presuppone che concretezza sia il con-creto (nel significato indicato), insomma la relazionalità. Ma è bene questo, come ogni presupposto, che la metafisica quale criticità originaria della ragione deve questionare e questiona come atto critico, come critica sempre in atto. Non è metafisico accettare e subire una qualche interpretazione pre-metafisica di cosa sia “metafisica”.
Potremmo, allora, dire così: metafisico è il criterio stesso di cosa sia effettivamente “concretezza”. Tale concretezza deve esibire, in altre parole, essa stessa carattere metafisico.
Con questo ci troviamo effettivamente in medias res rispetto ad uno dei gangli centrali della questione, vale a dire la metafisica come interrogazione “sul” tutto (o intero) della cosa o, con terminologia classica, sull’ente in quanto ente, che è la “cosa” stessa del pensare: ciò che Aristotele (Metafisica, A 3, 984 a 18) e, prima, Platone (Lettera VII, 341 c) indicavano in termini equivalenti, rispettivamente come autò tò prâgma e tò prâgma autò.
Tale snodo è, a mio avviso, con molta chiarezza indicato in due brevi passaggi che estrapolo da due recentissime opere di metafisica di due tra i massimi pensatori italiani viventi: Massimo Cacciari con la sua proposta di “Metafisica concreta” ed Aldo Stella, erede e rigorizzatore della scuola patavina di “Metafisica classica” o “Metafisica originaria”, se si preferisce.
Il senso della “concretezza” della metafisica, la quale, se non fosse concreta in sé (dunque, originariamente), non lo sarebbe mai, poggia su e fa tutt’uno con la concretezza del senso dell’ente in quanto tale, o dell’essere dell’ente (ossia dell’ente nel “suo” essere), che dalla metafisica soltanto viene inteso.
Ma ecco subito il punto: cos’è l’ente in se stesso, l’intero dell’ente? Più radicalmente: si può incontraddittoriamente fare dell’intero il “domandato”? Oppure l’intero controlla, condizionandolo, il porsi stesso della domanda? Se, come riteniamo, vale il secondo corno dell’alternativa, allora esso varrà come prerequisito (cosa ben diversa da presupposto) del domandare autenticamente metafisico, ché farne un oggetto di domanda sarebbe “fisicizzarlo”, appunto perché oggettivato.
Il domandare è attestazione, già essa stessa metafisica, dell’insufficienza a sé del “fisico” (dei tà physiká), dell’incapacità cioè di esibire in sé la propria ragion d’essere da parte di tutto ciò intorno a cui si domanda e che, in quanto risolventesi nell’atto del domandare, si rivela per ciò stesso non assoluto.
Si potrebbe dire: si domanda nell’intero, non l’intero. Di più, si domanda in virtù dell’intero. Questo perché la domanda è la presenza stessa dell’intero quale principio di problematizzazione, quale presenza-assenza problematizzante, che rivela l’intrinseca problematicità di ogni sua pretesa determinazione: «abissale presenza della verità assente» era la formula icastica, utilizzata da G.R. Bacchin (Anypotheton, Bulzoni, 1975, p. 16), abissale ed abissante ogni sua pretesa “fisicizzazione”.
Vorremmo, ora, lasciare parlare i due Autori, che peraltro, così accostati, ci paiono dialogare idealmente tra loro, come avviene, in verità, sempre a chi si rivolge al fondamento stesso di ogni discorso. Ci limiteremo, dunque, a qualche semplice annotazione incidentale a margine delle loro già chiare parole, onde esplicitarne la portata e cercando di coglierne le implicazioni teoretiche.
Osserva Cacciari che «tutte [le forme dell’apparire] sempre si riferiranno alla sostanza kath’hautó dell’ente, che ponendo la propria determinatezza pone insieme il proprio essere in relazione col Tutto. Se si opponesse tale determinatezza all’infinità del Tutto, si farebbe del Tutto una parte, cadendo in palese contraddizione» (Metafisica concreta, Adelphi, 2023, p. 297).
Questa prospettiva, che egli chiama «anche philagathía, ricerca del valore ultimo dell’essere-bene, agathón, dell’essente», impone un’indagine «che non può svolgersi che a partire dalla sostanza kath’hautó, dalla singolarità non riducibile ad altro […], singolarità che non esclude, ma implica l’essere in relazione e i modi in cui l’essere-in-relazione può venir predicato» (Ivi, p. 377).
Il problema è decisamente se l’intero dell’ente (l’essere dell’ente), l’intero metafisicamente inteso – intero che vale “in-dividuo”, indivisibile, ergo irrapportabile, da non confondersi con “isolato” in una separatezza empirica – possa venire declinato e definito come un plesso sintetico, ovvero come una composizione di momenti o aspetti (entrambi essenziali!), il che è quanto ci sembra voglia proporre Cacciari, ma non solo.
Dichiarare “originaria” tale sintesi non significa risolvere le aporie (o la contraddizione?) che essa comporta e che non si pongono soltanto, seguendo Cacciari, nel caso in cui «si opponesse tale determinatezza all’infinità del Tutto», poiché non è soltanto la modalità oppositiva (esclusivo-disgiuntiva) della relazione a porre capo alla contraddizione di un Tutto ridotto a parte (in quanto termine opposto), ma tale contraddizione ci pare sia l’esito di qualsivoglia pretesa di riferirsi (relazionarsi) al Tutto, riducendolo giocoforza a termine relato.
Non si vede, insomma, come si possa evitare la contraddizione, che è implicata già dal mero riferirsi al Tutto, che, in quanto termine (non necessariamente opposto), risulterebbe essere parte, dunque parte del Tutto ovvero di se stesso, risultando, quindi, contraddittoriamente “tutto e parte”, “tutto e non-tutto”.
Ad una siffatta conseguenza – non tanto aporetica (problematica), quanto realmente antilogica (contraddittoria) – non sembra, dunque, riuscire a sottrarsi nemmeno l’indicazione cacciariana.
Le ragioni di tale esito ci sembrano limpidamente espresse da Stella, il quale fa presente che «l’intero domanda di venire inteso come infinito, ossia come assoluto. Al pari dell’assoluto (infinito), infatti, esso non può non escludere ogni relazione estrinseca, che lo dividerebbe in un intero in sé e in un intero per altro, nonché ogni relazione intrinseca, che lo dividerebbe in parti: gli elementi che finirebbero per costituirlo.
Intero e assoluto, pertanto, si rivelano un medesimo: assolutamente intero il primo e interamente assoluto il secondo» (Riflessioni teoretiche, Morlacchi, 2023, p. 26).
Precisamente in ragione della sua assolutezza non è concesso declinare l’essere dell’ente (o intero metafisico o determinatezza indeterminabile di ciascuna determinazione, apparentemente posta) come un plesso sintetico, secondo l’indicazione di Cacciari. Diciamo “apparentemente poste” – riferendoci alle determinazioni in quanto tali –, perché esse appartengono interamente al “loro” fondamento (di nuovo: l’essere, l’intero), ma non vale la reciproca, dunque non vale la coappartenenza (o correlatività) di determinazioni ed essere (fondamento). Se e solo se anche l’essere appartenesse alle determinazioni, queste si configurerebbero come determinazioni dell’essere (come il suo intrinseco determinarsi, il suo essenziale strutturarsi), autorizzando a parlare dell’essere delle determinazioni, dunque a considerarle “poste”.
Ma questo non equivale, forse, a negare l’assolutezza indeterminabile dell’essere, facendone termine di rapporto (un “termine” indeterminabile?), presupponendo che l’assolutezza possa co-esistere col (porsi accanto al) relativo cioè al determinato? Che “assoluto” sarebbe un assoluto in sintesi (in relazione) con il relativo? E che “intero” sarebbe un intero (indivisibile) diviso in se stesso?
La cosa ci sembra ancor più seria, se si tiene presente che l’impostazione perseguita da Cacciari è intenzionalmente anti-riduzionistica, nonché tale da aver a cuore il senso della trascendenza, non ingenuamente contrapposta all’immanenza ovvero altra rispetto all’esperienza, bensì colta nell’esperienza medesima, trascendentalmente.
Diciamo “più seria”, perché Cacciari ci sembra incorrere, sia pure meno scopertamente, nel medesimo errore che egli vorrebbe addirittura correggere. Infatti, sintetizzare assoluto e relativo non può non configurare un problema o, meglio, una vera e propria contraddizione. Innanzitutto, per la ragione che far coesistere nell’intero, cioè nell’assoluto, un aspetto di assolutezza (kath’hautó) e un aspetto di relatività (prós ti) significa eo ipso dividere l’intero in due sezioni: in quanto due ed in quanto correlative, esse non possono non essere entrambe astratte. In secondo luogo – e ciò configura una contraddizione ancor più eclatante – includere l’assoluto nell’intero equivale a non cogliere l’interezza dell’assoluto e l’assolutezza dell’intero.
Se è così, a quale medesimezza (unità) si potranno riferire quei due momenti e quella sintesi (unione), a cui si vorrebbe appunto ridurre l’unità, onde strutturarla ed articolarla intrinsecamente, pretendendo nondimeno di preservarne l’essenziale ed innegabile semplicità, l’assoluta compattezza?
Se si finisce per perdere (in realtà, solo obliare) l’assolutezza – e questo pare inevitabile, sulla base della suddetta impostazione –, si perderà la condizione di intelligibilità in virtù della quale soltanto è possibile cogliere il relativo nel suo intrinseco limite, che lo spinge a trascendere se stesso. Tutto questo a causa dell’assurda pretesa di includere lo stesso assoluto nella relazione (sintesi), fingendo, tuttavia, di mantenerne l’assolutezza.
Chiamare la sintesi “originaria” – insistiamo – non risolve il problema, anzi la contraddizione, ma renderebbe contraddittorio l’originario stesso. Col che, nemmeno potremmo mai saperne incontraddittoriamente la “contraddittorietà”, essendo venuto meno ogni incontraddittorio. Qualsiasi diaporeîn, giustamente caro a Cacciari, sarà, pertanto, precluso, poiché non vi sarebbe nemmeno aporia, ma appunto antilogia originaria. Insomma, se l’intero venisse pensato nel modo in cui propone Cacciari, allora non potrebbe non essere antíphasis, anziché aporoúmenon. Sicché verrebbe a mancare il principio in forza di cui operare il percorso diaporetico.
Vale riprendere, ora, il passo di Stella sopra citato, perché argomenta, con grande chiarezza e rigore, precisamente questa situazione. Egli rileva che se «si negasse che intero e assoluto sono un medesimo, allora si dovrebbe indicare la differenza che sussiste tra di essi, differenza che l’assoluto non può non negare – stante che non ammette un altro da sé – e che nemmeno l’intero può accettare. Dove dovrebbe porsi, infatti, tale differenza? Non tra l’intero e l’assoluto, […] ma nemmeno nell’intero, perché ciò comporterebbe ancora la distinzione dell’intero in un “in sé” e in un “per altro”, la quale negherebbe proprio l’intero, riducendolo alla sintesi di due componenti diverse fra loro.
La distinzione di intero e assoluto posta nell’intero, inoltre, farebbe dell’assoluto un momento dell’intero e ciò non potrebbe non configurare una contraddizione.
Del resto, coloro che intendono l’intero nel senso della sintesi di elementi, ebbene costoro eo ipso lo riducono a composto e, cioè, riducono l’assoluto ad un insieme di parti relative (proprio in quanto parti che si riferiscono reciprocamente), sì che l’assoluto finisce, contraddittoriamente, per dipendere dal relativo» (Ivi, p. 27).
Ci sembra che si imponga, a questo punto, la necessità di distinguere – dialetticamente, ovvero senza assumerli come complanari, cioè in continuità analogica tra loro – i due livelli, ampiamente tematizzati da Stella: il livello dell’inevitabile in cui ci si colloca per il fatto stesso di (tentare di) dire l’indicibile ossia l’assoluto e il livello dell’innegabile, a cui corrisponde la coscienza teoretica, direi autenticamente metafisica, dell’innegabile “fisicità” di ogni inevitabile dizione dell’indicibile, cioè della contraddittorietà – innegabile, appunto! – di ogni tentativo di determinare l’indeterminabile e, pertanto, la coscienza dell’impossibilità di assumere tali tentativi, necessariamente fallimentari, come costitutivi dell’innegabile (dell’assoluto, dell’intero), che pur originariamente (innegabilmente) non può non costituire l’inteso ossia l’esigito del discorso metafisico.
Vorremmo esporre tale essenziale discrimine con due ultimi riferimenti testuali dei teoreti con i quali abbiamo cercato di pensare queste “gigantesche” questioni.
Richiamandosi espressamente a Florenskij, da cui mutua la nozione stessa di “Metafisica concreta”, così esprime Cacciari il senso del “rapporto” che intercorre tra Uno (verità, assoluto, essere, intero) e Molteplice (dimensione “fisica”, piano del finito-determinato): «Il páthos del realismo consiste nel cogliere l’ek-sistere dell’uno verso i molti e dai molti al Tutto, nel respingere ogni isolamento solipsistico dell’uno. […] L’apparenza, l’Erscheinung, il dominio dei tà physiká, vero-reale e nient’affatto illusorio, è trascendenza in sé stesso, ‘apre’ all’inosservabile, a ‘ciò’ che possiamo indicare propriamente come Ab-solutum solo in quanto non predicabile secondo le categorie dell’intelletto. La manifestazione lo incarna, pur senza risolverlo in sé» (Op. cit., p. 410).
Decisivo è capire cosa comporti questo “senza risolverlo in sé”. L’Autore, poco sotto, lo precisa meglio, ma ribadendo, a nostro avviso, il punto di difficoltà speculativa (su cui lasceremo, infine, parlare Stella, con il quale Cacciari mostra indubbiamente motivi di affinità teoretica ma altrettanto forti differenze).
Non si può non convenire con Cacciari che «non è pensabile equivalenza tra rappresentazione e integrità dell’essere, ma nell’esprimerla, con ciò stesso, essa si presenta come un infinito convergere» (Ivi, p. 412). Senonché, sembra che quella assolutezza o integrità (l’intero metafisico) debba intendersi, iuxta Cacciari, come infinità (cattiva?) delle trame relazionali, essendo per lui “metafisica” «l’attenzione per l’inosservabile dello stesso osservabile, in quanto questo, sub specie aeternitatis, rimane avvolto nell’Infinito. Nient’affatto uno sguardo teso a un al di là dell’essente, ma, all’opposto, alla inesauribile ricchezza del suo essere-relazione» (Ibidem).
Ci permettiamo di riassumere come segue: per il pensatore veneziano la “traduzione” dell’intero (del vero, dell’essere) nelle «schegge» mondane dell’unica verità celeste, seguendo una citazione di Florenskij (p. 411), non sarebbe un mero “tradimento”, sia pure inevitabile, dell’unica assoluta verità, ma vi sarebbe, al contrario, una circolarità virtuosa in termini di exitus-reditus tra assoluto e relativo (infinito e finito), tale per cui, in termini ora anassimandrei, «[d]all’ápeiron i kósmoi, dal ‘distacco’ dall’Infinito ogni essente finito, che pone sé stesso op-ponendosi agli altri, e che di nuovo nell’Infinito si risolve». Vi è, per Cacciari, una sola Physis e, dunque, concretezza sarà non porre il principio metafisico (l’ápeiron) come «un vago Astratto», come «l’assolutamente inosservabile», bensì come «‘ciò’ che si rivela nell’indefinito numero dei kósmoi e in sé di nuovo li riassume» (p. 409).
Ora, in questa sede non ci è possibile mostrare, come sarebbe opportuno, la profonda distanza dell’interpretazione del celebre frammento di Anassimandro data da Cacciari, nonché da Severino e Heidegger (a cui ci sembra affine la lettura cacciariana) rispetto a quella fornita da Stella, sicché ci limiteremo ad invitare a confrontare la visione che Stella esprime, criticando Severino e Heidegger, del senso irriducibilmente meta-fisico dello ápeiron nell’articolo La relazione come fondamento nella lettura di Anassimandro offerta da Heidegger e da Severino, scritto con G. Ianulardo ed apparso in «La Filosofia Futura» (8, 2017, pp. 85-97), successivamente ripreso ed approfondito nella Parte Prima, Capitolo I del volume Sul riduzionismo (Quaderni di «Cum-Scientia», Aracne, 2020, pp. 19-60).
Ci sembra possa valere quale replica alla lettura di Cacciari la seguente breve e pregnante considerazione del teoreta perugino circa la dinamica che, in termini aristotelici, sembrerebbe accreditare un’impostazione come quella di Cacciari, tale per cui le determinazioni sarebbero molteplici modi in cui l’indeterminabile si manifesta “concretamente” e “positivamente”, sia pure con il caveat cacciariano-heideggeriano di intendere tale apparire come un ri-velarsi (un mostrarsi sottraendosi, un sottrarsi mostrandosi).
Ad avviso di Stella «[…] l’interpretazione fornita da alcuni filosofi [a cominciare da Aristotele, che afferma che “l’essere si dice in molteplici significati”, Metafisica, Γ 1003 a 31], secondo la quale la molteplicità degli asserti corrisponderebbe alla molteplicità dei modi usati per indicare la medesima realtà – modi che risultano, appunto, in opposizione gli uni con gli altri e che pertanto tendono ad escludersi reciprocamente –, non è affatto condivisibile.
Tale interpretazione dà per scontato il fatto che i molteplici modi risultano legittimati dalla cosa reale, cioè da quella realtà che non può non permanere la medesima.
Ciò che obiettiamo a questa interpretazione è quanto segue: se la cosa legittimasse effettivamente i modi e se questi ultimi valessero come autentica espressione dell’unica realtà, allora il conflitto tra i modi (significati, asserti) espliciterebbe non altro che il contrasto intrinseco, cioè la contraddizione, che dovrebbe sussistere nella cosa reale. Di contro, per lo meno a nostro giudizio, la pluralità dei modi – ed il conflitto tra di essi – attesta proprio l’irriducibilità della cosa reale alle forme che pretenderebbero di rappresentarla e che il discorso offre, così che la contraddizione risulta intrinseca e costitutiva del discorso e delle sue forme. Si tratta, insomma, della contraddizione immanente ad ogni tentativo di esprimere, positivizzandola, la realtà autentica» (Op. cit., pp. 377-378).
Quale delle due concezioni metafisiche risulta, alla fine del discorso che abbiamo cercato di svolgere, effettivamente convincente?
Da un lato abbiamo la proposta di Cacciari, la quale muove bensì dall’innegabile necessità del fondamento assoluto, che non può non essere inoggettivabile (indeterminabile, inosservabile) ma, poi, finisce per vincolarlo a quella coappartenenza ai molteplici modi (determinabili, osservabili), così da includerlo nella relazione con questi ultimi, negando per ciò stesso tanto la sua assolutezza quanto la sua indeterminabilità.
Dall’altro lato abbiamo la proposta alternativa di Stella, il quale prende seriamente l’assolutezza del fondamento, cosicché quest’ultimo non può non venire inteso come il fondamento incondizionato che condiziona unilateralmente gli enti (i determinati), rivelando l’insufficienza ontologica di ciascuno e di tutti i possibili modi di esprimerlo. La medesima insufficienza ontologica, peraltro, investe la stessa totalità delle relazioni che si pretenderebbe sussistano tra ciascuna determinazione e il loro fondamento (sì da ridurlo a termine della relazione medesima): tanto le relazioni quanto le determinazioni rivelano la loro intrinseca inintelligibilità, sicché la condizione incondizionata non può non imporre il loro toglimento ossia la necessità del loro innegabile negarsi nell’intenzione metafisica di essere e di essere assolutamente (veramente).
Con questa ultima riflessione pensiamo di poter concludere il nostro discorso, pur nella consapevolezza che la conclusione del discorso non è mai la conclusione del pensiero, il quale non può non tornare a problematizzare ogni asserto nonché ogni punto d’arrivo.
Come soleva ripetere il grande metafisico Giovanni Romano Bacchin, tali questioni “da sempre restano da pensare”. Per questo ci sembra debba valere l’atteggiamento di chi, per dire con Gregorio di Nissa, sa di dover «andare di inizio in inizio» (Homiliae in Canticum, 8: PG 44, 941C), poiché in metafisica e, di conseguenza, in tutto «non si è mai finito di iniziare».
Marco Cavaioni































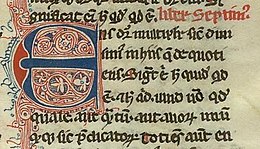
 Area personale
Area personale











