Sinodo e donna: lo spazio del diaconato tra autorità femminile e magistero sulla riserva maschile
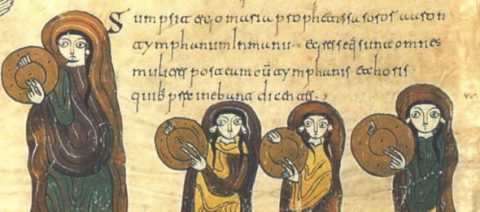
In che modo il magistero cattolico ha affrontato negli ultimi decenni la questione dell’accesso della donna al ministero ordinato? Con singolare determinazione, ha ripreso con audacia il dibattito secolare: esso aveva conosciuto metodi, strategie argomentative e posizioni assai differenziate nel giustificare la esclusione della donna, ed era stato a sua volta profondamente modificato dalla costatazione della entrata tardo-moderna della donna nella vita pubblica, ma ora si trasforma in una teologia positiva e in una teologia di autorità. Potremmo dire così: mentre culturalmente la donna acquisiva nuova autorità sul piano pubblico, la chiesa (almeno in apparenza) riteneva di spogliarsi di ogni autorità e di riconoscersi priva della facoltà di far accedere la donna all’ufficio sacerdotale (non al ministero ordinato). Curioso parallelismo: fino a che la donna era culturalmente subordinata, la Chiesa ha avuto al suo interno una discussione sui motivi di questa esclusione. Nel momento in cui la cultura comune è uscita da questa comprensione minorata del femminile sul piano pubblico, la Chiesa cattolica ha concentrato la propria attenzione soltanto su due piani:
- da un lato sul “fatto” della riserva maschile attestata da una lunga tradizione e attribuita addirittura ad una “libera scelta” del Signore Gesù (con una riduzione “positiva” della questione come la tradizione precedente non aveva mai fatto)
- dall’altro sulla “autorità” con cui questo fatto viene dichiarato appartenere alla “divina costituzione della Chiesa” e quindi da tenersi come definitivo (senza però impegnarsi in una “definizione infallibile”)
Questo doppio registro, su cui si attestano prima Inter insigniores e poi Ordinatio sacerdotalis, sposta la questione della “dignità della donna all’esercizio della autorità ecclesiale” sul piano opposto: da un lato sulla costatazione che la storia ci dà un modello esclusivamente maschile di ministero sacerdotale, dall’altro sulla natura “dottrinale” e “definitivamente vincolante” di tale riserva maschile. In questo modo, per confermare la chiesa nella fede, il magistero trasforma la discussione sul ruolo della donna in una discussione sulla obbedienza della fede. Dal 1994 è facile vedere che chi discute la possibilità della donna di accedere al ministero ordinato viene prima o poi sospettato di non essere coerente con la fede cattolica. Se la “riserva maschile” è di “diritto divino”, ogni discussione sembra minacciare la “costituzione divina della Chiesa”. Il che appare obiettivamente esagerato, perché tende a porre sullo stesso piano la Immacolata concezione, l’Assunzione e la esclusione del sesso femminile dalla ordinazione sacerdotale.
Questa impostazione, allo stesso tempo di “teologia positiva” e di “teologia di autorità”, rischia in effetti di avere un effetto distorto sulla discussione intorno al diaconato femminile, perché da un lato “ricerca solo dati storici” e dall’altro “teme di compromettere il principio dottrinale della riserva maschile”. Proviamo a considerare questi due aspetti:
a) La lettura storica dei “fatti”.
Non vi è dubbio che il fatto della presenza della “riserva maschile” sia molto antico e molto coerente per molti secoli. Ma il “fatto” in sé, privato della sua interpretazione, diventa assai vago. Non si possono portare come “prova”, nel 1976, i fatti del III, del XII o del XVII secolo, senza ricordare la interpretazione pesantemente misogina che accompagnava questi fatti. Leggiamo in Tertulliano, in Tommaso, in Suarez o in Scheeben parole irripetibili contro la dignità della donna e delle quali oggi ci vergogniamo senza esitazione. La questione della donna come possibile “soggetto ministeriale” appare solo quando questi pregiudizi contro la sua autorità in pubblico iniziano a declinare. Non a caso questo fenomeno viene chiamato da Giovanni XXIII come un “segno dei tempi”, ossia un elemento della cultura comune che cambia in profondità la comprensione della donna in ogni ambito, privato come pubblico, civile come ecclesiale. Di questa novità, in una considerazione meramente positiva della “riserva maschile”, non si riesce ad avere la minima percezione: lo sguardo resta strabico. In altri termini, la storia che conta, in una argomentazione positiva, è quella degli ultimi 200 anni, nei quali la evidenza della riserva maschile non gode più di una vera autorità, se non rifugiandosi in un passato, dominato però dal pregiudizio misogino.
b) La “riserva maschile” come “dato rivelato”
Il secondo passaggio è la rivendicazione con cui la autorità ecclesiale considera la “riserva maschile” come appartenente alla “divina costituzione della Chiesa” e quindi come un dato originario che deve essere considerato e riconosciuto come definitivo. Qui si pongono alcune questioni che meritano una accurata discussione:
- La tradizione ha svolto la discussione teologica sul tema della “ordinazione della donna” con due stili diversi: da un lato includendo il sesso femminile tra gli impedimenti alla ordinazione, dall’altro facendo del sesso maschile un requisito della sostanza del sacramento dell’ordine. Ma sempre argomentando l’impedimento o il requisito e non assumendolo semplicemente come un fatto.
- Una “teologia di autorità”, così come adottata da OS, conosce due gravi limiti: da un lato tende a lasciare “con la testa vuota” chi domanda ragione (così dice Tommaso d’Aquino), dall’altra esige comunque delle ragioni a sostegno del dato storico (così diceva già nel 1994 J. Ratzinger).
- L’effetto diretto di questa soluzione è la pretesa di orientare la riflessione soltanto per giustificare la riserva maschile. Ma qui, dobbiamo ammetterlo, i piccoli tentativi che troviamo in Inter Insigniores e le costruzione dottrinali che sono state offerte al tempo o successivamente (da Von Balthasar o da Menke o da Mueller) lasciano piuttosto delusi: i principi elaborati sono solo rielaborazioni dei pregiudizio classici e lasciano isolato e molto esposto il radicalismo della posizione magisteriale sulla riserva maschile, che appare “posta” ma non “giustificata”.
Dottrinalizzazione della riserva maschile e imbarazzo nel giustificare la “differenza femminile” come non discriminatoria lasciano aperto il campo intermedio del diaconato, su cui è possibile elaborare un pensiero più accurato perché meno pregiudicato. Vediamo perché.
c) Il “punto medio” del diaconato
In primo luogo dobbiamo precisare che il diaconato, come grado più basso del ministero ordinato, costituisce un caso di “ordinazione” in senso stretto. Ordinare una donna diacono significa superare l’idea classica per cui la donna non può ricevere la ordinazione. Questa, però, non essendo una “ordinatio sacerdotalis” non cade sotto la dichiarazione di definitività della “riserva maschile” assunta da OS. Inventare un “diaconato femminile” diverso e non ordinato, per non alterare la riserva maschile per tutto il “ministero ordinato”, apparirebbe un escamotage molto simile ad una insopportabile ghettizzazione ecclesiale e teologica.
In secondo luogo, la ordinazione diaconale delle donne può avvalersi del precedente di Spiritus Domini, con cui è caduta la riserva maschile per i “ministeri istituiti”. Quando gli antichi parlavano di “riserva maschile”, pensavano in modo unitario l’intero campo degli ordini, dalla tonsura alla ordinazione sacerdotale: tutti gli ordini erano riservati ai “viri”. Oggi abbiamo, sullo stesso campo, una grande differenziazione: i gradi iniziali sono senza riserva, gli ultimi due (presbiterato e episcopato) sono riservati, ma del diaconato è possibile definire la accessibilità femminile, non essendo una “ordinazione sacerdotale”. Si deve notare che il superamento della “riserva maschile” per i ministeri istituiti non è fondato storicamente, ma sistematicamente. Una nuova evidenza della autorità femminile lo rende possibile.
In terzo luogo lo spazio intermedio del diaconato potrebbe consentire di rileggere l’intera vicenda dell’ultimo secolo come una complessa mediazione tra una nozione di donna, che la cultura contemporanea ha profondamente modificato e arricchito, e una lettura “apologetica” con cui la Chiesa cattolica, non trovando più ragioni convincenti per giustificare la riserva maschile, l’ha trascritta sul piano del mistero, chiedendo obbedienza di fede sul fondamento di una prassi storica anziché comprensione teologica in relazione alle evidenze del presente e del futuro. Bisogna riconoscere che non sempre l’ideale di una “teologia in ginocchio” è del tutto giustificato. Piegare il ginocchio solo davanti al nome del Signore significa non piegarlo di fronte agli idoli che pretendono di sostituirlo. Tra i quali ci sono anche quei pregiudizi che nella donna confondono la differenza con la inferiorità e che per difendere la sua differenza negano la sua autorità ecclesiale, fino al punto di fare, di questa negazione, addirittura un oggetto di fede.


























 Area personale
Area personale












Professore, se possibile ci chiarisca meglio cosa intende per “autorità ecclesiale”. La ringrazio.
Dipende dai contesti. Se riferita alla donna indica la svolta culturale riconosciuta da Giovanni xxiii e spesso misconosciuta dopo di lui