Le parole e le cose, grazie a Francesco e dopo Francesco
Se è vero che lo stile con cui Francesco ha scelto di esercitare il proprio ministero è stato largamente da lui mutuato dal Concilio Vaticano II, allora non è difficile pensare che una delle caratteristiche fondamentali di quel concilio sia stata di essere stato anzitutto un «evento linguistico». Questa definizione, che dobbiamo in larga parte a teologi americani (statunitensi e canadesi, come O’Malley e Routhier), si può usare, mutatis mutandis, anche per il pontificato di Francesco: da Evangelii Gaudium, fino a Desiderio Desideravi, per coprire quasi un decennio, abbiamo letto una serie di documenti in cui appariva non raramente, almeno nei passaggi più arditi, una audacia espressiva e una immaginazione teologica di nuovo conio. Dobbiamo chiederci da dove venga questo “uso delle parole”, che cambia l’esperienza, e quale impatto abbia avuto e possa avere, in futuro, nel rapporto con le “cose”. Possiamo chiederci come stia nell’insegnamento di Francesco il rapporto tra le parole e le cose.
Le parole
L’evento che abbiamo vissuto con il papa “preso dalla fine del mondo” si è materializzato subito nei linguaggi del saluto, della veste, delle benedizione, della preghiera, del tono di voce, dei gesti della mano: un esordio di pochi minuti che è stato una specie di dichiarazione di intenti. Un uso libero del linguaggio verbale e non verbale ha caratterizzato tutto il pontificato, dall’inizio alla fine, dal modo di iniziare fino al modo di concludere e di prendere commiato. Il “lessico di Francesco” si è nutrito abbondantemente di linguaggio comune, di “neologismi” tratti dal parlato popolare, di originali esegesi della scrittura, di interferenze strutturali tra espressioni della letteratura, del cinema, dell’arte e parola del magistero. Questo ha permesso, almeno nei punti più alti della espressione magisteriale di questi dodici anni, di elaborare “espressioni dottrinali” caratterizzate da grande novità, da audacia, da inattesa chiarezza: basta pensare ad alcune formulazioni dottrinali che si trovano in Evangelii Gaudium, in Amoris Laetitia, in Laudato sì, in Veritatis Gaudium, in Desiderio desideravi.
Le cose
Il lessico di Francesco ha faticato a diventare il canone ecclesiale. Qui la somiglianza tra Francesco papa e il Concilio Vaticano II è forte. Come il Concilio ha profondamente inciso sul lessico, ma inciso in misura minore sul canone ecclesiale, così possiamo dire anche del magistero di Francesco. Usare la parola “uscita dalla autoreferenzialità” è diventata una cosa nuova e facile per quasi tutti. Ma entrare in procedure e prassi non autoreferenziali è rimasta cosa piuttosto rara, e sicuramente più difficile. Questo lato “realistico” del papato di Francesco si dischiude con una certa evidenza davanti al suo successore. Come far diventare “cose” le parole di Francesco è la grande sfida, dell’ufficio papale e del corpo ecclesiale. Probabilmente questo implica una “mutazione” che il Concilio e Francesco hanno solo inaugurato. E’ la mutazione dal magistero negativo al magistero positivo. Se non viene curata, si generano testi equivoci, nei quali stanno cose contraddittorie. Per fare due esempi: tra il Proemio e la normativa di Veritatis Gaudium, tra la affermazione di principio e la disciplina di Fiducia supplicans.
Magistero positivo nel suo sviluppo
Il punto delicato è questo: il Vaticano II e poi, nel modo più evidente, il papato di Francesco ha giocato soltanto sul piano del “magistero positivo”. La scelta è stata di rinunciare al “magistero negativo”, ossia ad un magistero fatto di “proposizioni di condanna”. Se il magistero passa da negativo a positivo, tuttavia, cambia il modo di collocarsi rispetto alla storia. Non è più sufficiente “condannare l’errore” per essere nella verità. Occorre dare parole e fare cose in una maniera nuova, cosa che abbiamo iniziato a sperimentare dal 1962. Davvero prima le cose erano impostate diversamente. Nell’apprendistato di un nuovo modo di porre se stessi in rapporto alla verità, cambia in radice la funzione del magistero. Che non deve rincorrere tutti i temi, ma deve riconoscere una autorità plurale all’interno della Chiesa. Questo è un modo di recepire la “società aperta” che non può soltanto basarsi su “slogan”, ma deve prendere la forma di “procedure”. Per farmi capire vorrei fare un esempio. Se un papa afferma “chi sono io per giudicare”, ma non cambia una proposizione dottrinale che giudica in modo netto proprio l’oggetto di cui si parla, si crea una tensione insuperabile tra due istanze che cadono in contraddizione. Lo spazio di mediazione tra legge universale e applicazione particolare (che chiamiamo discernimento) può essere una soluzione frequente, ma non può escludere, anzi talora esige, che si operi non solo una traduzione della disciplina, ma anche un ripensamento e una traduzione della dottrina. Considerare intoccabile ogni proposizione dottrinale è una forma ideologica di fedeltà alla tradizione.
Magistero papale, episcopale, ecclesiale
Una più adeguata soluzione dei “soggetti magisteriali plurimi”, che caratterizza la tradizione ecclesiale, è un compito alla cui definizione lavora la Chiesa da più di 60 anni. Francesco ha introdotto elementi nuovi e importanti, dei quali non potremo più fare a meno. Ma è rimasto ancora molto fedele ad una convinzione duplice: che la vera conversione sia dei cuori e non delle strutture; e che la differenza tra dottrina e disciplina possa continuare a funzionare così come la abbiamo ricevuta dal passato. La eredità che lasciano le sue parole piene di profezia ci consegna un “lavoro sulle cose” che chiede una sapiente opera di traduzione: le forme istituzionali diventano mediazioni delicate e decisive, perché il nuovo lessico prenda forma di cose, di procedure, di evidenze, di riconoscimenti. Un lavoro disciplinare senza una elaborazione dottrinale aggiornata non può avere successo. Aver portato alla luce questa tensione è stato un grande merito storico del pontificato di Francesco. Avviarsi a superarla, mettendo le parole nelle cose sul piano strutturale e istituzionale, potrà essere l’assillo e il munus del suo successore.
Oltre la “nota praevia”
Infine, proprio sul punto del rapporto tra le parole e le cose, è famosa la “Nota previa” che è stata aggiunta in calce (ma con la pretesa di essere in testa) alla Costituzione Lumen Gentium. Se esaminata dal punto di vista del rapporto tra “parole e cose” la Nota svolge la funzione di ribadire il canone del Vaticano I di fronte al lessico del Vaticano II. Il sottotesto può essere tradotto così: «voi parlate pure di “comunione” come verità della Chiesa cattolica, e fate bene a farlo, perché è un linguaggio antico, biblico e liturgico, ma la comunione ecclesiale è solo “gerarchica”, ossia ha nel “potere di giurisdizione papale” la sua verità prima». Curiosa inversione tra potestates, in cui un non sacramento prevale sui sacramenti, prodotta dall’ordinamento giuridico di fronte alla minaccia di un linguaggio nuovo, ritenuto pericoloso. L’ombra lunga della Nota praevia continua ad aleggiare sulle nostre parole e sui nostri gesti: anche sui nostri commenti al Conclave. Il lessico di Francesco, senza una adeguata riformulazione della Nota praevia, rischia di restare una parola che non riesce a incidere sulle cose. Uscire dalla autoreferenzialità implica una teoria teologica della Chiesa e del suo rapporto con il Mistero di Dio, che non sia monopolizzata e quasi ossessionata dalla questione della giurisdizione: questa è una ideologia ottocentesca che anche Francesco ha faticato non poco a superare e con cui il suo successore dovrà fare i conti in modo determinato, proprio a motivo del suo ufficio,































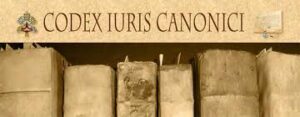
 Area personale
Area personale











