Le amnesie del Card. Koch: su Vetus Ordo e Fiducia supplicans
Quando ho letto la intervista al sito kath.net del Card. Koch intitolata “Papa Leone ha un profondo rapporto con le Chiese orientali” (che si può leggere qui ), ho notato subito che, parlando “per transennam” dell’uso del VO, il cardinale formulava una posizione che lui stesso aveva recentemente negato, e più anticamente affermato. Curiosa oscillazione che avevo puntualmente registrato nel 2011 e poi nel 2020 e di cui si può leggere in due post pubblicati sul mio blog poco più di 5 anni fa (e che si possono leggere qui e qui). Perciò prima di leggere le ultime affermazioni, ricostruiamo brevemente la storia di queste precedenti dichiarazioni.
a) Nel 2011, quindi dopo soli 4 anni dall’inizio della esperienza di “parallelismo rituale”, introdotta avventatamente dal MP Summorum Pontificum, e a poca distanza dal documento “Universae Ecclesiae”con cui la Commissione Ecclesia Dei cercava di ampliare le maglie di SP tentando di renderne più facile l’accesso, Kurt Koch interveniva per sottolineare, allora, il valore ecumenico e di riconciliazione di SP e di UE. Anche alcuni teologi non di seconda fila avevano espresso, negli stessi giorni, un grande entusiasmo verso la “lezione di stile cattolico” che SP e UE avrebbero rappresentato.
b) Nel 2020, tuttavia, sempre K. Koch, di fronte alla esperienza negativa che quei 9 anni di vita ecclesiale avevano dimostrato, anche contro il suo entusiasmo iniziale, diceva cose molto diverse. In una dichiarazione diceva infatti che, alla prova dei fatti, nessuna coesistenza tra le due forme rituali poteva portare alle pace (la dichiarazione si può leggere qui). Parlava di una necessaria riconciliazione, ma senza la possibilità di poter ancora sperare in una “pace liturgica” generata dalla convivenza parallela tra due riti conflittuali. Negli stessi termini, anche quegli stessi teologi, precisavano la mira e prendevano le distanze dai passati entusiasmi.
c) Eccoci dunque al 2025. Le parole pronunciate da Koch sembrano dimenticare totalmente ciò che lui prima aveva detto e poi contraddetto, per esperienza negativa. Koch, forse fidandosi troppo della comune smemoratezza, prova a rilanciare la soluzione del 2011, come se nulla fosse accaduto in 14 anni. Una “impossibile coesistenza” diventa così prospettiva ecumenica di riconciliazione: un salto mortale davvero pericoloso.
Va detto che quando si pronuncia su questo punto, rispondendo ad una domanda specifica, egli precisa di non aver parlato con papa Leone e di esprimere solo il suo giudizio. Ma di quale giudizio si tratta? Di quello del 2011, senza la esperienza successiva? E’ possibile aver dimenticato 14 anni di delusioni? In effetti, nel motivare la sua posizione, egli ripete il sofisma centrale di SP: ciò che è stato sacro nel passato non può non esserlo anche oggi. Ma qui siamo di fronte non a teologia, ma a nostalgia. Con la nostalgia non si amministra la Chiesa, ma si alimentano illusioni. Soprattutto colpisce l’azzeramento della esperienza negativa, che lo stesso Koch aveva apertamente ammesso nel 2020 e che ora sembra essere stata improvvisamente dimenticata. Si tratterebbe di “riaprire le porte” che Francesco aveva chiuso. Questa immagine è grave: non sembra cogliere che non si tratta anzitutto di una questione di disciplina, ma di una dottrina sul valore comunitario dell’atto rituale e della Chiesa che da esso deriva. Questa amnesia sembra inspiegabile. Ma se Koch si è dimenticato ciò che aveva detto, noi ce lo ricordiamo bene, purtroppo per lui, per fortuna per noi.
La medesima perplessità si può notare per le dichiarazioni che emergono dalla medesima recente intervista a proposito della Nota “Fiducia Supplicans”. Le difficoltà delle Chiese orientali, così come anche di molte chiese africane, sulle “aperture” di FS circa le coppie irregolari e omosessuali costituiscono una questione ecclesiale ed ecumenica perché attestano la difficoltà (cattolica e orientale) nel fare i conti con il cambiamento culturale e sociale. Trovo veramente curioso che il cardinale segnali solo le difficoltà e non le opportunità del documento che, per quanto in modo parziale, è uscito dalla idea della “esclusione” della irregolarità dalla grazia e dalla benedizione. Su questo ne verbum quidem. Non si fa buon ecumenismo dando più valore ai pregiudizi che alla grazia. Che cosa avremmo dovuto fare, in passato, sulla schiavitù, sulla guerra, sulla libertà di coscienza? Si può essere ecumenici solo con il principio “quieta non movere”?
Insomma, anche il Card. Koch, pur parlando per lo più di prospettive ecumeniche e del rapporto tra papa Leone e le Chiese di Oriente, non ha colto la occasione per riferire le cose con la dovuta articolazione, senza semplificare le questioni difficili e senza ignorare le esperienze acquisite. Se la comunione da mantenere fosse quella del pregiudizio (sulla pretesa antichità intoccabile del VO e sulla extraterritorialità degli irregolari rispetto ad ogni benedizione) il compito ecumenico consisterebbe nell’infilare la testa nella sabbia, come gli struzzi: senza memoria e senza libertà.






























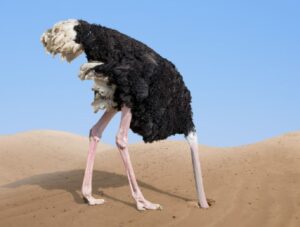
 Area personale
Area personale












Andrea, secondo me non è corretta la tua lettura. Il cardinale semplicemente disse che *alla lunga* si sarebbe ritornati ad un solo rito latino, non che SP fu un fallimento.
La lex orandi divina è, certamente, il nucleo immutabile voluto da Dio: la sostanza del culto che Egli stesso ha istituito e che la Chiesa non può alterare. In essa rientrano, per esempio, la materia e la forma dei sacramenti, la centralità del Sacrificio eucaristico, la proclamazione della Parola, la preghiera in nome di Cristo e della Chiesa. È la dimensione teologica e ontologica del culto, che permane identica attraverso i secoli perché appartiene al deposito della fede.
La lex orandi ecclesiae, invece, è la concretizzazione storica, disciplinare e rituale con cui la Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, esprime e celebra quella lex orandi divina. In essa rientrano le formule liturgiche, le rubriche, il calendario, la lingua, la disposizione dei riti… elementi che, pur essendo sacri e venerabili, sono storici, contingenti, e sono soggetti alla legittima autorità della Chiesa per essere riformati, adattati o sostituiti, purché si conservi la sostanza sacramentale.
Quando diciamo che non possono esserci due lex orandi parallele nel rito romano, ci riferiamo a questa seconda dimensione: la Chiesa, in ogni momento storico, determina una forma unica e normativa della propria preghiera ufficiale, e questa è la lex orandi ecclesiae, che incarna e trasmette la lex orandi divina. Per questo un Papa può cambiare il Messale —come avvenne nel 1570 o nel 1969—, ma non può cambiare la sostanza del sacrificio eucaristico.
Ogni teologo liturgista che adotti integralmente il Magistero e la disciplina canonica vigente non può fare a meno di leggere quella frase di Benedetto XVI, “ciò che per le generazioni precedenti era sacro, permane sacro e grande anche per noi e non può essere improvvisamente totalmente proibito o addirittura dannoso” —pronunciata nel contesto del motu proprio Summorum Pontificum del 2007— in modo strettamente armonizzato con la costituzione Sacrosanctum Concilium, con la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II e con la situazione giuridica successiva alla costituzione apostolica Missale Romanum del 1969, e soprattutto a partire dal motu proprio Traditionis custodes del 2021, che ha riaffermato il Novus Ordo Missae come unica lex orandi della Chiesa di rito romano.
In primo luogo, consideriamo il contesto e lo scopo della frase del papa Ratzinger nella sua Lettera ai Vescovi, la quale aveva il proposito di spiegare loro il senso, i motivi e la portata del motu proprio Summorum Pontificum. Sta di fatto che Benedetto XVI non stava riconoscendo un “diritto” alla coesistenza permanente di due forme parallele della lex orandi ecclesiae, bensì rispondeva a ciò che credeva prudenzialmente corretto in un contesto pastorale come quello del 2007, cercando di sanare divisioni con certi fedeli legati al Messale del 1962. La frase sottolinea un principio di continuità: afferma che ciò che è stato autenticamente santo e fecondo nella vita della Chiesa —nel suo momento e nelle sue circostanze— conserva il suo valore nel deposito della fede e nella memoria liturgica, anche quando non sia più la forma vigente di celebrazione.
Allora, a partire da tale presupposto, qual è l’interpretazione di quella frase di Benedetto, conforme al Magistero attuale? Il valore del “sacro per le generazioni precedenti” non significa che debba continuare a essere norma di culto. La normatività liturgica non va confusa con la venerazione storica. Il fatto che una determinata modalità storica del rito romano sia stata veicolo di santificazione non le conferisce automaticamente uno statuto giuridico nel presente. Paolo VI nel 1969 ha stabilito che il Messale riformato per mandato del Vaticano II esprime l’unica lex orandi del rito romano, e ciò è stato confermato esplicitamente da papa Francesco in Traditionis custodes. Ciò non contraddice Benedetto XVI se la sua frase è intesa in chiave di rispetto della tradizione, non di rivendicazione parallelista.
Perciò dobbiamo tenere presente quale sia il criterio teologico-liturgico che regge qui. La lex orandi è unica perché esprime visibilmente l’unità della Chiesa attorno al sacrificio eucaristico secondo le norme attuali. Il riconoscimento della sacralità delle forme anteriori rientra nell’ambito della tradizione liturgica viva: esse possono essere oggetto di studio, di memoria e, in alcuni casi, di uso ristretto e pastorale regolato, ma non di parità normativa rispetto alla forma ordinaria o modalità vigente.
Come conclusione, è necessario scartare qualsiasi parallelismo liturgico, sia nella forma di interpretare quanto deciso nel 2007 da papa Benedetto XVI, sia in quanto deciso da papa Francesco nel 2021, o in ciò che eventualmente potrà decidere in futuro papa Leone XIV. Quella frase di Benedetto XVI non legittima il mantenimento di due percorsi paralleli della lex orandi, poiché l’esercizio dell’autorità apostolica in materia liturgica può, per ragioni di bene comune e di unità, determinare quale forma sia normativa. Interpretare ciò in modo opposto implicherebbe, come conseguenza, che il Concilio Vaticano non avesse alcun potere di determinare, come invece determinò, una riforma integrale del Messale Romano.
In definitiva, il principio è: si venera e si rispetta ciò che è stato sacro; si obbedisce e si pratica ciò che la Chiesa, oggi, ordina come culto ufficiale. Di conseguenza, qualsiasi uso del Messale del 1962 oggi deve svolgersi solo nelle condizioni ristrette ed eccezionali stabilite dall’autorità, senza poter essere prospettato come un’“alternativa”, o un’opzione al Novus Ordo Missae.
Fin qui quanto essenzialmente volevo esprimere in questa breve nota. Tuttavia, per chiarire ancora di più i dubbi che il lettore potrebbe avere su questo tema, potrebbe essere sollevata un’obiezione a quanto riflettuto su quella celebre frase di Benedetto. Si potrebbe dire che un Papa, in futuro, per esempio Leone XIV, potrebbe eventualmente stabilire un ritorno al Messale del 1962, ma potrebbe farlo sempre come unica lex orandi del Rito Romano, perché ciò che è teologicamente importante è che non possono esserci due modalità di un medesimo rito.
Vale a dire, dal punto di vista teologico e giuridico, in linea di principio —sebbene possa sembrare un esercizio di immaginazione teorica— un Papa —nell’esercizio della sua potestà suprema sulla sacra liturgia (cfr. Sacrosanctum Concilium 22 §1 e c. 838 CIC)— potrebbe, in futuro, stabilire che il Messale del 1962 torni ad essere la forma unica e normativa della lex orandi del rito romano.
Ciò che è decisivo non è quale libro liturgico si usi, ma che vi sia una sola forma normativa per tutto il rito romano, in modo che l’unità visibile della Chiesa si esprima anche nell’unità della sua preghiera ufficiale.
Perciò, il principio che invalida il “bipolarismo liturgico” non è che il Messale del 1962 sia intrinsecamente inammissibile, bensì che non possano esistere due modalità coesistenti con pari rango normativo all’interno di uno stesso rito. L’autorità apostolica può, per ragioni pastorali e di bene comune, sostituire la forma vigente con un’altra —sia più recente sia più antica—, ma sempre come unica lex orandi per tutti i fedeli di quel rito.
Nella storia liturgica della Chiesa latina, l’autorità apostolica ha sempre esercitato la sua potestas suprema per determinare la forma unica e normativa della lex orandi del rito romano. Così, per esempio, dopo il Concilio di Trento, papa san Pio V, con la bolla Quo primum del 1570, promulgò il Messale Romano riformato come unico per tutto il rito romano, salvo gli usi legittimi di oltre due secoli di antichità, che potevano essere conservati. Tale unità si mantenne, con successive revisioni ed edizioni tipiche, fino alla riforma ordinata dal Concilio Vaticano II e promulgata da san Paulo VI nel 1969, che stabilì il Novus Ordo Missae come unica forma ordinaria di celebrazione per tutta la Chiesa di rito latino.
In questo quadro, dunque, quella frase di papa Benedetto XVI del 2007 circa “ciò che per secoli era stato santo” deve essere intesa come un riconoscimento del valore storico e spirituale delle modalità precedenti del rito romano, non come l’istituzione di un parallelismo liturgico permanente, come purtroppo hanno interpretato i pasadisti filolefebvriani. Certamente, l’autorità del Romano Pontefice può, per ragioni pastorali e di bene comune, sostituire la forma vigente del rito con un’altra —sia più recente sia più antica—, ma sempre come unica lex orandi per tutti i fedeli di quel rito.
Di conseguenza, oggi, nell’ipotetica possibilità —a mio avviso inimmaginabile alle attuali condizioni di vita della Chiesa— che un Sommo Pontefice, per esempio papa Leone XIV, potesse legittimamente determinare che il Messale del 1962 tornasse a essere l’unica modalità o forma normativa per tutto il rito romano, ciò che non potrebbe fare —senza attentare all’unità visibile della Chiesa— sarebbe mantenere in modo stabile due modalità con pari rango normativo all’interno dello stesso rito. L’unità della lex orandi divina ed ecclesiae è espressione e salvaguardia dell’unità della fede, e per questo la disciplina liturgica vigente, qualunque forma essa assuma, deve essere unica per tutto il rito romano.
Ma poniamo un’altra obiezione. Ho appena detto che, dopo il Concilio di Trento, san Pio V, con la bolla Quo primum del 1570, promulgò il Messale Romano riformato come unico per tutto il rito, salvo gli usi legittimi di oltre due secoli di antichità, che potevano essere conservati. Tuttavia, allora, non potrebbe il Papa stabilire che il Messale del 1962 o il Messale di san Pio V fosse un “uso legittimo” che potesse essere conservato?
Per sciogliere questa obiezione, la chiave sta nel precisare cosa intendeva Quo primum con “usi legittimi di oltre duecento anni” e perché quella clausola non è un jolly applicabile a qualsiasi momento storico.
Ebbene, nell’anno 1570 papa san Pio V non stava creando un’eccezione aperta per il futuro, bensì riconosceva l’esistenza, in quel momento, di riti o usi liturgici già vigenti e con una storia documentata di almeno due secoli (per esempio, il rito ambrosiano a Milano, il mozàraico a Toledo, il domenicano, il certosino, ecc.). Quegli usi o riti erano “legittimi” perché erano nati e si erano sviluppati con approvazione ecclesiastica indipendentemente dal rito romano, e la loro antichità li collocava al di fuori del campo di applicazione della riforma tridentina, che mirava a unificare il resto dei Messali latini, ossia quelli del rito romano.
Il Messale del 1962 —o quello di san Pio V in qualunque delle sue edizioni— non è un uso distinto all’interno del rito romano, bensì un’edizione precedente di quello stesso Messale Romano. Non possiede la condizione giuridica di “rito o uso legittimo” indipendente, bensì fa parte della linea storica del rito romano che oggi si esprime nella sua edizione tipica vigente (quella di san Paulo VI e delle sue revisioni successive).
Pertanto, un Papa potrebbe, se lo ritenesse opportuno, ripristinare il Messale del 1962 come forma unica e normativa del rito romano, sostituendo quello attuale. Ciò che non potrebbe fare —senza infrangere il principio di unità della lex orandi ecclesiae— è dichiararlo un “uso legittimo” parallelo, come se fosse un rito autonomo alla stregua dell’ambrosiano o del mozàraico, perché non lo è: appartiene alla stessa famiglia rituale e non può coesistere con pari rango normativo con un’altra edizione dello stesso rito.
In sintesi, e per chiarirlo in modo semplice e breve in un unico paragrafo: in Quo primum (1570), san Pio V permise di conservare unicamente quei riti o usi liturgici che, in quel momento, avevano già più di due secoli di esistenza e godevano di propria approvazione ecclesiastica, come l’ambrosiano a Milano, il mozàraico a Toledo o i riti domenicano e certosino. Non si trattava di edizioni antiche del Messale Romano, bensì di famiglie rituali distinte all’interno della Chiesa latina. Il Messale del 1962 —come quello di san Pio V in qualunque delle sue edizioni— non è un rito autonomo, bensì un’edizione precedente dello stesso rito romano. Perciò, non può essere considerato un “uso legittimo” nel senso di Quo primum per coesistere con un’altra edizione dello stesso rito. Un Papa potrebbe, qualora lo ritenesse opportuno, ripristinarlo come forma unica e normativa per tutto il rito romano, sostituendo l’Ordo attuale di san Paulo VI; ciò che non sarebbe possibile, senza violare l’unità della lex orandi, è mantenerlo in modo stabile e parallelo con pari rango normativo insieme al Messale vigente.
Per tutto ciò, quanto disposto da Francesco nel motu proprio Traditionis custodes manifesta una notevole lucidità teologica nel Pontefice argentino, poiché è venuto a confermare la vigoria di quanto stabilito nel 1969 con la promulgazione del Novus Ordo Missae e riafferma un principio costante nella vita della Chiesa: in ogni momento storico il rito romano deve disporre di un’unica lex orandi ecclesiae normativa, determinata dall’autorità apostolica, sia essa il Messale vigente o qualsiasi altro che legittimamente venga stabilito, evitando così ogni duplicità stabile che possa fratturare l’unità visibile e orante del Popolo di Dio.
In definitiva, quella celebre frase di Benedetto XVI nella Lettera ai Vescovi del 2007 —“ciò che per le generazioni precedenti era sacro…”—, pur nata da un’intenzione conciliativa, si rivelò ambigua nella sua formulazione e spalancò la porta a letture equivoche che ancora oggi persistono, nonostante tutte le successive chiarificazioni. Non pochi cattolici di sensibilità filolefebvriana —che prima del 2007 mostravano verso Ratzinger-Benedetto XVI la stessa antipatia che riservavano a tutti i Papi del postconcilio— hanno reinterpretato quelle parole come una convalida del parallelismo liturgico che reclamavano, e oggi la Chiesa clandestina dal profilo pasadista continua a utilizzarle come argomento tattico in un progetto più ampio: preparare il terreno a ciò a cui aspirano —il ripristino dell’ordine ecclesiale antecedente al 1962— con tutto ciò che ciò implica in termini di rifiuto del Concilio Vaticano II, del Magistero postconciliare e della riforma liturgica da essi derivata.