Forma conciliare o anteconciliare della devozione? Il caso Acutis secondo Giovanni Salmeri
La lettura dell’articolato testo di Giovanni Salmeri (qui), a proposito del caso Acutis, fa avanzare positivamente il dibattito ecclesiale e mette a nudo una questione importante, rimasta parzialmente in ombra nella discussione che finora si è svolta sul tema. L’autore, infatti, ricostruendo le perplessità emerse a proposito della canonizzazione del giovane Carlo, concentra la questione su un punto tanto delicato quanto importante: ossia la questione della devozione. E lo fa cercando di distinguere, almeno in parte, questo livello (devoto) dal livello teologico del problema. Per capire il suo accurato approccio, vorrei citare subito una sua affermazione: “Un santo adolescente certamente non ha nessuna teologia, ma certamente ha una devozione”. Come cercherò di dire più avanti, a mio avviso la distinzione tra teologia e devozione non può essere così netta, anche se, nella economia del discorso di Salmeri, capisco bene perché sia stata proposta. Orbene, alla luce di questa distinzione, Salmeri rileva che un ragazzo acceso di interesse per l’eucaristia, se vuol essere devoto, può trovare solo una “devozione classica”, una forma “anteconciliare” di devozione, perché una “devozione conciliare” alla eucaristia non c’è. E’ ovvio che si tratta di una formulazione molto forte, forse troppo forte, che mette però il dito su una piaga vera: ossia il fatto che il Movimento Liturgico, prima, e la Riforma Liturgica voluta dal Vaticano II, hanno cambiato la teologia, hanno cambiato i riti, hanno parzialmente cambiato le norme, ma non hanno cambiato la devozione. In qualche caso, dice Salmeri, hanno semplicemente eliminato la devozione.
Altrettanto giusto è ricordare un dato spesso dimenticato: l’interesse per la liturgia è nato da e con una domanda spirituale. E si è caricato di senso proprio per la esperienza durissima anzitutto della prima come anche della seconda guerra mondiale. Una nuova devozione, non individuale, non borghese, non intimistica, era la risposta con cui Guardini, Parsch, Vagaggini, Marsili, rispondevano ad una sfida storica: la catastrofe mondiale era maturata nelle forme classiche dell’essere devoti. “Eravamo devoti all’Eucaristia, al Rosario e al Purgatorio, ma ci siamo sparati tra cattolici austriaci, italiani e francesi” diceva Parsch, tornando dal fronte della I guerra mondiale. Per cambiare devozione, tre erano i punti di riferimento: Bibbia, Liturgia e Padri. Questo “ressourcement”, questo ritorno alle fonti, faceva della liturgia rituale una fonte di rinnovata devozione: devozione comunitaria e non solo individuale, devozione attiva e non solo contemplativa, devozione pastorale e non solo interiore. Come non ricordare che circa un secolo fa, nel Monastero di Kaisersberg a Lovanio, iniziava il lento movimento verso la “concelebrazione”, per liberare la relazione dei monaci (e dei preti) dall’individualismo di “una messa per ogni prete”. Cento anni dopo abbiamo visto, con immagini sorprendenti, come il Pellegrinaggio di Chartres, di tre settimane fa, orgogliosamente abbia presentato “tende” in cui 12 preti celebravano contemporaneamente 12 messe già alle 4 del mattino, per essere poi seguiti da altri 12 alle 4.30 e da altri 12 alle 5 e così via. La devotio moderna vuole anche questo: è un sistema coerente. A questo ha reagito il Concilio Vaticano II, impostando le basi di una “devozione diversa”, più antica e più nuova.
Da tempo chi osserva lo sviluppo delle forme devote osserva che i nuovi riti e le nuove sensibilità faticano ad uscire dai cortocircuiti classici. In fondo la contraddizione sta anche nella posizione, assunta su questo punto, da papa Francesco. Egli, infatti, da un lato ha portato avanti con determinazione il cammino della Riforma, non solo superando le ambiguità di Summorum Pontificum, ma scrivendo in Desiderio Desideravi un testo singolarmente lucido proprio sul versante richiamato da Salmeri: si tratta di “formare” dopo aver “riformato”. Ovvio che formare non significa solo spiegare e comprendere, ma assumere forme devote nuove. Eppure lo stesso papa, come ricorda bene Salmeri, è rimasto alle devozioni della misericordina, del vangelo, della app sul cellulare o del bracciale. Qui plasticamente Francesco ha dato forma ad una condizione incompiuta delle forme pratiche della devozione che Salmeri chiama “conciliare”..
D’altra parte, e qui ritorno alla distinzione tra devozione e teologia, suggerita in prima istanza da Salmeri, mi pare che lui stesso riconosca, continuando nella scrittura del suo testo, che in realtà per entrare in una devozione conciliare, non ci siano molte alternative ad un lavoro teologico serio e profondo. Certo, non ci si deve illudere che per i giovani o per gli anziani, sia sufficiente leggere un teologo (Schillebeeckx, Barth o Guardini) per uscire da forme superate di culto. D’altra parte non si può neppure pensare che la devozione possa smentire il cammino ecclesiale, sul piano teologico e sul piano pastorale. Provo a spiegarmi.
Lavoriamo sull’immaginario: la devozione ha bisogno di immagini. Bene. Guardiamo la iconografia che viene riferita a Carlo: lo si associa ad una pisside oppure ad un ostensorio. In entrambi i casi la eucaristia è devotamente pensata come oggetto di adorazione, non come azione di celebrazione. Si potrà obiettare: l’oggetto si rappresenta facilmente, l’azione è più difficile. Certo. Però su questo immaginario sta o cade non solo ogni possibilità di una “devotio conciliaris”, ma anche quella di una rinnovata teologia dell’eucaristia. Non è un caso che chi vuole bloccare le forme della devozione, reagisce male anche solo all’idea di una “nuova teologia eucaristica”, che considera erronea, eretica e distruttiva. Vuole una devozione senza pensiero. Ma una devozione senza pensiero diventa facilmente devozione senza vangelo.
Per questo, a mio avviso, la distinzione netta tra teologia e devozione non si può proporre come una chiave di lettura pienamente convincente: essere devoti alla eucaristia significa averne una percezione anche teorica, significa rispondere in modo corretto alla questione “dove incontro Gesù”, alla domanda “come prego con Lui”, alla domanda “come faccio esperienza del mio destino”. La devozione è sempre anche la espressione di una teologia: non è solo teologia, ovviamente, tanto meno è teologia professionale, ma presuppone una visione teologica e favorisce una idea di teologia. Se eucaristia è ostensorio o pisside, restiamo in una teologia del tabernacolo, non dell’ambone e dell’altare. Se dopo aver celebrato la messa del Corpus Domini, e aver fatto la comunione (cosa che la Bolla del 1264 chiedeva come obiettivo della festa), facciamo la processione “col Santissimo”, alimentiamo indirettamente una devozione da tabernacolo, non da ambone e da altare. Se al momento della comunione, usiamo le particole prodotte sull’altare solo per due o tre persone, mentre le centinaia dell’aula le nutriamo tutte dalla pisside presa dal tabernacolo, alimentiamo una teologia eucaristica parziale e unilaterale, che per custodire una devozione classica (non producendo pericolosi frammenti nella frazione), perde il significato più profondo del rito che si celebra. La separazione tra sacramento e suo uso (un luogo classico della devozione eucaristica) è un errore teorico a cui non si rimedia intensificando la preghiera, ma correggendo la rappresentazione.
Facciamo una teologia eucaristica dell’effetto intermedio, ma non dell’effetto di grazia. Ci fermiamo a metà della strada: il Corpo di Cristo sacramentale non ci interessa che diventi corpo di Cristo ecclesiale. Salmeri dice: di questo effetto “ecclesiale” non c’è alcuna devozione. Forse però è giusto così. Essendo la devozione virtù di individui, l’effetto di grazia sta su un altro piano. Forse è giusto che la virtù di religione, che deve essere devozione e adorazione, si trasformi in forma di vita e che l’atto di culto diventi atto morale. Non perché sparisca la devozione, ma perché assuma la forma con cui la fede genera una istituziona di conversione e misericordia.
D’altra parte, proprio osservando il centro della “devozione eucaristica”, ossia la messa, non è difficile rilevare la interferenza continua, anche nel rito riformato, tra forme della conoscenza e forme della affettività che non vivono in armonia. Non solo le polemiche pretestuose sul modo di “ricevere la particola” (il fatto che cardinali si ostinino a dire il primato della bocca sulla mano non è solo coreografia curiale) ma anche la postura durante la cosiddetta consacrazione (se Dio vuole, l’anniversario del Concilio di Nicea ci ha fatto ricordare che stare in ginocchio è una forma di devozione penitenziale prima che eucaristica), ma anche l’uso devoto di suonare il campanello prima dopo e alle due elevazioni, ma anche la mancanza di senso rituale della frazione del pane e la conseguente forma tonda della particola, singolare contraddizione tra atto di condivisione e pretesa di avere ciascuno un piccolo intero…Unendo tutte queste prassi quasi inconsapevoli (e che si vedono tanto nell’ultima delle parrocchie come anche a S. Pietro) riconosciamo bene la inerzia di una devozione anteconciliare dentro un rito certamente postconciliare. Non aveva visto, almeno fino a papa Benedetto XVI, preti e professori andare a celebrare agli altari laterali di S. Pietro, al mattino presto? Il rito era quello di Paolo VI, ma la devozione (presbiterale) era quella di Pio V.
Come si domanda Salmeri, se un giovane vuole essere devoto alla eucaristia, non può che esserlo in forma anteconciliare? Si noti: non anti-conciliare, ma ante-conciliare. Però è chiaro che una devozione ante-conciliare, se non viene assunta ad oggetto di revisione, diventa facilmente, anticonciliare. Le cose vanno così: dove la affettività devota identifica la teologia con il sentimento, può accadere anche ad un papa teologo di giustificare il parallelismo rituale con il principio “ciò che è stato sacro per le generazioni del passato deve restarlo anche per quelle del futuro”. Potremmo dire che, isolando troppo nettamente la devozione dalla teologia, si blocca il sistema e si diventa nostalgici del bel tempo in cui tutti adoravano l’ostia, anche durante la messa: unità e comunione della Chiesa restavano esterne alla devozione. Essere “apostoli della eucaristia” e avere accanto un ostensorio e una pisside fa pensare che la devotio moderna sia il sacro della chiesa cattolica per sempre, non una sua forma storica che ha largamente esaurito la sua efficacia ecclesiale. La domanda di spiritualità, nata dalla esperienza tragica delle due guerre mondiali, aveva un altro orizzonte e un’altra idea: forse era una utopia?
“Se uno parla male di mia mamma, deve aspettarsi un pugno”, ha detto una volta papa Francesco, con la sua franchezza. Nel dibattito su Carlo Acutis e sulla devozione eucaristica scattano affetti travolgenti e anche “pugni” metaforici. Ma gli affetti chiedono una educazione. Se non li educhi, prendono la via più facile, anzitutto nei giovani. Ha ragione Salmeri quando pone con forza la questione della devozione conciliare. Per parte mia sento di dover insistere sullo stretto legame delle forme della devozione con la comprensione teologica della eucaristia, della preghiera e dei novissimi. Proprio gli ambiti che vengono richiamati nel processo di canonizzazione, come più tipici della santità di Carlo, sono i piani su cui la elaborazione pratica postconciliare risulta più carente, anche se non inesistente (ad es. il Brasile ha prodotto una preghiera popolare dei salmi che permette di attuare, in qualche modo, il dettato conciliare che Salmeri denuncia come inapplicato quasi totalmente). Ma non trascuriamo il contributo che a questa trascuratezza hanno dato teologie troppo facilmente “concordiste” e orientate a dare allo stesso tempo colpi al cerchio e colpi alla botte. Fino al punto di teorizzare la possibile convivenza “pacifica” tra riti tra loro contraddittori. Nel caso Acutis emergono perciò anche le carenze di un pensiero teologico, che spesso risulta del tutto incapace di assumere responsabilmente gli “altiora principia” stabiliti dal Vaticano II, conducendoli elaborati alle nuove generazioni postconciliari. Anche questa, a me pare, è una concausa del “caso Acutis”. Chi, da teologo, è stato consultato lungo il percorso di istruzione della causa, sembra aver ignorato tutte le questioni più decisive, rifugiandosi nelle evidenze sospette di una devotio moderna, che non ha più il supporto di una evidenza sistematica. Forse l’ambiguità del caso consiste proprio nel lato oscuro di un rapporto tra parola liturgica e parola dogmatica, che sugli snodi di maggior rilievo della pratica devota, conosce una sorta di “impermeabilità” di un discorso rispetto all’altro. La pretesa che la esperienza della eucaristia (devozione compresa) sia comandata da proposizioni dogmatiche medievali e tridentine, e non da proposizioni conciliari e rituali, è il segno di una crisi non piccola. A cui non si rimedia né difendendo una riforma che non genera pratiche spirituali, né difendendo pratiche spirituali senza più supporto né rituale né dogmatico. La riforma non è riforma se non genera pratiche. Ma le pratiche spirituali non sono spirituali se sono anzitutto “contro” la riforma e contro una più profonda comprensione di che cosa è eucaristia, che cosa è preghiera e che cosa è l’essere giudicati sull’amore.






























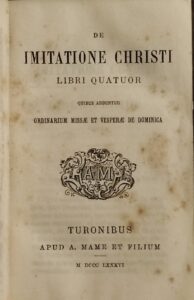
 Area personale
Area personale











