Nuove meditazioni di teologia eucaristica (/1): Gli equivoci sulla sostanza in 12 tesi
Nuove meditazioni di teologia eucaristica (/1)
Nel 2018, per alcuni mesi, su questo Blog ci fu un bello scambio di post, al quale parteciparono diversi teologi, sotto il titolo “Nuova teologia eucaristica”. Da quei testi sorsero anche volumi, come lo splendido testo di Gh. Lafont Un cattolicesimo diverso, pubblicato nel 2019 da EDB. Oggi è maturo il tempo per suscitare una nuova riflessione che, traendo luce da quel primo esperimento, possa tradurre le questioni teologiche sul piano ecclesiale e sul piano spirituale. Nel dibattito ecclesiale il riferimento alla eucaristia e alla messa è spesso vago, equivoco, unilaterale. Le discussioni sulla liturgia tridentina e sulla devozione al Santissimo Sancramento spesso incrociano questioni teologiche fondamentali, che oggi chiedono chiarimenti. Lo spazio di questo blog può essere il luogo di un confronto e di un chiarimento di cui molti sentono l’esigenza. Iniziando da questo testo, di carattere programmatico, spero che sia possibile portare luce e rendere ragione della fede nel Signore che si rende presente in mezzo ai suoi nella frazione del pane. (ag)
Gli equivoci sulla sostanza in 12 tesi
Se non vi è dubbio che la elaborazione della teoria della “transustanziazione” sia servita, tra il XII e il XVI secolo a ciò che veniva ritenuta la difesa della “vera realtà” della presenza del corpo e del sangue di Cristo nella celebrazione eucaristica, altrettanto chiaro è che questa spiegazione, per quanto possa essere ancor oggi ritenuta come “molto adeguata” per dare ragione della “presenza reale”, tuttavia sconta una serie di limiti, che la esperienza ecclesiale, rinnovata dalla ricerca del Movimento Liturgico e dalla pratica della riforma liturgica, non stenta a percepire e a considerare, se medita con cura sulle forme che assume il celebrare e l’adorare eucaristico.
Un esame attento del linguaggio dottrinale classico, così come formalizzato ultimamente dal Concilio di Trento, mostra con chiarezza alcuni limiti vistosi, che vorrei qui richiamare per impostare un ragionamento pacato, ma esigente. Propongo una serie di 12 tesi, che possano aiutare a dare ragione delle difficoltà e ad impostare una risposta più adeguata, favorendo un dibattito sereno su ciò che non muore e ciò che può morire della nostra tradizione.
1. La conversione della sostanza come “atto” e non come “processo”
La identificazione della “conversione sostanziale” in un momento preciso della celebrazione eucaristica – nella cosiddetta “consacrazione” – induce a pensare che la presenza del corpo e sangue (con anima e divinità) del Signore Gesù possa essere un dato “localizzabile” sotto le specie. Se la conversione è compiuta validamente, la presenza reale tende ad imporsi tout court, superando ogni limitazione. La sequenza tridentina di avverbi – vere, realiter, substantialiter – tende a ridurre in modo pericoloso le altre tre espressioni – ossia segno, figura e virtù – a forme di negazione della presenza.
2. Un “ritus interruptus” non consegue l’effetto ultimo di grazia, ma si ferma all’effetto intermedio
Se il rito eucaristico prevede una “imitatio Christi” che attraversa l’intero “racconto istituzionale”, comprendente ben 5 verbi diversi (prendere, rendere grazie, spezzare, dare, dire), cui segue una “formula” che non dice più “questo è il mio corpo”, ma dice “prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato (offerto in sacrificio) per voi”, allora è evidente che se la imitazione si interrompe nel cuore della preghiera eucaristica, il rito resta spezzato e tronco. Considerata dal punto di vista rituale, la consacrazione non è il centro della azione eucaristica, ma è solo parte della anafora, orientata alla sua realizzazione nel rito di comunione..
3. Una sostanza e 9 accidenti
La sostanza risponde alla domanda: che cos’è? la cui risposta, certa, non va però oltre la definizione. Ogni determinazione possibile chiede la concretezza di tutte le altre domande, cui rispondono le altre categorie, studiate da Aristotele e recepite dalla scolastica. Siccome, come dice S. Tommaso d’Aquino nella Summa Theologiae, la presenza eucaristica non è locale, ma sostanziale, allora la determinazione delle specie, mediante le altre 9 categorie (di quantità, qualità, relazione, tempo, spazio, modalità, azione, passione e possesso) riguarda soltanto il pane e il calice.
4. Non è bene che la sostanza sia sola
Se la sostanza resta senza accidenti, come stabilito per principio dalla teoria sostanziale, chiede tuttavia che questa mancanza sia completata: non è bene che la sostanza sia sola, se non “en passant”. La condizione di “zwischen” dell’ostia, o della particola consacrata, è attestata da due elementi: manca degli accidenti, è solo sostanza, e sta al centro di un processo rituale, che la deve ancora elaborare. L’ostia su cui si è detta la preghiera eucaristica e si è proclamato il racconto istituzionale, attende di essere spezzata, data, consumata e detta. La particola è un bene di consumo. La festa è consumo, non conservazione. Il tabernacolo è feriale, perché garantisce la riserva, la conservazione. L’altare è invece festa, spreco e consumazione. Per questo il tabernacolo non entra, se non eccezionalmente, nel processo rituale, che ruota intorno solo all’altare. Il fatto che ordinariamente si ricorra al tabernacolo al momento del rito di comunione è il segno di una inerzia della problematica separazione tra preghiera eucaristica e comunione.
5. Effetto intermedio ed effetto di grazia
La incompiutezza della particola corrisponde alla incompiutezza del Corpo di Cristo sacramentale. Come hanno riconosciuto i teologi medievali, da Innocenzo III a Tommaso d’Aquino, l’effetto intermedio della eucaristia è il Corpo di Cristo sacramentale, ma il dono di grazia ultimo della celebrazione è la comunione, la carità e l’unità della Chiesa. Il Corpo di Cristo sacramentale deve diventare il Corpo di Cristo ecclesiale. Questo corrisponde al linguaggio con cui i Padri dicevano: “Estote quod videtis, accipite quod estis” (Augustinus). La dimenticanza del fatto che questo passaggio è scandito e realizzato nel rito e non solo nelle coscienze è uno dei punti ciechi della tradizione medievale-moderna.
6. Diventare il Corpo di Cristo
La sostanza è solo una delle 10 categorie, ossia di tutto ciò che può essere predicato delle cose. La presenza della sostanza dice l’inizio di un processo, che si compie solo quando tutte le altre 9 categorie si uniscono alla sostanza. Quando la qualità, la quantità, la relazione, lo spazio, il tempo, la modalità, la azione, la passione e il possesso, come accidenti del pane e del vino, con la sequenza rituale di anafora-comunione, diventano qualità, quantità, relazione, spazio, tempo, modalità, azione, passione e possesso del Corpo di Cristo ecclesiale. Questo fa sì che chiamiamo “sostanza” la invisibile efficacia del dono dello Spirito, che trasforma la mediazione del pane e del vino, perché diventi Corpo e Sangue di Cristo, sacramentale ed ecclesiale.
7. Due dimensioni, anzi tre
Una delle letture medievali più sorprendenti è quella di papa Innocenzo III, nelle cui parole pane e vino sono segno del corpo e del sangue sacramentale, ma il corpo di Cristo sacramentale è a sua volta segno del corpo di Cristo ecclesiale. Il duplice rimando è un’altra prova della incompiutezza della teoria della sostanza. Il vero problema non sta nella logica transustanziale, in sé legittima, ma nella affermazione, che ha accompagnato larga parte della coscienza ecclesiale post-scolastica, che i due effetti del sacramento (sulla materia e sulle persone), per quanto correlati, non sono da considerare sullo stesso piano.
8. Il contenuto e il significato
In effetti, se si afferma che il “Corpo di Cristo sacramentale” è contenuto nel sacramento, mentre il “Corpo di Cristo ecclesiale” non sarebbe contenuto, ma solo significato, nel sacramento, allora è evidente che la affermazione rende quasi “istituzionale” e “dovuta” una separazione tra le due dimensioni. La efficacia del sacramento sarebbe quella di produrre solo l’effetto intermedio, additando solo da lontano la comunione ecclesiale, come il dito indica la luna. Qui avviene una svolta che mette il rito eucaristico sullo sfondo, riducendolo alla funzione di produzione della presenza sostanziale.
9. La comunione ridotta ad uso
Una delle conseguenze di questa sovrapposizione di teorie (la transustanziazione come garanzia di effetto sacramentale e la sospensione/differimento dell’effetto ecclesiale) è perciò la solenne riduzione della celebrazione eucaristica a “produzione di transustanziazione”, con la inevitabile emarginazione del rito di comunione. Questa minorazione, a sua volta, è stata rafforzata e giustificata prima dalla distinzione scolastica tra sacramento e uso, e poi dal conflitto cattolico con la teologia protestante della Santa Cena e la centralità che, per quella impostazione evangelica, la comunione assumeva come momento-chiave della presenza del Signore. Così, questa centralità riformata della comunione ha determinato, apologeticamente, un rito dell’eucaristia post-tridentino senza comunione del popolo. La lunga prassi cattolica di “communio extra missam” viene in larga parte da questo abbaglio apologetico.
10. La corrispondenza di frattura nell’eucaristia e nel ministero
Ultimo particolare di questa frattura tra sacramento e chiesa, che affligge la teologia eucaristica, è la teoria, formulata dalla scolastica e rimasta in vigore fino al codice del 1983, della divisione degli effetti della eucaristia come criterio per la articolazione delle forme del ministero. La parola limpida di Tommaso d’Aquino fotografa una correlazione formidabile (e a sua volta assai pesante): del Corpo di Cristo sacramentale si occupa la potestas ordinis del presbitero/sacerdote, mentre del Corpo di Cristo ecclesiale si occupa la potestas iurisdictionis del vescovo. Alla esclusione della chiesa dagli effetti della eucaristia corrisponde la esclusione dell’episcopato dal sacramento dell’ordine. In un certo senso, potremmo concludere, la Chiesa appare, certo contro le intenzioni, soltanto come un accidente eventuale della sostanza eucaristica.
11.La sostanza senza accidenti come “trascendenza processuale”?
Forse “sostanza”, rispondendo alla domanda: che cos’è, e garantendo la risposta “Corpo di Cristo”, invita soltanto a non lasciare la parola alla sola percezione immediata e sensibile. Potrebbe essere compresa come una istanza negativa rispetto alla pretesa della evidenza sensibile. Ma la sostanza, se risulta priva dei propria accidenti, resta il segnale di una trascendenza non determinata. La sostanza resta in cerca dei suoi accidenti. Invece, nella sua solitudine categoriale, risulta “irriconoscibile”. La determinazione avviene, però, non anzitutto nella contemplazione adorante e statica dell’ostia consacrata, ma nel processo rituale e dinamico, di parola e sacramento, di linguaggio verbale e non verbale: non semplicemente nella fede e nell’intelletto del soggetto singolo, ma nell’interscambio corporeo e intersoggettivo si manifesta il Signore della sua chiesa. Le sequenze rituali non agiscono però che accidentalmente, nella contingenza non necessaria. Attraverso le specie del pane (preso, benedetto, spezzato, condiviso) e del calice (preso, benedetto, condiviso) la sostanza assume gli accidenti della Chiesa, delle persone battezzate che diventano una sola cosa, il corpo del Risorto. Facendosi pane, il Signore può riconoscere il proprio corpo nel corpo della Chiesa e, allo stesso tempo, la Chiesa può riconoscersi, mediante il pane spezzato e il calice condiviso, come corpo del Signore.
12. Nel rito la unità di sacramento e chiesa
Il rito eucaristico, col succedersi delle sue sequenze, pone nella forma più alta la correlazione tra annuncio della parola, preghiera eucaristica e rito di comunione. Il Signore è riconosciuto presente nella parola da lui annunciata, nella comunità che ripete le sue azioni di commiato e che riceve il pane e vino come corpo e sangue, diventando essa stessa ciò che riceve. Appare importante superare una duplice limitazione: la messa non è una vetta centrale ( /\ ) con salita e discesa, ma un crescendo verso la vetta ( / ) della comunione: il suo vertice non è nel racconto istituzionale della preghiera eucaristica, ma nel compimento della comunione da parte dell’ intera assemblea. Il rito centrale della celebrazione eucaristica non è la consacrazione (che è una parte della preghiera eucaristica, con parole esplicative della comunione), ma la comunione (che non è uso del sacramento, ma passaggio alla costituzione del Corpo di Cristo che è la Chiesa).































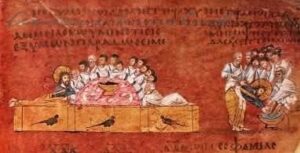
 Area personale
Area personale











