La guerra liturgica di alcuni cardinali. Perché tutti gli altri tacciono?
Un passaggio di pontificato, tra la morte improvvisa di Francesco e l’inizio cauto di Leone XIV, è tempo di riposizionamenti. Colpisce il fatto che una serie di soggetti ecclesiali, fin dai primi giorni dopo l’8 maggio, abbiano iniziato a sollevare con sempre maggior forza la questione della liturgia, come ambito in cui chiedere al nuovo papa di intervenire con urgenza. Questo non avviene per caso. Una narrazione distorta e interessata della storia recente, suffragata dalla approssimazione di non pochi giornalisti, ha preparato il campo alla “guerra liturgica” scatenata da alcuni cardinali. Di fronte a questo, salvo rarissime eccezioni, tutti tacciono. Questo è un classico fenomeno di corte. La teologia di corte funziona così. Prima che si pronunci il capo si tace, poi si fa a gara a chi fa i complimenti più sperticati. Siccome il “nuovo” capo non si pronuncia, si traccheggia e si fischietta un motivetto indolore, mentre alcuni le sparano più grosse che mai.
Cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo. La guerra liturgica nasce da parole, opere e omissioni. Vediamo nel dettaglio queste dinamiche.
1. La guerra liturgica contro il Concilio Vaticano II
Fin dall’inizio, quando si capì che il Concilio Vaticano II avrebbe prodotto una riforma della Chiesa (come Giovanni XXIII e poi Paolo VI avevano chiaramente dichiarato) si cercò di attaccare il fondamento della prima riforma messa in cantiere: quella della liturgia. E’ famoso l’intervento dei Cardinali Bacci e Ottaviani, che già nel 1969 cercarono di fermare la riforma liturgica della messa, con argomenti che C. Vagaggini confutò con la finezza teologica che lo caratterizzava. Era chiaro, già allora, che contestare la nuova liturgia significava bloccare la riforma della Chiesa.
Quando poi fu approvata la riforma liturgica del messale romano, Mons Lefebvre riprese una idea che era nata alcuni anni prima, formulata dal Card. Siri a Genova, in occasione della riforma della veglia pasquale. Il card. Siri aveva chiesto a papa Pio XII, nel 1951, che lasciasse i vescovi liberi di applicare la riforma o di non applicarla. Chiese che si potesse celebrare la veglia “in die” (come prima) o “in nocte” (secondo la riforma), a piacere. Si capì subito che questo non poteva essere. E Siri comprese allora, come poi comprese 20 anni dopo di fronte al nuovo messale, che la riforma vincolava tutti i battezzati, a partire dai vescovi. Lefebvre, invece, non accettò. Al punto che, nel 1988, dopo aver sempre celebrato col rito tridentino, col rito tridentino ordinò vescovi senza rapporto con Roma. E fu scisma.
Oggi abbiamo vescovi e cardinali che si comportano in modo più simile a Lefebvre che a Siri. Pretendono di stare nella Chiesa cattolica come se il Concilio Vaticano II non ci fosse mai stato e credono di poter dire, pubblicamente, che questa è una cosa normale. Le “forme liturgiche parallele” sono chiese parallele. Questo i cardinali lo sanno. Con le loro parole irresponsabili alimentano la guerra, piuttosto che promuovere la pace.
2. La ipocrisia di una narrazione capovolta.
La pace liturgica non si fa accettando come normale la guerra contro il Vaticano II. L’unica pace liturgica è la accurata applicazione della riforma liturgica, ricca di tutte le sensibilità che la accolgono, non di quelle che la negano. I giochini paternalistici di Burke, Sarah, Mueller, Koch e Bagnasco sono dichiarazioni di guerra, non domande di pace. Colpisce in modo particolare il comportamento recente del Card. Bagnasco. A differenza di Burke, Sarah e Mueller, che da molti anni si sono schierati decisamente a favore del rito tridentino, Bagnasco ha fatto cadere la maschera solo molto recentemente. Pur essendo stato ordinato dal Card. Siri, appare molto meno prudente di lui. In una recente intervista ha sposato una narrazione capovolta, ingiusta e irresponsabile. Cito qui le sue 4 righe in cui commette almeno 5 gravi errori:
«Sono stato per diversi anni al Dicastero della Chiese orientali, e ho verificato che nella Chiesa cattolica ci sono più di 30 riti liturgici. Non ho mai visto e non vedo ora come la forma straordinaria del rito romano, che è unico, come ha chiarito Papa Benedetto XVI, possa, come accade per il rito Ambrosiano, creare problemi. Non vedo né rischi né pericoli se le cose si fanno serenamente e con benevolenza da parte di tutti».
Non una sola di queste affermazioni è fondata, come spiegherò tra poco. Al centro, però, vi è una ricostruzione della storia che merita di essere corretta sul piano generale. Da quando esiste la nuova forma del “rito romano” (a partire dalla fine degli anni 60) tutti i papi si sono mossi secondo tradizione: il nuovo rito soppianta la forma precedente. Così è stato per Paolo VI, per Giovanni Paolo I, Per Giovanni Paolo II e per Francesco. Solo papa Benedetto ha ritenuto, in modo troppo audace e obiettivamente imprudente, che per pacificare la Chiesa si potesse rimettere in vigore, accanto alla forma nuova, la forma vecchia del rito romano. Nelle intenzioni questa disposizione era per una pacificazione, ma in realtà, mancando di fondamento teologico, ma poggiando solo su sentimenti e nostalgie, si è trasformata, molto rapidamente, in un incitamento alla guerra. A buon diritto Gianfranco Zizola ha definito Summorum Pontificum un atto di “anarchia dall’alto”, mentre il Card. Ruini aveva sottolineato, già il giorno dopo la sua approvazione, nel 2007, la esigenza di evitare il rischio “che un motu proprio emanato per unire maggiormente la comunità cristiana sia invece utilizzato per dividerla”.
Rispetto a questa audacia arrischiata di papa Benedetto, Francesco è stato più prudente. Semplicemente è tornato alla forma tradizionale di gestione della questione: esiste solo una forma rituale comune a tutta la chiesa, mentre per celebrare nella forma tridentina occorre una esplicita autorizzazione. Per questo i giudizi superficiali sulla “durezza” di Francesco circa la messa tridentina sono del tutto infondati. Si dovrebbe parlare piuttosto di “diffidenza” di Benedetto verso la messa di Paolo VI.
3. I cinque gravi errori del card. Bagnasco
Esaminiamo ora nel dettaglio gli errori del Card. Bagnasco
a) Egli inizia dalla sua esperienza nel Dicastero delle Chiese orientali. Ma l’esperienza di pluralità di riti “cattolici” non è molto utile quando si deve parlare del rito romano. Cambiare argomento non è il più grande merito di una risposta. Se ti chiedono “a che ora mangiate pranzo a casa vostra” e tu dici che nel condominio dove abiti si mangia dalle 12 alle 14.30 e tutti sono contenti di mangiare a ore diverse e si rispettano a vicenda, non aiuti molto chi fa la domanda per capire a che ora deve venire da te (e non dagli altri). Il rito romano non è “in comunione con se stesso” nel momento in cui viene duplicato in forme diverse, tra loro in contraddizione. Riti cattolici e rito romano non sono la stessa cosa.
b) In secondo luogo, il cardinale usa l’espressione “forma straordinaria” come se fosse una “cosa” chiaramente identificabile. In realtà egli dimentica che la “forma straordinaria” è il sofisma argomentativo, mai usato in 2000 anni di storia della Chiesa, che sta al centro del MP Summorum Pontificum. Di forma straordinaria si è parlato, erroneamente, dal 2007 al 2021, fino a quando un altro MP ha superato questo errore. Dire che l’unico rito romano esiste in due forme (una ordinaria e una straordinaria) è un errore storico e teorico che si paga con la perdita della unità. Non esiste nessuna forma straordinaria del rito romano. C’è solo una forma precedente, che il Concilio e la Riforma liturgica hanno deciso di superare, e c’è una forma successiva, che Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno reso vigente. La ricostruzione con “due forme parallele” è un trucco per rendere la riforma liturgica e il Concilio irrilevanti. Come fa un cardinale a non aver capito che questo errore di prospettiva crea divisione in ogni parrocchia e in ogni diocesi?
c) Riferirsi al “rito ambrosiano” come analogatum della forma straordinaria è un errore storico, teorico e anzitutto geografico. Anche il rito ambrosiano, se non fosse legato ad una storia e ad una geografia, sarebbe fonte di divisione, se domani un papa decidesse, in modo arbitrario, che tutti i battezzati cattolici potrebbero domandare di celebrare i riti romani con forma ambrosiana. Il rito ambrosiano è giustificato, nella sua esistenza attuale, dalla delimitazione geografica che lo caratterizza. Solo così può essere motivo di ricchezza e non di divisione. La cosiddetta “forma straordinaria”, invece, è lacerante, perché pretende una validità universale e illimitata.
d) Il card. Bagnasco asserisce: “non vedo problemi”. Ma come fa a non vederli? Facciamo alcuni esempi. Il MP Summorum Pontificum creava un parallelismo “straordinario” per tutti i riti romani. Ad es. per il matrimonio, diceva che si poteva celebrare il sacramento nella forma successiva al 1969 ma anche nella forma precedente. Ossia nella forma con due anelli, ma anche nella forma con un solo anello (quello della sposa). Ma questo non può essere, perché la riforma del 1969 ha fatto entrare nella Chiesa la parità di marito e moglie anche nel gesto dell’anello. Il rito precedente al 1969 non è la forma straordinaria del matrimonio, ma la forma vecchia e superata del rito del matrimonio, che continua a pensare la donna come “subordinata” al marito. Lo stesso vale per la messa: il rito del 1962 ha un lezionario poverissimo rispetto al rito romano del 1970. E non può essere affidata alla singola comunità o parroco la possibilità di scegliere tra ricchezza e povertà biblica. Non ci sono due forme, ma c’è l’unico rito in una crescita storica che assume un’unica forma, vincolante per tutti.
e) L’ultimo errore è forse il peggiore: far dipendere tutto dalla benevolenza e dalla serenità. Questa è l’ultima mistificazione. La forma straordinaria, in quanto concetto astratto, nasce come contestazione della riforma liturgica. Assumere sullo stesso piano le due forme rituali è un modo di negare quella storia, che ha portato la chiesa di Roma prima al Concilio e poi alla Riforma che il Concilio ha imposto alla Chiesa, come un dovere di verità e di autenticità. Non ci può essere benevolenza verso chi attenta al cammino ecclesiale e pensa di rendere accessorio ciò che è centrale. Per questo affermare l’unica lex orandi, come ha fatto papa Francesco nel 2021, ristabilendo la tradizione, è l’unico modo per eliminare la confusione che era sorta nel 2007, con la pretesa di un parallelismo di forme tra loro in contraddizione.
4. Perché il silenzio di tutti gli altri?
Per finire, mi chiedo: come mai, con il centinaio di cardinali, le migliaia di vescovi, di presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, le centinaia di teologhe e teologi, di fronte alle parole infondate e irresponsabili che esprimono ogni giorno alcuni cardinali, alcuni vescovi, molti giornalisti, e altrettanti tradizionalisti, pressoché nessuno difende le ragioni della riforma liturgica e del Vaticano II? Perché non si crea un coro di interventi fondati e significativi, che contrastino le semplificazioni e le menzogne che dobbiamo leggere non da blog marginali, ma da cardinali irresponsabili? O aspettiamo solo che parlino i papi e deleghiamo a loro ogni responsabilità?
Sorprende non poco che il dibattito ecclesiale veda da una parte una serie di cardinali e molti siti tradizionalistici, tutti accomunati da una straordinaria approssimazione sulla storia e sulla teologia, di fronte ai quali ci sono moltissimi soggetti, a diversi livelli di autorità pastorale, teologica ed ecclesiale, che restano al 99,9 % assolutamente muti. E tutti sembrano dire: vediamo che cosa dirà papa Leone. Questo è un modo di ridurre la chiesa ad una associazione cortigiana, che confonde la comunione con la indifferenza e il silenzio.
Se mi guardo intorno, in questi ultimi mesi, vedo sul tema pochissime espressioni chiare, capaci di affrontare la questione nel modo integrale e preciso che merita. E per trovare un pastore che abbia saputo, in campo liturgico, dire con chiarezza come stanno le cose, debbo tornare al 2022, al testo di Desiderio desideravi, in cui Francesco scriveva queste frasi memorabili, che ogni cardinale dovrebbe custodire come un memoriale e tenersi strette al cuore, cucite sotto la sua sgargiante veste rossa:
“Non possiamo tornare a quella forma rituale che i Padri conciliari, cum Petro e sub Petro, hanno sentito la necessità di riformare, approvando, sotto la guida dello Spirito e secondo la loro coscienza di pastori, i principi da cui è nata la riforma. I santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II approvando i libri liturgici riformati ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II hanno garantito la fedeltà della riforma al Concilio. Per questo motivo ho scritto Traditionis Custodes, perché la Chiesa possa elevare, nella varietà delle lingue, una sola e identica preghiera capace di esprimere la sua unità. Questa unità, come già ho scritto, intendo che sia ristabilita in tutta la Chiesa di Rito Romano.”
Questa resta la migliore risposta alle assurde parole di pochi cardinali, di alcuni blog tradizionalisti, di diversi giornalisti molto interessati e poco competenti. Così si è espressa la prudente tradizione che va da Giovanni XXIII a Francesco. Questa è la via della pace. Chi vuole fare la guerra al Concilio, si inventa parallelismi rituali che mai la storia del rito romano moderno ha conosciuto. Sul testo di Desiderio Desideravi vorrei che si pronunciassero da oggi tutti quei cardinali, quei vescovi, quei teologi e quelle teologhe, quei religiosi e quelle religiose che finora sono rimasti in silenzio. Il loro silenzio diventa un peccato di omissione. Una opinione pubblica ecclesiale è una delle conseguenze di Dignitatis Humanae: la libertà di coscienza è una cosa seria e restare muti è uno dei modi per non attuare il Vaticano II, lasciandosi bloccare dalle regole spietate di una società dell’onore. Occorre invece denunciare, con precisione e con dignità, tutte le cose sbagliate che dicono coloro che parlano a vanvera (a qualunque livello si collochino, senza alcun inferiority complex) e ristabilire con forza ed entusiasmo la linearità del cammino di sviluppo organico del rito romano. Perché la riforma liturgica, che resta necessaria, sia riconosciuta insufficiente e bisognosa di quella applicazione, alla quale tutte le sensibilità diverse devono concorrere. La pluralità ecclesiale, con i suoi diversi stili, si esprime nell’unico rito comune da attuare in modo differenziato, non nella contrapposizione ideologica tra VO e NO, che genera solo lacerazione e non produce pace, ma guerra.































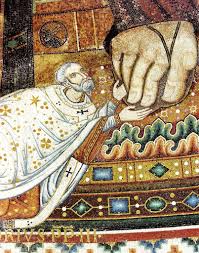
 Area personale
Area personale












Caro dottor Grillo,
sono pienamente d’accordo con i concetti contenuti nel vostro articolo. La sua conclusione sulla necessità che il Collegio dei Cardinali parli di queste cose, in contrapposizione ai quattro o cinque Cardinali filo-lefebvriani, la condivido pienamente.
Quello che mi chiedo è questo: hanno bisogno di parlare attraverso i mass media e i blog marginali, come fanno i quattro o cinque cardinali che lei menziona? Pensi che questa minoranza di Cardinali sono fuori dall’orbita del Papa, lontani dal funzionamento della Curia, e senza diocesi a carico, per cui la loro quasi unica presenza pubblica nei mass media e nelle reti… Mentre la stragrande maggioranza degli altri Cardinali svolgono funzioni in attività o sono a capo di Dicasteri o di importanti diocesi. Chi le ha detto di non parlare con il Papa attraverso i canali normali, e per questo non lo fanno nei media o nei blog marginali?…
Caro Andrea, sono pienamente d’accordo con te circa il carattere obbligatorio della riform liturgica voluta dsl Concilio. Quanto però al prendere posizione, temo che l’argomento interessi poco sia ai preti che ai laici. Purtroppo la gente che frequenta la chiesa alla domenica è abituata a prendere quello che passa il convento. L’ignoranza della Bibbia è di regola molto estesa e la lettura dei brani liturgici, estratti dal contesto, non ne garantisce una migliore conosenza. Anche i gesti liturgici per lo più non sono compresi e le prediche solitamente non aiutano. In definitiva, il vero problema della liturgia sta più a monte: manca una vera esperienza comunitaria e da secoli la nostra gente è abituata ad “assistere alla messa”. Dopo il Concilio c’è stato un rifiorire di interesse, ma ora non è più così. Grazie per il tuo impegno in campo liturgico.
p. Alessandro
Caro Andrea,
ieri avevo cominciato a risponderti un po’ dettagliatamente. Ma non ho lo stesso tempo che hai tu da dedicare a questo dibattito. E ti prego di non attribuirmi un peccato di omissione – ne ho già tanti – se rispetto che tu abbia fatto della questione del VO la tua battaglia, ma ritengo, come molti altri colleghi, che i problemi della nostra chiesa oggi siano anche altri. Anche quelli liturgici, certo. Ma le chiese che si svuotano non dipendono dalle pretese di Burke o Sarah né dalle loro enclave che, anzi, assorbono quei tradizionalisti altrimenti difficili da gestire nelle nostre povere parrocchie. Perché non pensare che il problema ecclesiologico serio non è il conflitto tra VO e NO, ma prima di tutto la crisi delle appartenenze che attenta alla radice la possibilità di riconoscersi in un corpo ecclesiale, oppure anche l’insignificanza di gesti e soprattutto parole a cui sono ormai condannati i nostri riti? Quella che stancamente chiamiamo “riforma liturgica” ha presentato le sue criticità quasi subito ma, comunque, è ormai destinata da tempo a cedere il passo a qualcos’altro. Il silenzio che tu denunci non dipende, poi, da un peccato di omissione. Almeno non per tutti: molti di noi hanno parlato, e con parresia, qualsiasi sia stato il pontefice regnante, molti hanno anche pagato i loro prezzi. Non credere che questa ricrescita esponenziale del devozionismo al centro come alle periferie della chiesa a me, biblista, faccia piacere. Sappiamo bene però che i fronti su cui schierarsi sono tanti perché la crisi è sistemica. E per di più in un mondo che brucia. Ho rotto il silenzio: vorrei dirti di più, ma il lavoro, anche quello teologico, mi richiama all’ordine.
Con la stima e l’amicizia di sempre.
Cara Marinella, figurati se attribuisco a te un peccato di omissione! Omettono gravemente coloro che sono, diremmo per specializzazione e spesso anche per mestiere, tenuti a scrivere sul tema di cui ho scritto. Anche tu, che sei teologa in senso pieno e vero, rispondi anzitutto sul piano biblico e degli studi di genere. Su questi temi, se ci fosse cardinali che straparlano, sicuramente tu non taceresti come mai hai taciuto. La questione è invece legata strettamente ai colleghi liturgisti. Ti ricorderai, al tempo del Covid, quando proposi la lettera aperta contro Summorum Pontificum, molti teologi sottoscrissero la lettera, ma i liturgisti che lo fecero furono quasi tutti stranieri. I liturgisti italiani sono spesso pieni di paura. Ogni questione ha ovviamente i suoi limiti. E sono il primo a riconoscere che solo la difesa della riforma liturgica lascia il tempo che trova. Ma per impegnarsi in altro non si deve permettere a nessuno di dire stupidaggini con la pretesa di essere autorevole. Su questo, mi pare, mi attenderei che gli “specialisti” non facessero i pesci in barile. Cara Marinella, ti ringrazio per la reazione e, come vedi, sei tra le poche e i pochi che si sentono chiamati in causa. Questo è l’atteggiamento che non funziona più: chiedere al papa di provvedere…ma per molti resta l’unico esercizio di libertà possibile.
Perché tacciono? Perché aspettano. Il vento è instabile, come certe cattedre.
Buongiorno Andrea,
Ti scrivo perché, anche se probabilmente non pubblicherai il testo, almeno potresti leggerlo.
Come ben sai, dopo il Messale del 1570, diverse famiglie religiose e anche diocesi i cui libri liturgici avevano più di 200 anni di antichità decisero di mantenere i propri “usi” o “forme” senza adottare il Messale Romano detto di Pio V.
Cioè, per secoli è esistito un rito romano con diversi usi religiosi e diocesani. Così è stato fino al Concilio Vaticano II.
Attualmente possiamo trovare all’interno del rito romano usi e forme diverse, come il rito romano per le diocesi dello Zaire, le celebrazioni “ad experimentum” ma esistenti delle comunità neocatecumenali, il rito di Braga, gli usi di alcune famiglie religiose…
Pertanto, affermare che nella storia non ci siano mai stati usi o forme all’interno dell’unico rito romano è puro positivismo giuridico.
Esiste un’unica lex orandi, ma all’interno di essa possono esistere diversi usi o forme, come dimostra la storia.
Mettere in parallelo le due forme, i due libri liturgici, dimostra proprio che l’Eucaristia, il matrimonio, l’Ordine sacro, ecc., presenti in entrambi i libri liturgici, sono gli stessi.
Non è ammissibile pensare che per secoli lo Spirito Santo abbia permesso che celebrassimo i sacramenti in modo deficitario o erroneo. Se la liturgia attuale è ciò che è, quella precedente non può non esserlo. Lo Spirito Santo non abbandona la sua Chiesa. Non va in vacanza.
Possono esserci sensibilità diverse, accenti diversi, pastorali diverse, ma entrambi i modi di celebrare, proprio perché sono liturgia, sono santi e ortodossi. Finché continueremo a sostenere che ci siano libri migliori di altri, dal punto di vista strettamente liturgico e teologico (diverso può essere dal punto di vista pastorale), non raggiungeremo mai la pace liturgica.
Dovrebbe farci riflettere questo distacco verso la liturgia riformata da parte di tanti cattolici che celebrano con la forma precedente, di tanti che soffrono in silenzio gli abusi dell’attuale, o che la celebrano senza affetto o interesse particolare.
A mio parere, è un segno che, dopo più di 60 anni dalla riforma liturgica, c’è ancora molto da fare.
Caro José, ho scritto che altre forme del rito latino, o anche romano, hanno sempre una ragione o personale o locale. Non è mai esistita una forma parallela e universale del rito romano affidata alla opzione di ogni comunità nell’universo mondo. Questo non è positivismo, ma buon senso. Grazie per la tua osservazione, anche se non sono d’accordo sul piano sistematico.
Perché gli altri tacciono (cardinali ma anche Vescovi, preti seminaristi e laici attivi nelle parrocchie)?
Per paura: credo che nessuno meglio di lei conosca come una mano vindice possa abbattersi in molte diocesi del mondo su chi mostra simpatie ‘tradizionali’, figuriamoci se vetusordiste). Con Ratzinger almeno i vescovi erano esentati, ma tutti gli altri no… Dopo sono stati colpiti anche i Vescovi (magari anche solo con la non promozione alla porpora). Sarà giusto o sbagliato sterminare anche solo moralmente i tradizionalisti, ma è quello che accade, e quello che fa si che solo pochi (e tendenzialmente chi ha poco da perdere, come il Bagnasco che si scopre filo-rito antico senza mai esserlo stato quando governava Genova) si espongano. Aggiungo, è con il voto anche di questi cardinali che Leone è stato eletto: magari è una persona leale che ha esposto un programma e che si sente tenuto a rispettarlo.