Mancuso sulla identità ebraica: non concordo con lui, ma lo difendo
Anche se si conosce più o meno accuratamente il pensiero di Vito Mancuso, si sarà notato come, dopo il suo articolo del 13 luglio su “La Stampa”, siano sorte molte critiche che tendono ad affermare due cose: la vicinanza delle sue tesi sull’israelismo all’antigiudaismo e addirittura all’ antisemitismo cristiano classico e la clamorosa smentita del cammino di avvicinamento iniziato con Nostra Aetate tra cattolicesimo e tradizione ebraica.
Di qui, in aggiunta a questi rilievi, viene avanzata da alcuni rappresentanti del mondo ebraico la richiesta di chiarire se questa posizione sia condivisa dagli altri teologi cattolici.
Già diverse volte mi è capitato di discutere con Mancuso e anche in questo caso vedo i limiti della sua lettura. Tuttavia vorrei anche suggerire un modo più ampio di concepire questa critica: ciò che Mancuso dice dell’ebraismo vale per lui anche per Islam e per il Cristianesimo. Se si legge l’articolo del 13 luglio in modo veramente contestuale, non si deve trascurare quella piccola parentesi in cui egli ammette che ogni religione ha il suo lato oscuro e che pertanto ogni forma storica di fede sia in qualche modo un tradimento della originaria vocazione spirituale (ebraica, cristiana e musulmana). Quella piccola parentesi, in cui Mancuso ammette questa critica generale contro tutte le religioni, è decisiva per intendere davvero quella che, a mio avviso, è la sua vera intenzione, che non ha nulla di “antigiudaico” né di “antisemita”. Ovviamente il tema della identità ebraica, molto più di quello della identità cristiana o islamica, ha ricevuto una attenzione più grande ed è quindi anche comprensibile che soprattutto in rapporto all’ebraismo – anche a causa delle contingenze belliche in corso e delle emozioni ad essa legate – il suo ragionamento abbia potuto apparire come segnato da una ostilità specifica verso la tradizione giudaica.
Tuttavia, nonostante questo, l’ occasione del dibattito resta ben fondata se si legge il testo di Mancuso non come il discorso che da fuori un teologo e filosofo impone ad una realtà a lui esterna, ma piuttosto come parte del travaglio che la stessa identità ebraica, dopo la rivoluzione francese, dopo la graduale chiusura dei ghetti, ha dovuto affrontare per impostare il rapporto con un mondo nuovo.
Un dibattito di 110 anni fa
Vito Mancuso, introducendo una radicale distinzione tra ebraismo spirituale ed israelismo politico, tra sapienza di servizio e potere di nazione, radicalizza una lettura liberale (che egli applica ad ogni religione). Non bisogna dimenticare, tuttavia, che questa è stata una delle vie con cui l ‘ebraismo ha pensato se stesso nel XIX secolo. Non senza discussioni anche molto accese. Vorrei ricordare in particolare il drammatico carteggio che nel 1916 si è tenuto tra Hermann Cohen (liberale antisionista) e Martin Buber (sionista e spirituale). Che cosa significa essere ebrei per questi due grandi intellettuali tedeschi?
Per capirlo, parto da una delle risposte date a Mancuso da parte di uno dei suoi critici, che ha usato un argomento apparentemente decisivo: “Mancuso non contesta ai francesi di essere francesi, agli italiani di essere italiani…ma agli ebrei l’essere nazione è rinfacciato come un peccato originale, indissociabile da una violenza istituzionale” (Rav. Di Segni). Si tratta di un semplice esempio, che utilizza la parola “nazione” e rivela fino in fondo la profondità della questione ebraica: essere ebrei non è come essere italiani o francesi. Tanto è vero che ci sono stati e ci sono ebrei italiani, francesi, tedeschi… La identità nazionale non si identifica con la identità ebraica né l’ebraismo con una identità nazionale (almeno nel senso che diamo alla parola dal XIX secolo. Questo è il cuore della cosiddetta questione ebraica. Dopo la rivoluzione francese, in effetti, nasce una questione nuova. La chiusura dei ghetti – nella sua novità epocale – dona libertà ai cittadini ma sottrae la identità alla rilevanza della fede. Chi è l’ ebreo in Europa dopo la Rivoluzione Francese? Emancipazione da ogni chiusura e resistenza nella logica del ghetto sono possibilità e tentazioni compresenti. Hermann Cohen è il campione della emancipazione. Essere ebrei significa per lui obbedire a tutte le leggi del Reich. Martin Buber è il campione della resistenza. Essere ebrei per lui significa uscire dalla Germania e dalla Europa e fondare in Palestina uno stato senza confini e senza esercito. Le due opzioni sono interne all’ebraismo. Anche il liberalismo di Mancuso mi pare una possibilità interna all’ebraismo dell’ultimo secolo: forse con l’utilizzo di categorie particolarmente nette, ma senza alcuna intenzione ostile o offensiva.
Cittadinanza e fede: una questione aperta
La questione che resta aperta è la funzione che esercita la fede per la identità ebraica (e cristiana e islamica e in generale religiosa). Mancuso tende a ridurre a zero il valore della fede. E lo fa non solo per l’ebraismo, ma per ogni tradizione credente. Eppure ogni tradizione religiosa, se risolta in principi della coscienza, rischia la irrilevanza. Questo è il rischio che corre l’ebraismo interpretato da Mancuso, ma lo stesso fenomeno di riduzione accade anche a una non secondaria tradizione ebraica, che ha elaborato, tra le altre, una versione del sionismo in cui conta solo il popolo e la terra, mentre Dio resta solo come sfondo morale. Anche uno dei romanzi recenti più preziosi per capire la identità ebraica moderna, Il Signor Mani, di A. Yehoshua, permane in una certa tensione con la teoria puramente liberale del suo autore. Il quale ritiene che la identificazione dell’ebreo (per lui finalmente) non debba più dipendere da fattori esterni (dalla fede della madre, dalla tradizione, dalla legge) ma dal semplice fatto di autodefinirsi ebreo: il fondamento è la dichiarazione “io sono ebreo”. Una identità autoreferenziale, però, non è mai una soluzione duratura. Neppure al problema del popolo e della nazione questa teoria immediata sembra dare risposte di peso.
In conclusione, la provocazione di Mancuso merita certo di essere criticata. Ma non perché fraintende la identità ebraica, bensì perché applica anche alla tradizione ebraica un principio di irrilevanza della fede, che riduce la alterità alla coscienza. Questo non è un problema solo per gli ebrei, ma per tutti i cittadini che non vogliano relegare la fede o tra i soprammobili di famiglia o tra le armi non convenzionali. In un mondo, nel quale il cittadino è pensato come portatore diritti e doveri indipendentemente da ogni credo religioso, una identità che contiene in sé un atto di fede costituisce una provocazione anche per il pensiero, oltre che per la identità di ogni uomo e ogni donna. Non importa se possiamo riconoscere “due tipi di fede” nella tradizione europea, secondo la nota espressione di Martin Buber. Quello che il testo di Mancuso sollecita ad affrontare criticamente è il senso per cui la fede può e deve essere considerata come un elemento strutturale della identità del cittadino. Una fede ebraica e una fede cristiana, in uno stile di reciproca comprensione e implicazione, permettono di uscire tanto da riduzioni liberali, quanto da riduzioni fondamentalistiche. Forse a questo aspira anche Mancuso, pur non cogliendo i gravi limiti di una troppo facile ricostruzione liberale della identità ebraica.































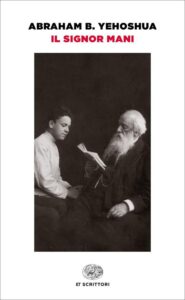
 Area personale
Area personale











