La liturgia ridotta (male). Le proposizioni sinodali italiane come occasione perduta?
Poiché oggi inizia la fase conclusiva del Cammino sinodale della Chiesa italiana, che lavora sulle “50 proposizioni” presentate nel pomeriggio ai delegati, è giusto cogliere l’ occasione per intervenire sui testi proposti, che mostrano alcuni tratti negativi rispetto ai testi che a novembre erano stati discussi nella Assemblea nazionale. Come avevo fatto allora (rimando al testo pubblicato su questo blog), mi limito ad esaminare i testi che riguardano la dimensione liturgica della vita ecclesiale, su cui capisco qualcosa di più, cercando di portare alla luce alcuni limiti vistosi, che per certi versi peggiorano le affermazioni che si erano potute leggere nei Lineamenti [= L] di novembre, senza tener conto del dibattito sollecitato dallo Strumento di lavoro (a partire dal dicembre scorso). Per offrire al lettore un materiale utilizzabile nel dibattito che da oggi pomeriggio si svolgerà fino al 3 aprile, recupero brevemente le asserzioni che abbiamo trovato 4 mesi fa, nel testo preparatorio (§. 1). Dopo un rapido cenno allo Strumento di lavoro (§.2) propongo un confronto con i testi delle proposizioni attuali, che parlano di liturgia (§.3), per concludere con alcuni auspici, almeno allo scopo di emendare e correggere le sviste più gravi (§.4) secondo ciò che risulta dal dettato problematico di alcune proposizioni.
1. I testi dei “Lineamenti” sulla liturgia
Per cominciare, presento i testi più rilevanti dei Lineamenti dï circa 4 mesi fa:
a) E’ anzitutto importante richiamare L 21-22. Da un lato, infatti, al n.21 si dice che la Chiesa “può anche cambiare linguaggio”, ma questo viene riferito al bisogno di un linguaggio “meno iniziatico”, in tensione con L 22, dedicato interamente alla liturgia, dove si chiede, inevitabilmente, di rimediare al “divario” tra liturgia e vita mediante “seri cammini di iniziazione all’ordine simbolico”. Da un lato, dunque, si chiedeva meno iniziazione, e dall’altra maggiore iniaziazione. La provocazione si rifletteva sulla soluzione offerta, che restava incerta: da un lato non si deve nulla alterare del rito, dall’altro occorre far entrare la vita della azione rituale.
b) Il punto di arrivo del discorso nell’ambito delle proposte operative (cfr. L 25), appariva piuttosto faticoso e poco istruttivo. Lo riporto integralmente:
Curare la qualità celebrativa e la efficacia comunicativa delle liturgie, a partire dalle omelie, attraverso iniziative di sostegno e formazione per le diverse ministerialità liturgiche, al fine di attivare la partecipazione dei laici e di avvicinare la liturgia alla vita delle persone, in particolare a quelle con maggiori difficoltà dovute a disabilità fisiche o psicologiche, cultura differente, età, situazioni di vita; è necessario inoltre, in collaborazione con la catechesi, favorire processi di iniziazione liturgica per aiutare i fedeli a porre e a comprendere il linguaggio liturgico.
Si sovrapponevano quattro registri diversi, senza coordinamento: efficacia comunicativa, ministerialità, cura per le persone in difficoltà e iniziazione liturgica sul piano della catechesi. Come proposta operativa appariva disorientata e disorientante, priva di un centro unificante.
c) L. 27, di fronte alla constatazione che in sequenza battesimo, prima comunione e cresima, non riescivano più a iniziare, ma erano diventati “riti di congedo temporaneo”, talvolta illimitato, deduceva di dover passare da una proposta “prevalentemente dottrinale” ad una proposta “integrale”. La integralità veniva collocata nell’orizzonte del “sommario” con cui At 2,42 descrive la chiesa primitiva: ascolto dell’insegnamento degli apostoli, comunione, frazione del pane e preghiera.
Importante è la ammissione che si trova nel cuore di L 27:
«Non si partecipa ai sacramenti perché si è giunti alla piena conoscenza del mistero, ma si cresce nella fede partecipando ai sacramenti»
d) Nel suo svolgimento, tuttavia, questo riferimento ai 4 ambiti della vita ecclesiale veniva svolto con alcune precisazioni non irrilevanti:
– primo luogo di formazione è l’ascolto della Parola di Dio
– secondo luogo è la cura per gli altri
– terzo luogo è la pratica dei sacramenti (dove viene messo in luce il valore formativo della pratica)
– quarto luogo la preghiera, soprattutto intesa come “interiorità”.
e) L 28 diceva apertamente come la iniziazione non riguardasse soltanto i “percorsi di catechesi”, ma implicasse una conversione pastorale di tutta la comunità. Per far questo veniva proposto un elenco di “metodi” (linguaggi, gioco, arte, via pulchritudinis, sport, visite a luoghi o persone…). Il ritmo poteva avvalersi forse più della scansione dell’anno liturgico che dell’anno scolastico. Ma l’anno liturgico era letto piuttosto in relazione alle soglie esistenziali (speranza, sacrificio, sofferenza, dono…).
f) La revisione dei cammini ai sacramenti e del percorso di iniziazione cristiana (L 29) era collocata in un orizzonte ampio di ripensamento della Chiesa come “grembo generativo”: non piccoli ritocchi, ma rilettura del rapporto tra crescita, sacramenti e vita.
g) Il modello “catecumenale” (L 30-32) era presentato nei termini di un “ricominciare”, non come segno di ogni inizio. In un certo senso si applicava solo a casi particolari (fidanzati, genitori, coppie in condizioni irregolari o soggetti vulnerabili).
h) Stile spirituale era obiettivo condiviso, soprattutto per uscire dalla “amministrazione burocratica” e guadagnare la forma della “famiglia accogliente”.
i) Un rilievo particolare, nell’ambito di tutti i sacramenti, sembrava assumere il sacramento della Riconciliazione (L 36), di cui si rilevava la necessità di una accurata riconsiderazione, anche studiando un accesso più ampio alla “seconda” e “terza forma” del rituale.
2. Il passaggio rimosso attraverso lo Strumento di lavoro
Bisogna comunque ricordare che il lavoro che ha portato alla stesura delle Proposizioni è passato, almeno nominalmente, attraverso la elaborazione dello Strumento di Lavoro, pubblicato a fine dicembre 2024. Va detto che tutte le riaperture contenute nel testo di dicembre, rispetto a L, non sembrano aver inciso sulla formulazione delle proposizioni, almeno per quanto riguarda il discorso liturgico e sacramentale. Che cosa sia rimasto, nelle proposizioni finali, di questa “fase profetica” degli ultimi 4 mesi, è difficile dire. Resta la impressione, che ora cercherò di documentare, che le proposizioni rimangano, comunque, largamente indietro rispetto al testo dei Lineamenti.
3. La liturgia nelle Proposizioni 2025.
Che cosa resta di tutto il lavoro proposto dal percorso compiuto nelle proposizioni oggi elaborate? Bisogna dire: molto poco. Se già nei L, accanto ad un insistito richiamo alla “riforma della Chiesa” mancava un richiamo chiaro alla riforma liturgica, anche se alcuni riferimenti alla liturgia erano chiaramente segnati da quella esperienza, nei testi delle proposizioni di oggi, nonostante il possibile apporto del confronto con lo Strumento di Lavoro, il riferimento alla liturgia e ai sacramenti appare minore, secondario e per certi versi messo come al riparo dalla coscienza maturata negli ultimi 60 anni di prassi ecclesiale. Esamino i riferimenti che si trovano all’interno delle 50 proposizioni, facendoli seguire da brevi commenti:
Proposizione 10
Presidenza della liturgia e omelia
Si rilanci la formazione all’“ars celebrandi” e alla presidenza della liturgia,
per i presbiteri e i diaconi, soprattutto in merito all’omelia. La Conferenza
Episcopale Italiana stabilisca circostanze e casi in cui ammettere i laici
alla presidenza di celebrazioni non eucaristiche e alla predicazione in una
chiesa o in un oratorio (cf. CIC, can. 766).
La questione della presidenza non può assorbire integralmente la questione della “ars celebrandi”. Uno dei dati nuovi e decisivi, scaturiti dal Vaticano II, è che tra celebrare e presiedere vi è una differenza essenziale: tutti celebrano e uno solo presiede. Per questo la questione della “ars celebrandi” riguarda anzitutto tutta la assemblea. C’è poi una “ars presidendi” che può essere sviluppata in modo particolare e giustamente può anche riguardare soggetti laici, uomini e donne. Ma qui sarebbe fondamentale recuperare, come “cambio di paradigma”, la consapevolezza che il celebrare chiede una arte della assemblea. Una espressione infelice, quella della proposizione 10, che induce a confondere “celebrare” con “presiedere” e che dovrebbe essere corretta.
Proposizione 11
Revisione nazionale dei testi liturgici
Sia predisposta a livello nazionale una revisione dei formulari e dei canti
liturgici, interrogandosi sulla loro efficacia comunicativa, in dialogo con i
giovani, per rendere più comprensibili e pregne di significato per l’oggi le
forme della liturgia, tenendo assieme e facendo dialogare diverse competenze
di carattere educativo, catechistico, artistico e di comunicazione.
La revisione di quelli che vengono chiamati “formulari e canti liturgici” è un processo complesso, che può avere certo anche i giovani come obiettivo, ma che non può essere inteso soltanto come “traduzione comunicativa” di contenuti acquisiti. La questione è più ampia e chiede necessariamente anche competenze bibliche, teologiche e liturgiche, che siano disposte a pensare la lingua italiana non soltanto come “strumento di traduzione del latino”. Qui il ritardo sconta una arretratezza che si è ancora usata con disinvoltura per comporre la traduzione vigente del Messale Romano. I formulari sono ostici perché si è voluto che fossero così. Una giusta “revisione dei testi liturgici” ha anzitutto radice biblica, teologica e liturgica. Senza questo sfondo si rischia di introdurre nel testo forzature senza fondamento, maturate da evidenze pedagogiche o antropologiche che rischiano di restare estrinseche rispetto ai ritus e alle preces
Proposizione 12
Celebrazione dei passaggi dell’Iniziazione cristiana
Nelle Diocesi e nelle Parrocchie siano valorizzati i momenti celebrativi nei
percorsi di Iniziazione cristiana, cogliendo le opportunità offerte dal Benedizionale,
per dare maggiore importanza ai passaggi e alle situazioni
particolari di vita.
La relazione tra iniziazione cristiana, sua natura di percorso, e utilizzo del Benedizionale sembra una forzatura rispetto alle forme iniziatiche, che la tradizione ecclesiale ha elaborato lungo la storia. Il rito della iniziazione cristiana degli adulti offre tutte le forme che, mutatis mutandis, possono entrare nella esperienza delle Diocesi e delle Parrocchie. Il ricorso al Benedizionale, certo possibile, non sembra rispondere ad una esigenza autentica e condivisa. Assume la funzione di una “divagazione” rispetto alla iniziazione, che ha già in sé la sua forza, senza che la dobbiamo cercare nel libro delle Benedizioni.
A queste tre proposizioni si aggiungono poi la n.13 e la n. 14, dedicate rispettivamente ai “gruppi liturgici” e alla “pietà popolare”, di cui si chiede la valorizzazione in modo piuttosto generico, ma utilizzando solo per la pietà popolare la qualità di “esperienza spirituale”.
Nella parte del testo dedicata alla “formazione”, il tema liturgico appare sviluppato in particolare nelle seguenti proposizioni:
Proposizione 27
Percorso nazionale rinnovato di Iniziazione cristiana
L’Assemblea sinodale chiede un rinnovo degli strumenti a supporto dei
percorsi di Iniziazione cristiana per le diverse età, adottando un modello
che integra la dimensione catechistica con le altre dimensioni essenziali
dell’esperienza cristiana (cf. At 2,42): celebrativa, caritativa e orante.
L’Assemblea chiede di offrire in una piattaforma nazionale le coordinate
fondamentali entro le quali le Diocesi e le Regioni ecclesiastiche, possano
integrare proposte (luoghi di spiritualità, arte, testimoni e santi…) e far
conoscere le “pratiche virtuose” in via di sperimentazione.
Il rinnovamento della iniziazione cristiana viene identificato semplicemente nel superamento del modello catechistico, da parte di un “modello integrale”, ispirato da At 2,42, ma il cui profilo non è affatto delineato, ma semplicemente rimandato ad una “piattaforma nazionale” con la identificazione di “coordinate fondamentali” di cui nulla è detto.
Proposizione 28
Potenzialità dell’Anno liturgico per l’Iniziazione cristiana
Molte Diocesi auspicano che le proposte di Iniziazione cristiana, specialmente
dei bambini e dei ragazzi, siano ritmate sull’Anno liturgico più che
sull’Anno scolastico, in modo da approfondire esperienzialmente le potenzialità
racchiuse nei suoi diversi periodi, che si intrecciano con aspetti
fondamentali dell’esistenza umana e cristiana, quali: speranza, nascita,
corpo e affetti, dolore e morte, vita eterna, spiritualità, comunità.
Anche il tono descrittivo non aiuta la proposizione ad assumere autorità. L’auspicio di molte diocesi ad usare il ritmo dell’anno liturgico, al posto del ritmo dell’anno scolastico, non sembra uscire da un generico riferimento di calendario, piuttosto che di “percorso”.
Nella stessa linea si muovono le due proposizioni che mettono più esplicitamente a tema la struttura stessa del percorso di iniziazione. Soprattutto la prima (P 29) appare un testo non soltanto “vuoto”, ma male organizzato al suo interno. Eccone il tenore con un breve commento:
Proposizione 29
Indicazioni nazionali circa aspetti specifici dell’Iniziazione cristiana
L’Assemblea chiede che siano date indicazioni nazionali circa la figura dei
padrini e delle madrine, la successione della celebrazione dei sacramenti
dell’Iniziazione cristiana e della Riconciliazione e l’età del conferimento
della Confermazione nell’itinerario dei ragazzi.
La prima osservazione è questa: sembra che la Assemblea risulti priva di autorità. In una proposizione sinodale si chiede che vengano date indicazioni nazionali. E lo si fa con un “ordine” interno alla domanda che tradisce una certa fretta, con cui si sono messe insieme cose di natura e di valore molto diverso. Da un lato, infatti, si pone la questione decisiva dell’ordine dei sacramenti della iniziazione cristiana (battesimo, cresima e eucaristia) in rapporto al sacramento di guarigione (penitenza). Di natura diversa e di altro valore sono la questione dei padrini/madrine e la questione della età della cresima. Sarebbe del tutto urgente distinguere accuratamente le questioni, restituendo a ciò che è prioritario la funzione di orientare tutto il resto. Un testo di un sinodo nazionale non può parlare in modo tanto confuso, alimentando il disorientamento.
Proposizione 30
Servizio diocesano per il Catecumenato
Le Diocesi si dotino, dove non fosse presente, del Servizio per il Catecumenato,
aperto non solo agli adulti che desiderano intraprendere il cammino
dell’Iniziazione cristiana a partire dal Battesimo, ma anche a quelli
che, pur battezzati e magari cresimati, riscoprono la fede dopo tempi di
abbandono (i cosiddetti “ricomincianti”), per i quali si richiede un “secondo
annuncio”, che innesti la Parola di Dio nelle loro situazioni e scelte di
vita. Le persone del Servizio per il Catecumenato, che accompagnano
questi fratelli e sorelle, devono essere adeguatamente formate.
Anche qui, il richiamo ad una visione ampia del Servizio per il Catecumenato non sviluppa altra questione rispetto al ruolo della Parola di Dio, lasciando da parte il valore di una iniziazione liturgica alla fede, che non sembra rilevante, almeno dalla formulazione della proposizione. Di tutto il dibattito attestato dai documenti precedenti non resta pietra su pietra.
Oltre alle proposizioni che stabiliscono un ampliamento della esperienza ministerale, sia configurando un nuovo ministero istituito (P 41), sia ampliando il ricorso al servizio ministeriale delle donne (P 43) , si utilizza addirittura una proposizione in vista di una “semplificazione burocratica” al riguardo dei sacramenti:
Proposizione 44
Certificazioni per i Sacramenti o per le condizioni di vita
Allo scopo di alleggerire il peso delle guide della comunità e liberare
energie per l’evangelizzazione e la prossimità, si valuti di snellire o eliminare
dove possibile le procedure per le certificazioni e autocertificazioni
in merito ai Sacramenti o alle condizioni di vita personali per accedervi o
accompagnarli (come padrino/madrina).
Una intera proposizione dedicata ad una questione così secondaria non parla a favore di un vero equilibrio nelle priorità offerte dal testo.
4. Uno sguardo complessivo
La lettura delle 50 proposizioni, come espressione di un cammino che è durato ben 4 anni, lascia una profonda sensazione di occasione mancata. La considerazione del tema “liturgia” mostra una serie di rinunce, progressive, che nelle 50 proposizioni mostrano una comprensione marginale, riduttiva e parziale della tradizione. Provo ad esprimere meglio questa impressione in alcune conclusioni generali, in vista di una rettifica ancora possibile.
4.1. Senza autorità
Se un Sinodo non perviene a proposizioni autorevoli, non svolge la funzione per cui è stato concepito. E’ vero che il difetto sta alla radice – il percorso sinodale non è un Sinodo in senso stretto – ma il tenore delle proposizioni non manifesta in alcun modo la tensione verso un “cambio di paradigma”. Per farlo occorre che le parole che mediano le proposizioni siano all’altezza del compito: nel tono e nel linguaggio. Non si scrivono proposizioni di un Sinodo come si scrive un regolamento di condominio.
4.2. Liturgia clericale e semplicemente “da tradurre”
Se la comprensione dell’ars celebrandi è riferita semplicemente ai presbiteri e diaconi, come se fosse una cosa ovvia, questo costituisce una involuzione non solo rispetto al Concilio Vaticano II, ma anche rispetto a Sacramentum Caritatis (2007, nn. 38-40). Da un lato occorre riprendere, secondo quanto indicato chiaramente da Desiderio desideravi, la vocazione di tutto il popolo di Dio a celebrare. D’altra parte, bisogna riconoscere che le questioni che riguardano il “linguaggio” non si riferiscono semplicemente ad una “mediazione linguistica” in favore dei giovani, ma al modo stesso con cui l’azione rituale viene compresa in un ambito linguistico diverso da quello latino. Su questo non è sufficiente un “ufficio” che cerchi di rendere appetibile ai giovani un testo tradotto male dagli adulti. Un Sinodo non è il luogo in cui si raccontano favolette rassicuranti.
4.3. Una iniziazione disorientata
Sul piano della iniziazione cristiana, sembra evidente una mancanza di chiarezza circa la logica iniziatica dei sacramenti. Sembra che la “pratica dei sacramenti” sia, come tale, in grado di offrire la formazione adeguata ai soggetti e che la Assemblea, nelle sue proposizioni, non possa far altro che chiedere agli “uffici ecclesiali” di provvedere sia a criteri fondamentali, sia a sbrogliare la matassa delle questioni cosiddette “specifiche” in cui, con una confusione deleteria, di mette tutto, senza ordine e senza orientamento. Questo è forse l’aspetto più grave che emerge dalle proposizioni sul tema liturgico: la totale mancanza di un orientamento iniziatico davvero affidato alla azione rituale.
4.4. Tendenza amministrativistica circa il governo della Chiesa
Infine, sul piano della considerazione del coinvolgimento dei laici e in particolare delle donne nel governo della Chiesa, le proposizioni di fatto si allineano su una scelta che resta assai discutibile. Da un lato escludono la tematizzazione del diaconato femminile, come già avevano anticipato i Lineamenti (ma come lo Strumento di Lavoro non aveva fatto, almeno citando il testo finale del Sinodo universale sul tema). Dall’altro sembrano seguire, alla proposizione 43, la linea di una promozione delle donne, in ruoli di autorità all’interno delle curie, senza minimamente affrontare la relazione, di per sé inaggirabile, tra questa autorità di governo e l’autorità sulla parola e sui sacramenti. La triade regale, sacerdotale e profetica, con cui da 60 anni cerchiamo di dire la partecipazione al potere nella Chiesa cattolica, non si lascia trattare con disinvoltura entro categorie medievali, neppure nella sede di un sinodo. Se i problemi vengono affrontati formalisticamente, ricevono una soluzione altrettanto formalistica. Se oggi pensiamo di risolvere solo con la giurisdizione ciò che non riusciamo a pensare come “ordine”, restiamo al di qua di ciò che ci chiede la nostra epoca. Questo cambiamento di epoca non si lascia anestetizzare parlando la lingua dei medievali. Magari avendo poi il problema di spiegarla ai giovani…
Conclusione
Non è troppo tardi. Se le proposizioni che riguardano l’azione rituale saranno espresse nel linguaggio migliore che abbiamo saputo sviluppare dal 1963 ad oggi, troveranno il loro spazio per incidere sul corpo delle Chiesa che sono in Italia. Per fare questo c’è ancora tempo e si deve lavorare con linguaggi più intensi e con toni più adeguati. Altrimenti, se i testi conserveranno questo tratto un poco anaffettivo, maturato in un linguaggio tipico della rassicurazione burocratica, diventeranno soltanto il documento di una occasione mancata, del prevalere di un approccio amministrativo alla liturgia e ai sacramenti, e di una scarsa coscienza del valore decisivo che il linguaggio rituale ha non solo per i giovani, ma per tutti i discepoli di Cristo. Un intervento robusto ed efficace, sul testo delle proposizioni che ho segnalato, potrebbe ancora permettere al Cammino sinodale di dire cose non scontate e di evitare di utilizzare – come se fosse un destino ineluttabile e falsamente rassicurante – soltanto categorie vecchie, incomprese o compromesse. Ad un cambiamento d’epoca non si può rispondere cambiando soltanto la targa dell’ufficio. E perché vi sia gioia non basta scrivere la parola sulla insegna dell’ufficio. Con le proposizioni oggi messe a disposizione, il titolo “Perché la gioia sia piena” suona piuttosto strano e ha un forte effetto straniante.































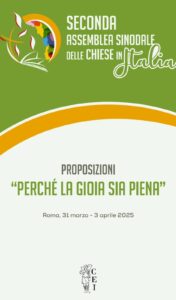
 Area personale
Area personale












Fosse solo questo il male, lo si potrebbe trasformare, come sostiene l’autore dell’articolo, perché si sarebbe ancora in tempo per farlo. Manca in realtà una formazione culturale di fondo, perché è inesistente attualmente nella Chiesa che è in Italia una ricezione del Vaticano II e c’è un ripiegamento narcisista sul banale, sull’apparente e sul successo immediato.
Buonasera Andrea. Trovo sintomatico della disattenzione e mancata distinzione tra celebrare e presiedere il fatto che persino i liturgisti ai convegni di liturgia usano normalmente il termine celebrante in luogo di presidente…
Verissimo. Anche i libri Liturgici usano questa espressione nelle rubriche, purtroppo.