Le parole e le persone: cura e vigilanza. Variazioni teologiche su un bel libro di Giovanni Grandi
Nelle ultime settimane ho letto ben tre libri, piccoli e preziosi, di Giovanni Grandi, di cui ho dato qualche conto su questo blog. Un libretto sulla “parola amica”, 8 lezioni di “etica pubblica” e ora questo “Virtuale è reale” che ha come sottotitolo “Aver cura delle parole per aver cura delle persone”. Il libretto non è altro che una limpida presentazione dei “dieci comandamenti” che si trovano nel “Manifesto per una comunicazione non ostile”. E mostra con buoni argomenti la delicatezza della “comunicazione virtuale” e dei suoi meccanismi rapidi, cui prestiamo una attenzione spesso scarsa e poco profonda. Ma il libretto è anche molto di più. E’ una pacata meditazione sulle “conseguenze delle parole”, sulla capacità di configurare, di istituire o di sfigurare e di distruggere che le parole hanno in sé. Leggendo le pagine del libro mi sono detto: la “non ostilità” non è il vero obiettivo del libro. Il vero scopo è la “responsibilità” nell’uso delle parole. E questo mi ha fatto subito pensare ad un “manifesto della comunicazione non ignava”. Ossia alla esigenza che la comunicazione pubblica, e anche ecclesiale, dica le cose, usi argomenti seri, dia parola all’esperienza, non si chiuda nelle mille forme in cui si parla di tutto ma si parla solo di sé o di nulla. Questo ha un valore alto anche nel mondo ecclesiale e in particolare nel mestiere “comunicativo” dei pastori e dei teologi. Proviamo a vedere dunque le “ricadute” di alcuni dei principi del Manifesto sul piano della comunicazione ecclesiale.
a) La cura per le parole
Anche se di recente, con obiettivi talora illustri, proprio i “social media” hanno visto degenerare anche il linguaggio intraecclesiale, con scambi di parole sguaiate, pesanti e irrispettose tra fedeli cattolici e nei confronti di singoli uomini di Chiesa, credo che per il linguaggio ecclesiale la maturazione di una “cura per le parole” debba assumere una evidenza nuova. Non si rende ragione della realtà citando solo il catechismo, così come non si rende giustizia alla chiesa investita dalla pandemia parlando solo con Decreti di carattere normativo. “Aver cura delle parole per aver cura delle persone” non significa anzitutto “non insultare”. Significa comprendere che le parole che scelgo, per dire una gioia o un dolore, per raccontare la storia o per confessare la fede, non sono mai scontate. E non sono mai soltanto “repertorio”. Una Chiesa che parlasse solo con “parole di repertorio” non avrebbe cura per le persone.
b) La giusta domanda di “parrhesia”
Per questo, come ci insegnano già i 10 comandamenti di Mosé, e in modo ancora più evidente anche le “10 parole” di questo libretto, un uso accurato delle parole non è fatto anzitutto dai divieti. Se osserviamo, in questo libro le “norme” sono quasi tutte “in positivo”. Pochissime sono le cose “vietate”. Perché la comunicazione, se è tale, non si cura semplicemente di “non offendere”, ma deve “dire la cosa”, senza tanti giri di parole. Questo si può fare con tutta la cortesia e il garbo, ma la comunicazione non serve soltanto per farsi i complimenti. Come accade nei “gruppi whatsapp” dove tutti, all’inizio, sono tentati di dirsi, a distanza, buon giorno, buon pranzo, buona notte…Occorre “parrhesia”, con tutta la umanità e la discrezione necessaria. Una Chiesa capace di parrhesia è messa a rischio di infrangere la “non ostilità”. L’arte da imparare, anche con fatica, è “dire la cosa”, anche quando è bruciante, senza offendere, senza sarcasmo, senza discredito. Ma la finezza, l’ironia e la oggettività permettono di essere franchi senza essere ostili. Di questo la Chiesa ha non solo la possibilità, ma la necessità.
c) Linguaggio tecnico e linguaggio comune
Un altro punto qualificante una comunicazione non solo “non ostile”, ma “vera” è la relazione complessa tra linguaggi tecnici e linguaggio comune. Non è facile, nemmeno nella Chiesa, assicurare una relazione profonda tra questi due livelli della comunicazione. Questo problema potrebbe avere una soluzione molto semplice: di certe cose, sui Social media, non si deve parlare. Io non credo che questa sia la soluzione. E’ possibile parlare anche delle cose più difficili, e più delicate, accettando le regole di un contesto diverso sia dalla omelia, sia dalla accademia, sia dal bar. Anche qui la responsabilità ecclesiale e teologica è alta: poter entrare in universi di discorso “altri”, senza pretendere che gli altri abbiamo la competenza richiesta, per spezzare il pane della tradizione. Questa è una sfida, alla quale non si può resistere semplicemente “restando a guardare”. Ma occorre anche imparare le regole del gioco e lavorarci dentro con creativa mobilità.
d) La vigilanza sulle parole
Infine, tra i compiti più alti del ministro cattolico per eccellenza, del Vescovo, c’è la “vigilanza sulle parole”. Questa terminologia viene facilmente fraintesa. Vigilare, in senso evangelico, significa non anzitutto temere che le parole ci vengano sottratte, rubate, sequestrate…ma che non siamo sorpresi dal Signore che viene nella sua parola. Vigilare sulle parole non è un atto “difensivo”, ma un “atto creativo”. Restituire alla Parola tutto il suo significato esige il nutrimento con l’esperienza. Così anche nello scambio sui Social Media possiamo “nutrire di esperienza” la fede e “vigilare” sulle parole. Non come vigili urbani pronti a “dare la multa”, ma come vergini sagge e come servi inutili, disponibili ad attendere con creatività e con responsabilità la sorpresa di colui che viene sempre come un ladro.































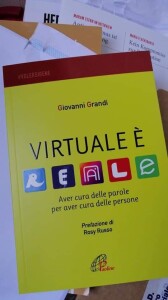
 Area personale
Area personale











