Nuova chiarezza da “Desiderio desideravi”: 10 proposizioni sulla riforma necessaria, ma non sufficiente
“Non possiamo tornare a quella forma rituale che i Padri conciliari, cum Petro e sub Petro, hanno sentito la necessità di riformare, approvando, sotto la guida dello Spirito e secondo la loro coscienza di pastori, i principi da cui è nata la riforma” (Desiderio Desideravi, 61).
Da tempo era necessario che una voce autorevole dicesse una parola chiara a proposito di un equivoco che il secolo XX ha creato intorno alla “questione liturgica”. Ciò che leggiamo in DD corrisponde bene a quanto era desiderabile ascoltare da alcuni decenni. Provo a presentarne qui la logica un una serie di 10 proposizioni, perché appaia a tutto tondo non solo il merito del testo, ma anche le conseguenze teologiche e astorali delle sue affermazioni:
1. La questione liturgica è sorta all’inizio del XIX secolo, quasi 200 anni fa. Da allora, nelle parole profetiche di A. Rosmini in Italia e di P. Guéranger in Francia si è manifestata la consapevolezza che la liturgia conosceva una crisi profonda, dalla quale occorreva uscire con nuove evidenze, nuove forme di vita, nuove pratiche. La crisi è riconosciuta negli anni 30 dell’800: non è quindi il frutto né del Vaticano II né del 68!
2. La nascita ufficiale del Movimento Liturgico è avvenuta, ai primi del XX secolo, proprio con questo duplice intento: la riscoperta della tradizione liturgica e il reinserimento della liturgia come “fonte” di vita cristiana e della esperienza spirituale. Fondamentale è stata la I guerra mondiale, che apriva una domanda nuova di interesse e di studio verso le pratiche rituali.
3. Almeno fino agli anni 50 del ‘900 la “formazione liturgica” è stata il centro della attenzione, rispetto ad un ruolo della “riforma”, in partenza piuttosto secondario, che però ha preso vigore in modo forte con le decisioni di Pio XII successive alla II guerra mondiale. Da allora la riflessione sulla “riforma” ha preso il sopravvento, grazie al Vaticano II e al lungo e dettagliato lavoro post-conciliare.
4. Questo passaggio, che potremmo definire “dal primato della formazione al primato della riforma”, è stato necessario e direi quasi fisiologico. Ma altrettanto naturalmente è accaduto che, dopo circa 40 anni di lavoro quasi totalmente volto alla realizzazione dei nuovi riti, nel periodo dal 1948 al 1988, tornasse a galla la questione più antica, ossia quella della formazione. Proprio su questa soglia finale del 1988 si sono collocati tre eventi simbolici di una trasformazione imprevedibile: la commemorazione dei 25 anni di SC (Vigesimus quintus annus), il primo rito inculturato (Messale romano per le diocesi dello Zaire) e lo scisma lefebvriano.
5. A partire da allora la questione liturgica aveva assunto sempre più la forma di una “progressiva attenuazione” della necessità della riforma. Alla domanda sulla “necessità della riforma liturgica” il magistero ha dato risposte differenziate, ma segnate da sempre maggiore cautela e ritrosia. Mentre si ribadiva formalmente la necessità della riforma, contemporaneamente la si rendeva sostanzialmente aggirabile, dispensabile, evitabile, scavalcabile, quasi a difesa della “libertà” di celebrare come se non vi fosse stato alcun Vaticano II.
6. Per più di 30 anni, rincuorati nel 2007 dal tenore del MP Summorum Pontificum, un certo numero di cattolici si sono (o sono stati) convinti della non necessità della riforma: in effetti quando un documento ufficiale asserisce che tutti i riti precedenti alla riforma possono essere usati anche dopo di essa, di fatto esso ridimensiona la portata e la evidenza di questa scelta conciliare. Permette di pensarsi cattolici indipendentemente dal Vaticano II e dalle sue conseguenze. Così si garantiva dall’alto una immunizzazione del cattolicesimo dal Vaticano II, che ha preso forme pesanti in diverse nazioni.
7. Ma, nonostante le apparenze, non è questo l’attacco più insidioso alla riforma liturgica. La riforma soffre molto di più non per la negazione sfrontata della sua necessità, ma per il fatto di essere giudicata “sufficiente”. In questo modo, infatti, si introduce una cesura nei confronti del movimento liturgico, che sapeva bene come, pur onorando il compito di riforma, il vero fine fosse la “formazione del popolo alla actuos participatio”. Con lucidità R. Guardini lo ha scritto dal 1918 al 1964: si tratta di “reimparare l’atto di culto”: questo sarebbe stato il vero scopo della riforma liturgica.
8. Così, accanto all’attacco alla riforma mediato dalla contestazione della sua necessità, vi è stato un altro attacco, molto meno evidente, ma molto più insidioso, che è consistito nel ritenere, ingenuamente o colpevolmente, che la riforma fosse sufficiente, in quanto tale, a risolvere la questione liturgica. Il primo attacco è venuto dai tradizionalisti (che avrebbero voluto negarne la necessità), mentre il secondo è venuto dai burocrati e dai funzionari (che si sono illusi e hanno illuso gli altri circa la sua sufficienza). D’altra parte la riforma è “atto centrale” controllabile, mentre la formazione da aggiungere ad essa è “atto decentrato” e molto più contingente.
9. Con Desiderio desideravi diventa chiaro che questo equivoco viene totalmente rimosso. Non si cade più nella trappola per cui la fatica e la lentezza della formazione diventa l’alibi per contestare la necessità della riforma. Con piena coscienza, e con grande lucidità, per DD l’unica lex orandi vigente diventa “testo e contesto normativo” per sviluppare la “via sperimentale” mediante cui l’azione rituale dà forma al soggetto ecclesiale. La riforma, con tutta la sua necessità, resta insufficiente se non diventa pratica rituale nuova, condivisa da tutto il popolo. La contingenza di questo passaggio esige una cura particolare, che non è solo “apologetica della riforma”, ma “contingente esperienza rituale”.
10. Se il dibattito uscirà dalle secche della disputa sulla “necessità della riforma” e permetterà una seria considerazione della sua “insufficienza” formativa, i nuovi riti potranno diventare mediazione linguistica della carne e sangue di Cristo e della Chiesa, cosa che potrà avvenire solo mediante una formazione liturgica alla partecipazione attiva di tutto il popolo di Dio nel contesto di una azione rituale riconosciuta come linguaggio comune, senza deleghe clericali a terzi. La prospettiva di SC si rispecchia ora in DD, ma con la nuova consapevolezza di una riforma riconosciuta ormai come necessaria e irreversibile, e tuttavia giudicata anche “non sufficiente” rispetto al compito primario della liturgia di costituire il “fons” e il “culmen” di tutta la azione della Chiesa. Una nuova liturgia che non riuscisse a diventare “fons comune” di tutta la Chiesa finirebbe prima o poi per veder messa in questione di nuovo la sua stessa necessità.































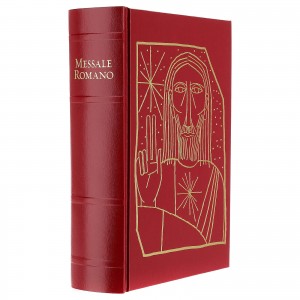
 Area personale
Area personale












Una questione decisiva:
https://gpcentofanti.altervista.org/un-inganno-di-certa-pastorale/
Rispetto ad una ricostruzione lineare lei fa valere illazioni. Giovanni xxiii non si può ridurre all’aurore di VS. Cosi come Bouyer resta un convertito dal luteranesimo, molto più rigido con la tradizione cattolica di qualsiasi cattolico. La teoria del complotto e la lettura del Consilium come rivoluzione è un mito. E continua a dimenticare che la crisi liturgica è dei primi del 800, non del 1969. Con questi criteri non si capisce se non il proprio pregiudizio
Caro professore, varie cose non funzionano nella sua risposta. Per lei gli argomenti contrari sono illazioni. Bouyer non vale nulla perché rigido ex pastore luterano (ma ciò che ha detto lui è stato detto da molti altri, tutti rigidi ex pastori luterani allora). L’ipotesi che il Consilium abbia esagerato non la sfiora, ma come spiega l’esilio in Iran di Bugnini? Infine lei dice che Roncalli non può essere ridotto alla VS. Già, ma l’ha scritta. E allora? Scegliamo fior da fiore? E infine fa ricorso ai pregiudizi. Che sarebbero solo i miei. Ha mai pensato ai suoi? O non ne ha? Beato lei, professore. Ma non pensi che io mi creda certe storielle.
Resti nei suoi pregiudizi. Ma non mi chieda di rinunciare ai miei giudizi
Se sono giudizi i suoi, sono giudizi anche i miei. Chi di pregiudizio ferisce, di pregiudizio perisce.
Caro Prof. Grillo,
che ne pensa della messa celebrata sul materassino?
Grazie!
Mi sono espresso su FB. Ecco:
A scanso di equivoci. Celebrare sul materassino in acqua è una scemenza senza giustificazioni
I laici che stanno zitti
Se un parroco mi avesse proposto di celebrare “sul materassino” io lo avrei mandato a farsi benedire. C è una responsabilità dei laici che non si sono rifiutati di partecipare a questa bella impresa.
Giusto,
Visto che si guarda con estremo orrore al ritorno del rito antico ma anche a quelle forme che metterebbero da parte la riforma vorrei chiedere proprio delle esemplificazioni. Dando per scontato che probabilmente a Lei, professor Grillo, viene l’orticaria a sentire un “Introibo ad altare Dei”, ci può fare proprio qualche esempio pratico di elementi che, a suo dire, vanno contro la riforma liturgica e riportano la Chiesa a pericolosi scismi? Sono veramente curioso. Esempi pratici, però.
Esempio facile facile. Il prete che dice Introib9…si rivolge ai fedeli solo 7 minuti dopo. Questo media l idea che la messa sia affar suo. Ahi ahi
Scusi , ma all’Introibo i fedeli non rispondono (rispondevano) Ad Deum qui laetificat iuventutem meam? Quindi il dialogo parte (partiva) da subito, mi pare; del resto la Messa era, ed è, prima di tutto, un dialogo con Dio, se non sbaglio. O sono rimasto indietro?